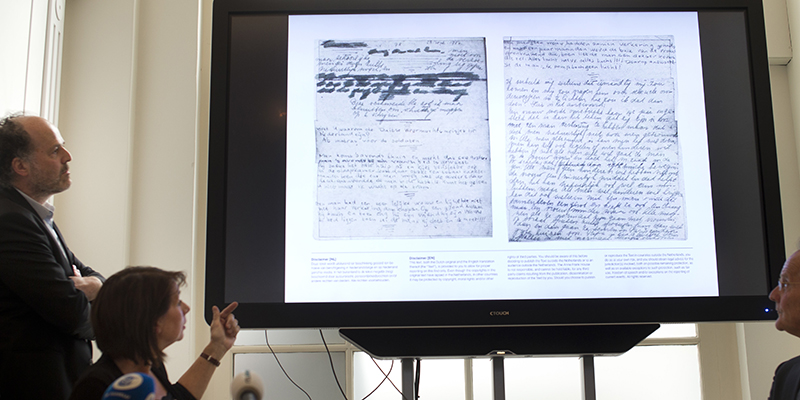La marmotta ipotetica dell’irrealtà
Tutto cominciò con un biglietto magico. Fu quello il suo lasciapassare per il paese delle meraviglie. Certo, non lo raggiunse subito, ci volle del tempo. Ma quel pezzo di carta per lui fu l’inizio. E il tempo poi, sì il tempo, nell’esistenza di Danny Rubin avrebbe sempre avuto un ruolo forse ancora più preponderante che per le nostre vite. Perché lui, anziché farselo scorrere sotto i piedi come un tapis roulant, ci avrebbe camminato sopra e, almeno per un po’, avrebbe avuto l’impressione di reggere il gioco. Persino di potere fermarlo. E non sarebbe stata una illusione da poco. Anche perché poi, guarda caso, il suo gioco sarebbe stato proprio il tempo. Un tempo incantato. Nel vero senso della parola.
D’altro canto questa è proprio una storia sul tempo. Anzi, sui tre tempi della sua vita. Quello del “prima”, quello per il quale sarà ricordato e quello del “dopo”, che, nonostante tutto, si rivelerà, a suo modo, ugualmente stupefacente.
Se volete ascoltarle, queste sono le sue tre storie.
Il primo tempo di Danny Rubin
Fu proprio facendo due calcoli sull’economia del suo tempo che Rubin scelse di laurearsi in biologia. Amava già il cinema ma pensò che sarebbe stato complicato arrivarci. Avrebbe fatto prima prendendo una laurea specifica. Magari dopo si sarebbe occupato di documentari scientifici. E poi si trattava di studiare proprio quella scienza che analizza la vita, quindi la nascita, l’evoluzione, l’estinzione. Insomma l’uomo rispetto al tempo. Dopo essersi laureato alla Brown University fece un master in radio, televisione e film alla Northwestern.
Pezzi di carta alla mano, iniziarono per lui i giorni delle infinite possibilità e delle incertezze dilaganti. Quelli in cui si ha il dovere di ballare sul tempo. Scoprì che la stazione televisiva pubblica WTTW (la sigla sta per “Window To The World”, Finestra sul mondo) di Chicago aveva organizzato le selezioni per uno stage. In palio in pratica c’era l’opportunità di servire caffè e ciambelle per un anno a Gene Siskel e Roger Ebert, i due conduttori del programma di cinema “Sneak Previews”. Rubin compilò la domanda. Cinquecento candidati, due posti. Arrivò terzo. Per sollevarlo dal suo stato di evidente afflizione, uno dei produttori lo invitò a pranzo. E, come si usa fare tra chi fa (da sempre) e chi non ha (ancora) mai fatto, tra una portata e l’altra sciorinò consigli. Uno di questi gli aprì una porta. “Vuoi lavorare nella produzione televisiva? Non sprecare tempo a fare l’assistente. Inizia a scrivere”. Non ci aveva mai pensato. E decise di provarci. Ma per varcare quella soglia aveva ancora bisogno di qualcosa. Il giorno dopo, così, stampò i suoi primi biglietti da visita: Danny Rubin – Scrittore. Era stato facile. Fu con quei biglietti in mano che iniziò.
Rubin in questo modo cambiò il corso del tempo della sua vita, allontanandosi irreversibilmente dalla scienza, iniziando a sfruttare ciò che Chicago aveva da offrirgli. E, forte di quei biglietti magici (sommati alle sue capacità unite ai suoi modi gentili), iniziò a lavorare.
Scrisse testi e canzoni (per un programma televisivo di Chicago rivolto ai bambini), per i maghi, per i burattini, per le aziende, per le industrie (come Wicks Lumber, McDonald’s o Bell of Pennsylvania, che ora si chiama Verizon). In uno di questi lavori, quello per McDonald’s, trascorse due giorni sul bancone del fast food più produttivo del paese, così da poter scrivere un documentario che mostrasse agli altri lavoratori come fare a risparmiare secondi preziosi. Non era glorioso, ma almeno era pagato per scrivere. Guarda caso sul tempo.
Frequentò corsi presso la Old Town School of Folk Music, dopo i quali scrisse canzoni, suonò la chitarra nei locali, partecipò a concorsi. Seguì anche un corso di regia teatrale, iniziò così anche a scrivere commedie e a recitare al punto da essere coinvolto in due importanti compagnie d’improvvisazione comiche (la Practical Theatre Company e il Wavelength Improvisational Institute). Arrivò così a scrivere cortometraggi che girava poi nei fine settimana usando apparecchiature prese “in prestito” dai dipartimenti dei media aziendali per i quali lavorava e attori del mondo teatrale che frequentava. Lavorava sì e scriveva. Ma non era così che voleva impiegare il suo tempo. Aveva capito come pagare i conti, ma non era interessato a scrivere film aziendali per il resto della sua vita. Non stava sfondando da nessuna parte e non poteva continuare a battere qualunque tipo di strada. Doveva trovare la sua.
In quel periodo, era la fine degli anni Ottanta, il capo dell’Illinois Film Commission e il fondatore del Second City di Chicago unirono le forze per formare una società di produzione cinematografica, con l’intenzione di introdurre i talenti di Chicago a Hollywood. Le porte sarebbero state aperte a chiunque avesse voluto provarci. Rubin, cortometraggi a parte, non aveva mai scritto un vero film. Non conosceva nulla della tecnica, non aveva agganci con lo show business, non si intendeva degli aspetti commerciali. Ma sapeva che non doveva perdere tempo. Era una idea da prendere al volo. E così decise di presentarsi. Prima fece un brainstorming per due giorni. Era sempre stato un tipo creativo così partorì cinquanta idee. Erano troppe e alcune non troppo riuscite. Le ridusse a dieci. Tutte magnifiche, secondo lui. Erano storie assai fantasiose e molto diverse tra loro. Tra queste c’era “Silencer” che raccontava di un omicidio in una comunità di non udenti, “The Chef” su un ladro perdente che in prigione diviene un cuoco straordinario o “We love our Idiots” su un idiota che diventava presidente. Poi c’era anche “The Neebider Institute”, su un genio che dona i suoi organi dopo la morte e sui destinatari del trapianto che diventano geniali, ma solo se lavorano insieme. E infine c’era “Time Machine”: un ragazzo è bloccato in una distorsione temporale che lo obbliga a vivere lo stesso giorno per sempre. All’interno di quel “loop” può quindi comportarsi in modo diverso e il mondo e le persone saranno diversi di conseguenza. Cosa sarebbe potuto accadere a questo ragazzo? Sarebbe diventato più cinico o più saggio?
Ora si trattava di sceglierne una sola, scriverla e proporla. Rubin non sapeva scrivere un film, ma ne aveva visti abbastanza. Aveva solo bisogno che qualcuno gli mostrasse come fare. Così comprò quello che all’epoca era l’unico vero libro sul mercato dedicato alla sceneggiatura, quello scritto da Syd Field, e un paio di sceneggiature (“Dentro la notizia” e “Wargames”). Nessuno di questi testi gli sembrò troppo difficile.
Scelse “The Neebider Institute”. Dopo un paio di versioni lo fece leggere agli amici. Sembrava un film per bambini ma era troppo duro. Non c’era un vero pubblico di riferimento e pertanto accantonò il progetto. La seconda fu “Silencer”. Aveva avuto modo di lavorare per interpreti non udenti e sapeva molto sul loro mondo. Il protagonista sarebbe stato come un prete, obbligato a tacere. E se era non udente avrebbe potuto essere sotto attacco senza nemmeno saperlo. Sarebbe stata una storia hitchcockiana. La scrisse e decise di mandarla fuori, nel mondo (vero) dello spettacolo. Prima di farlo compilò un’altra lista (gli americani sono tipi molto pratici e fanno liste per qualunque cosa): un elenco di persone che a loro volta conoscevano persone che lavoravano nel settore. Non era molto ma era qualcosa. E fu utile. Scoprì infatti che, finché si trovava ai confini esterni del mondo dorato dell’entertainment, le persone della vita reale erano gentili e desiderose di essere d’aiuto. Una di queste, un amico di un amico di un amico, era un agente. In realtà fino al giorno prima aveva venduto servizi di pulizia. Ma ora era un agente. Pressappoco come lui era uno scrittore: uno insomma che aveva scritto sul suo biglietto magico: “agente” [c’è un’altra cosa sulla quale gli americani sono fissati: i biglietti da visita (almeno finché sono esistiti in larga scala prima delle esplosioni digitali e ambientali) per loro lo standard dell’essenza umana in versione cartacea].
L’agente non aveva esperienza, non aveva potere e non aveva connessioni con il cinema. Ma lesse la sceneggiatura e pronunciò le parole fatidiche: “La amo!”. Rubin avrebbe scoperto in seguito che l’uomo era un tipo entusiasta e che avrebbe rivolto le stesse parole a quasi tutto ciò che lo circondava, dai cheeseburger al traffico. Fu proprio l’entusiasmo, però, a permettergli di vendere la sceneggiatura (questa sarebbe poi uscita, dopo essere stata stravolta, con il titolo “Hear No Evil” e interpretata da Marlee Matlin, l’attrice premio Oscar per “Figli di un dio minore”). A Rubin arrivò una busta che lo informava che si era appena unito alla Writers Guild of America. Il tempo sprecato era finito. Si era sposato, aspettava un figlio. Si trasferì a Los Angeles. Entrò nel sindacato. Era uno sceneggiatore. Stavolta sul serio.
Le idee a volte fanno strani giri. Si allontanano, si nascondono e poi improvvisamente si fanno ritrovare. Rubin era entrato nella sala di un cinema di Los Angeles e si era appena accomodato. Un’azione che aveva compiuto tante di quelle volte che non se le ricordava nemmeno. Sedersi in una sala era stata una delle costanti del suo tempo. La sua testa in quel momento iniziò a vagare. “E se una persona potesse vivere per sempre, se fosse immortale, come userebbe il suo tempo? E come cambierebbe nel tempo?”.
L’idea si allargava troppo. Un tempo infinito avrebbe presupposto location e contesti storici di epoche differenti. E ormai Rubin ragionava da professionista. Nessuno avrebbe prodotto una storia così costosa. Così gli tornò in mente la decima idea della lista che aveva compilato due anni prima: “Time Machine”, su un uomo che viveva continuamente lo stesso giorno. Se questo secondo input creava il contesto giusto, il primo, legato ai possibili cambiamenti nel tempo, conferiva alla storia uno scopo più profondo. Le due idee combinate all’interno della stessa storia avrebbero aperto al tempo stesso possibilità comiche e drammatiche. Era l’idea giusta. Lo capì in quell’istante, seduto su quella poltrona. Le luci si spensero e partì il film. Se glielo chiedete oggi Rubin non ricorda nemmeno il titolo. Non c’è da stupirsi: la sua testa stava già cavalcando altrove.
What if
La vicenda poteva rientrare nelle storie “What If” (cosa succede se…), quel particolare sottogenere del cinema fantastico (a sua volta declinabile in direzione drammatica o comica) che persegue la tradizione, tanto cara agli americani, delle possibilità paranormali alternative (se divento bambino, uomo, donna, grasso, povero, o se vado nel passato, nel futuro, etc.). E quindi effetto farfalla, teoria del caos, ucronie, destino, viaggi nel tempo, multiverso, dejà vu, caso, dimensioni parallele (e pertanto universi paralleli e dunque vite parallele), seconde possibilità, catabasi, anelli temporali, etc. (insomma, tutto quello che “Lost” anni dopo sarebbe riuscito poi a condensare in una unica serie). Storie su spaccati di esistenze con finalità escatologiche che rientrano in quelli che io chiamo, sfruttando una struttura sintattica, periodi ipotetici dell’irrealtà.
La protasi di un simile periodo ipotetico, infatti, esprime un’ipotesi non realizzata nel passato (e quindi qualcosa che sarebbe potuto succedere, ma non è successo) mentre l’apodosi esprime la conseguenza non realizzata nel momento presente. Se nel periodo ipotetico di primo tipo l’ipotesi è presentata come un fatto reale, in quello di secondo tipo è vista come possibile, qui, nel terzo, è invece irreale. E pertanto, ad esempio, se un uomo di nome Phil fosse stato una persona di buon cuore (ipotesi non realizzata nel passato) ora avrebbe conquistato quello di una donna di nome Rita (conseguenza non realizzata nel presente).
La storia del film che aveva nella testa era quindi quella di una ipotesi ravvicinata del terzo tipo, quella di un uomo che solo alla fine riesce a realizzare le ipotesi non attuate nel suo presente-passato proprio grazie alla sua permanenza eterna nella protasi che gli permette di poter correggere il tiro. A corto raggio, però.
Prima di Rubin già in molti avevano provato a calcare tematiche ipotetiche. A partire da film come “Avvenne domani”, “Alice nel paese delle paese meraviglie”, “Rashomon”, “Il cielo può attendere”, “Destino cieco”, “Ritorno al futuro” o “Big” (uno dei pochi casi americani ripresi da una storia italiana, “Da grande” di Antonio Amurri). Ma anche Troisi e Benigni ci avevano provato con il campione di incassi “Non ci resta che piangere” (visto che il fine del loro involontario viaggio del tempo sarebbe diventato quello di impedire la partenza di Colombo per evitare così la scoperta dell’America e la conseguente nascita di un ragazzo che avrebbe spezzato il cuore della sorella di uno dei due). Insomma tutti o quasi rampolli de “La vita è meravigliosa” di Capra e quindi del “Racconto di Natale” di Dickens (certo, bisognerebbe poi scomodare Omero, Dante, Orfeo, Dostoevskij, Pirandello, Orwell, Leinster, Asimov, Dick, Crichton e molti altri ma il discorso si farebbe ancora più lungo).
Ricordo poi alcuni episodi della seconda serie de “Ai confini della realtà” (quella uscita nella metà degli anni Ottanta) colmi di questioni temporali. In uno di questi, “Una questione di minuti”, una coppia si trovava intrappolata nel dietro le quinte del tempo scoprendone così i meccanismi. In un altro, “Dallas, novembre 1963”, uno storico tornava indietro nel tempo al giorno dell’attentato a Kennedy, ma salvando il presidente creava una spaccatura temporale. In “Un po’ di pace” una casalinga stressata riusciva a fermare il tempo e poi a farlo riprendere ma un attacco nucleare la portava a bloccarlo definitivamente. Ne “L’anima pellegrina” due scienziati entravano in contatto con l’immagine di una donna del passato che invecchiava ogni giorno di dieci anni. Etc.
Una questione di tempo
La storia di Rubin ricalcava, riprendeva, deviava, variava, sfruttava (volontariamente o meno) anche alcune teorie scientifiche e narrative. Tra queste, l’ucronìa (dal greco οὐ “non” e χρόνος “tempo”, quindi “nessun tempo”), ovvero la narrazione di quello che sarebbe potuto succedere se un preciso avvenimento storico fosse andato diversamente (la storia alternativa). O l’anello temporale (il loop), l’espediente nel quale i personaggi sono costretti a rivivere in continuazione vicende già avvenute (la sua validità scientifica è stata ipotizzata nel 1937 dal matematico Willem Jacob van Stockum, teorizzata nei lavori del matematico Kurt Gödel nel 1949 e successivamente confermata dal fisico Frank Tipler). E non bisognava dimenticare l’eterno ritorno nietzschiano. Sentite cosa scriveva il filosofo ne “La gaia scienza” (1882):
“Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione – e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere”.
Era la clessidra della giornata del suo uomo, quella che nella storia veniva capovolta ogni 24 ore.
Se non era stato il primo a utilizzare il sottogenere, Rubin non era stato il primo nemmeno a pensare alla premessa utilizzata nella sua storia. L’idea di replicare all’infinito un segmento di tempo l’aveva avuta, tra gli altri, anche lo scrittore Richard A. Lupoff. Nell’edizione di dicembre del 1973 del “Magazine of Fantasy and Science Fiction” aveva pubblicato un breve racconto, intitolato “12:01 PM”, su un uomo intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere costantemente la stessa ora della sua vita. Nel 1990 il racconto era diventato un cortometraggio con lo stesso titolo, diretto da Jonathan Heap, che era andato in onda nella tv via cavo ed era stato anche nominato per un Academy Award. Insomma Rubin ne aveva di materiale. I film della sua vita, poi, erano “Brazil”, “Blow Up” e “The Conversation”. Non era un caso. Il primo raccontava un mondo distopico, il secondo e il terzo rispettivamente le analisi di una immagine e di una conversazione (che nell’arco del tempo della storia riuscivano a consegnarci una nuova verità). Eppure riuscì a concepire una idea molto originale.
Il suo personaggio, rimanendo incantato nel presente, non solo non viaggiava nel passato o nel futuro, come accadeva in film del genere, ma la sua dannazione lo portava a vivere la storia in modo completamente diverso dagli altri film. Lo sviluppo narrativo classico dei loop temporali, infatti, conferiva ai personaggi imprigionati nel circuito la possibilità di alterare il flusso degli eventi con il loro comportamento (come nel caso che tutti ricordano di “Ritorno al futuro). Qui invece, lui poteva scegliere di comportarsi nei modi più diversi senza che questi lasciassero traccia. Avrebbe potuto per assurdo farsi schiacciare da un elefante senza modificare per questo il futuro. Era l’esatto opposto dell’effetto della farfalla. È probabile poi che Rubin non si fosse nemmeno mai imbattuto in nessuno dei film che lo avevano preceduto. Oppure che questi lo avessero sfiorato stillandogli nella testa un tema ma non il modo di trattarlo. Nella sua storia comunque non era così importante capire come e perché fosse accaduta una cosa così inverosimile. A lui interessava soprattutto raccontare cosa sarebbe accaduto a un uomo che si trovava costretto a rivivere continuamente lo stesso giorno. Sarebbe diventato pazzo? Avrebbe assecondato i suoi peggiori impulsi? E poi, si chiedeva: di quante vite abbiamo bisogno per cambiare veramente? La sua storia avrebbe dovuto dare le risposte.
Intanto però serviva un contesto (un luogo e una data del calendario dove farlo incantare). Doveva essere particolare se doveva ripetersi all’infinito. Qualcosa di poco battuto. Gli venne in mente il lavoro realizzato agli inizi per la Bell of Pennsylvania. Era stato in quei giorni che aveva sentito parlare per la prima volta di una strana usanza locale riguardante una marmotta. E lui era una delle poche persone al di fuori di quello stato che sapeva che il festival della marmotta si svolgeva in una piccola città chiamata Punxsutawney.
Il fatidico giorno della marmotta
A partire dal 1887, il 2 febbraio di ogni anno, la città di Punxsutawney, in Pennsylvania, celebrava (e celebra tutt’oggi) il cosiddetto “Giorno della marmotta” (Groundhog Day) in un clima festoso di musica e cibo. Durante la cerimonia, la marmotta Punxsutawney Phil emerge dalla sua tana di Gobbler’s Knob e, secondo la tradizione, se vede la sua ombra, vuol dire che ha previsto altre sei settimane di clima invernale, se non la vede, ci sarà una primavera precoce. Il problema è: come fa la marmotta a comunicare la sua previsione? È semplice. Il suo vaticinio lo sussurra all’unica persona in grado di capirla, il presidente del Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle (il gruppo che si prende cura di Phil per tutto l’anno e organizza la cerimonia), in una lingua conosciuta come groundhogese. Interpretato quindi il messaggio di Phil, il presidente del club invita il vicepresidente a scegliere la pergamena con il relativo verdetto per leggerlo poi alla folla.
La data era poco battuta e pertanto aveva un grande potenziale. Poteva diventare un classico e il suo film essere trasmesso ogni volta il 2 febbraio, come accade per gli altri film invernali nelle date di Halloween, Natale o Capodanno. Certo, accostarsi al Natale de “La vita è meravigliosa” era forse un po’ azzardato, ma, come diceva Nelson Mandela, “sembra sempre impossibile finché non viene realizzato”. E poi in fondo il giorno della marmotta stava al natale come il suo potenziale film stava a quello di Capra. La proporzione funzionava e teneva la giuste distanze tra folclore e sacralità.
Era perfetto come luogo claustrofobico dove far incastrare il suo personaggio. In questo modo avrebbe potuto portarlo fuori dalla sua città natale e obbligarlo a restare isolato in un territorio disagevole e sconosciuto. Lo chiamò subito Phil, in onore della marmotta, e gli trovò un lavoro che potesse costringerlo a trovarsi in una simile località: quello di un meteorologo che viene inviato dal suo canale per coprire l’evento.
Era quasi pronto per iniziare a scrivere.
Il secondo tempo di Danny Rubin
Rubin si chiuse in una stanza della sua casa di Los Angeles. Impiegò circa sette settimane per fissare i concetti di base e le regole per il loop temporale del film. Iniziò a rispondere alle domande che si era posto. Come il suo personaggio avrebbe sfruttato questa situazione, ad esempio. Sicuramente vivere lo stesso giorno lo avrebbe portato nel tempo a fingere di sapere cose solo per il fatto di averle già vissute. Avrebbe quindi potuto fingere di conoscere le persone nel profondo. Le donne, ad esempio. Ecco, Phil avrebbe potuto usare il suo “potere” per avere successo con le donne. Magari una sola. Questo gli indicò la strada del genere, aprendogli le porte alla commedia (in qualche modo, quindi, sentimentale). Pertanto sarebbe stato un film fantasy, declinato alla commedia, a sua volta parzialmente indirizzata al sottogenere della romantic comedy. Anche se per lui non era determinante, si chiedeva poi se fosse necessaria una spiegazione: come aveva fatto Phil a incastrarsi nelle maglie del tempo? Esisteva una macchina del tempo? Aveva subito una maledizione? C’era di mezzo una zingara? Era stata un’anomalia divina? Esisteva un orologio magico?
Risolti tutti gli interrogativi e stesa una struttura, Rubin aprì il suo portatile Toshiba, completò la prima stesura della sceneggiatura in pochi giorni e la consegnò al suo agente. Una volta letta questi lo chiamò: “È la migliore che io abbia mai avuto tra le mani – disse subito – ma dubito che potrà mai essere venduta”. Rubin però ormai sapeva che “Groundhog Day”, così aveva chiamato la storia, era il suo nuovo biglietto magico. Il suo vero biglietto da visita.
I due incontrarono una cinquantina di produttori. Tutti, in qualche modo, risposero ripetendo all’infinito la medesima frase dell’agente: “Abbiamo adorato Groundhog Day, ma non possiamo farlo”. Sfinito dai tanti rifiuti il suo agente si decise ad abbandonare il dorato mondo del cinema e Rubin, che ormai aveva già due sceneggiature al suo attivo (delle quali una venduta) ne cercò uno serio, un professionista. La sceneggiatura arrivò così nelle mani di Richard Lovett, presidente della Creative Artists Agency, il quale, pochi mesi dopo, fu in grado di farla finire sulla scrivania Harold Ramis. Il regista la trovò talmente interessante da decidere di produrla e dirigerla.
Ramis era ovviamente ben noto a Rubin. Era uno degli autori di commedie di maggior successo a Hollywood. Di lui Rubin conosceva i film che aveva scritto (come “Animal House” o i due “Ghostbuster”) e quelli che aveva diretto, come “National Lampoon’s Vacation”. Era entusiasta di sapere che un uomo così famoso avrebbe realizzato la sua storia. In più Ramis era anche una persona amabile. Aveva un ottimo carattere, sapeva ascoltarlo e rispettava le sue idee. Insomma era piacevole passarci il tempo.
Fin dall’inizio il regista fu chiaro: “Dobbiamo lavorare per trasformare il tuo film bizzarro e non-hollywoodiano in qualcosa di più mainstream”. Così si misero all’opera per creare una buona, accorata, divertente storia, nulla di più. Nel corso della lavorazione dello script i due ebbero grandi conversazioni su buddismo e reincarnazione, su Superman, etica e altre bizzarre idee filosofiche stimolate dalla vicenda. Senza mai pensare all’impatto che il film avrebbe potuto avere sugli spettatori. Erano consapevoli, però, che quella fosse una storia che poteva avere tutte le caratteristiche di un classico. Era però così semplice e vera che poteva essere raccontata in modi diversi da diversi narratori. Pertanto bisognava trovare una strada che sentissero propria.
Tuttavia Rubin era ancora scottato dalle esperienze precedenti. Le cose che aveva proposto fino a quel momento erano sempre state poi stravolte rispetto alle iniziali intenzioni. E temeva che al suo giorno della marmotta stesse ricapitando questo. Che insomma fosse entrato anche lui in un loop nefasto. Era certo che anche stavolta i produttori gli avrebbero portato via tutto quello che di innovativo e interessante era presente nella sua storia per trasformarlo in una commedia di Hollywood facile da digerire. Così era già accaduto. Così sapeva che sarebbe accaduto.
Nella sceneggiatura presentata a Ramis la vicenda iniziava in media res. L’intenzione di Rubin era infatti quella di non spiegare al pubblico perché Phil fosse entrato nel ciclo. Il suo personaggio si trovava già nel mezzo del loop temporale e secondo lui questo avrebbe creato nel pubblico molta curiosità. Sarebbe stata poi la voce fuori campo dello stesso protagonista a spiegare gli antefatti. Inoltre, anche Rita, la protagonista femminile, nel corso della storia avrebbe poi confessato di trovarsi nella sua stessa condizione. Quando Rubin incontrò Ramis per la prima volta chiese di lasciare questa impostazione. Il regista lo tranquillizzò: “Ho amato che il film iniziasse così e non lo cambierò”. Gli altri produttori Trevor Albert, C.O. Erickson, Whitney White e i capi dello studio della Columbia Pictures, confermando tutti i timori di Rubin, fecero però pressione affinché si usasse una tecnica narrativa più classica, costringendo così il povero autore a correggere il tiro della sceneggiatura sotto la direzione del più esperto Ramis.
Si creò quindi una particolare tensione tra le parti, attenuata però dal paziente lavoro di Ramis che, trovandosi in mezzo, cercò in tutti i modi di non scontentare la produzione e al tempo stesso non avvilire il lavoro di Rubin. I soci di Ramis gli imposero una struttura più classica in tre atti, dove nel primo veniva mostrata la ragione per la quale Phil restava intrappolato nel loop temporale. In queste versioni, Phil veniva maledetto da una zingara oppure scaricava senza troppi riguardi la sua fidanzata, Stephanie e mentre si trovava a Punxsutawney, lei, per vendicarsi, gli lanciava una maledizione che lo avrebbe intrappolato in un loop temporale per diecimila anni. L’incantesimo, realizzato con un rito voodoo su un orologio rotto (che segnava le 5 e 59), si sarebbe interrotto solo con un bacio, quello di Rita.
Questa soluzione gettò Rubin in uno stato di frustrazione. Il film si stava banalizzando. Non era più la sua creatura, quella storia speciale che aveva iniziato a pensare seduto sulla poltrona di un cinema di Los Angeles. Le nuove scene avrebbero tolto tutto ciò che era originale nella sua storia e lo avrebbe trasformato in “una commedia hollywoodiana facile da liquidare”. Ne parlò lungamente con Ramis. Insieme concordarono che quel lungo preambolo esplicativo non aggiungeva nulla alla storia e pertanto il regista intercedette a suo favore per rimuovere le scene mantenendo però la struttura in tre atti. Il compromesso fu: “Facciamo iniziare il film prima che accada ma dopo non spieghiamo perché”. A Rubin questa giusta via di mezzo sembrò molto ragionevole.
La storia definitiva
Il 5 marzo 1992 la trama era chiusa.
Il cinico meteorologo Phil Connors si reca a Punxsutawney, in Pennsylvania con il produttore Rita Hanson e il cameraman Larry in occasione della festività del Giorno della marmotta (Groundhog Day) che si tiene ogni anno il 2 febbraio. La mattina del servizio Phil si sveglia nel suo bed and breakfast al suono di una radiosveglia che intona “I Got You Babe” di Sonny & Cher (la canzone non poteva che essere questa visto il testo: “Dicono che siamo giovani e che non sappiamo. Non lo scopriremo finché non cresceremo”), fa il suo servizio e va a letto presto. La mattina dopo si sveglia ancora con la stessa canzone, pensa sia uno sbaglio ma presto si rende conto che gli eventi si ripeteranno esattamente come il giorno prima. La mattina seguente ha la certezza di trovarsi intrappolato in un loop temporale. Presto Phil capisce che non ci sono conseguenze per le sue azioni e abusa della situazione bevendo o guidando pericolosamente. Attraversa poi una fase depressa che lo porta ripetutamente a suicidarsi. Ma continuerà a svegliarsi sempre con “I Got You Babe”. Avendo sviluppato un sentimento, non ricambiato, per Rita, decide di usare la sua conoscenza degli eventi per cercare di impressionarla, ma viene respinto ogni volta. La ripetuta morte di un senza tetto però lo porta a estendere i suoi propositi per evitare incidenti e migliorare la vita di tutti gli abitanti di Punxsutawney. Finché si ritrova entusiasta di partecipare alle celebrazioni del giorno della marmotta. È ormai un altro uomo rispetto al suo primo giorno. E Rita ricambia finalmente il suo amore spezzando così l’incantesimo.
La scelta di Murray
Quando Rubin scrisse la prima stesura, per il ruolo di Phil aveva in mente qualcuno come Kevin Kline. Con Ramis vennero contattati prima Tom Hanks, che era occupato, poi Michael Keaton, che non comprese il senso della storia e rifiutò. Ramis, però, sapeva di avere un asso nella manica. Il suo eterno amico. Bill Murray.
Murray e Ramis si erano conosciuti alla Second City di Chicago, la famigerata troupe di commedie improvvisate. Murray si era lasciato alle spalle un’infanzia difficile (otto fratelli, un padre morto per diabete, una sorella con la poliomielite), una espulsione dal college per possesso di marijuana e una conseguente serie di lavori precari. Quando ormai era certo di avere perduto l’occasione di un futuro, era stato convinto dal fratello Brian a lavorare in teatro.
Entrambi nativi dell’Illinois, Murray e Ramis erano diventati subito inseparabili ed erano riusciti a scavalcare indenni i viaggi nell’LSD e gli arresti per droga. Grazie a lui Murray era entrato un incredibile circolo virtuoso: aveva conosciuto John Belushi, che lo aveva inserito nel programma radiofonico “The National Lampoon Radio Hour”, grazie a questo nel 1977 era entrato nel “Saturday Night Live” e di seguito era stato invitato come primo ospite della prima puntata del “David Letterman Show”. Il decennio degli anni Ottanta si era rivelato un periodo d’oro per lui (anche nella vita privata: si era sposato con Mickey Kelley e aveva avuto subito due figli, Homer e Luke).
Murray e Ramis erano ormai due delle personalità più popolari del cinema americano. Tra il 1979 e il 1993 (tra film scritti o diretti da Ramis) avevano realizzato cinque pellicole insieme – “Polpette” (1979), “Palla da golf” (1980), “Stripes” (1981), “Ghostbusters” (1984) e “Ghostbusters II” (1989) – e ormai vivevano un rapporto simbiotico. Sul set l’intesa tra loro era perfetta. Se qualcosa non andava, si dicevano “Facciamo illuminare questa scena”, si mettevano in un angolo a parlare per una mezz’ora e producevano qualcosa di grande.
Si trovavano entrambi nella stessa condizione di uomini di successo che però cercavano ancora il loro primo grande alloro. Murray era diventato uno dei grandi della sua generazione insieme a Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Belushi e John Candy, aveva recitato in “Tootsie” (1982) al fianco di Dustin Hoffman, era stato coprotagonista dello stratosferico “Ghostbusters” (nel ruolo che sarebbe dovuto toccare al suo amico Belushi se non fosse morto) ed era stato anche candidato a un Golden Globe, ma non era soddisfatto della sua carriera professionale. Sognava ancora una grande parte da protagonista in un film, Ramis di poterlo dirigere. Murray se ne era andato per quattro anni lontano da Hollywood, a Parigi (dove aveva frequentato la Cinémathèque e i corsi universitari della Sorbonne) ed era ritornato con desideri di crescita. Ramis fece leva su tutti i suoi punti di forza per convincere il suo vecchio amico a recitare. E quando Murray vide nei suoi occhi la solita luce capì che quel suo compagno di sbronze gli stava facendo scorgere una possibilità. E accettò.
Un’aria da commedia americana
Per la protagonista femminile venne individuata Andie MacDowell, attrice che, dopo “Sesso, bugie e videotape” e “Green Card”, era in grande ascesa. Ramis la fece incontrare in una stanza con Murray e le propose di fare una lettura insieme. Ma alla fine tutti e tre si trovarono a parlare. Fu piacevole, l’intesa si rivelò magnifica e così lei venne scelta.
Le riprese (che iniziarono il 16 marzo e proseguirono fino al 10 giugno 1992) non si svolsero a Punxsutawney, nella contea di Jefferson, ma a Woodstock, nell’Illinois, a poco più di un’ora da Chicago, vicino al confine con il Wisconsin. La scelta della location, come spesso accade nel cinema, rispondeva a criteri artistici e produttivi: Punxsutawney non aveva un centro città pittoresco e la sua posizione remota avrebbe amplificato i problemi logistici con conseguenti aggravi di spese per le riprese. Inoltre Ramis giocava in casa, era nato a Chicago, conosceva l’area come le sue tasche, sapeva che Woodstock era il sostituto ideale per mostrare una Pennsylvania nevosa e che sarebbe stato più facile sia ottenere le licenze per girare lì, sia gestire la produzione del film durante i mesi invernali.
Quell’aria da commedia americana però non contagiò i set. Se la macchina produttiva funzionò perfettamente, esattamente come previsto da Ramis, sul fronte umano tutto andò per il verso storto.
Cominciarono i funzionari di Punxsutawney. Seccati per essere stati snobbati, si rifiutarono di permettere al vero Punxsutawney Phil di apparire nel film. Mandarono però dei rappresentanti a Woodstock per assicurarsi che la cerimonia fosse rappresentata nel modo più fedele possibile.
Il roditore, dal canto suo, nonostante la presenza costante di un “gestore della marmotta”, ci si mise di impegno per peggiorare la situazione mordendo per ben due volte Murray (nella scena in cui entrambi si trovavano al volante di un autocarro) nello stesso punto (le nocche della mano) a distanza di giorni. L’episodio costrinse la troupe a fermarsi innescando nervosismi diffusi nella produzione (ogni minuto perso nell’enterteinment costa migliaia di dollari) e soprattutto nella vittima che fu portato da un dottore per accertarsi che non avesse contratto la rabbia (“Non sappiamo se le marmotte la provocano”, fu comunque la disarmante risposta del medico). Di fronte al suo sfogo, il produttore Albert sbottò: “Non è che potevamo allevare marmotte per dieci anni nella speranza che un giorno avremmo fatto un film”. I roditori-attori (rodittori?) erano in effetti più di uno, anche se si chiamavano tutti Scooter. “Mi odiarono con tutte le loro viscere, fin dal primo giorno”, avrebbe detto poi Murray.

Durante il periodo delle riprese, Murray si trovò comunque in un momento molto critico della sua vita personale. La sua relazione con la costumista Jennifer Butler stava portando il suo matrimonio con Mickey Kelley verso il divorzio e la conseguente perdita dei suoi figli. Era pertanto di pessimo umore, il suo carattere era instabile, scostante e talvolta intrattabile. Se nella pre-produzione si era dimostrato presente, partecipe e anche collaborativo, al momento delle riprese il suo comportamento sul set divenne sempre più irrazionale e problematico. Non riusciva a presentarsi in tempo e aveva frequenti scatti d’ira. Le più violente discussioni le fece proprio con Ramis. Non approvava il taglio, il timbro, le inclinazioni del suo personaggio e tutte le altre sue scelte di regia. Desiderava che Phil (e di conseguenza il film) fosse trattato in modo più lunatico e provocatorio rispetto a quanto deciso nella sceneggiatura. Da un alto c’era Murray che voleva provare a fare un salto rispetto alle sue abituali corde (quelle alle quali il pubblico si era assuefatto) cercando in tutti i modi di rendere il film più contemplativo, dall’altro c’era il suo amico di sempre, Ramis, stavolta nei triplici panni di produttore, regista e sceneggiatore, che voleva e doveva mantenere gli equilibri della commedia. Erano stati come fratelli, ed ora erano nemici. Ognuno sembrava che andasse contro gli interessi dell’altro. Anche se non era così, Ramis e Murray arrivarono al punto di non rivolgersi più la parola, neanche per discutere della sceneggiatura. Ramis per provare ad andargli incontro gli mise a disposizione Rubin. Nelle settimane in cui non venne impiegato, Murray si isolò insieme a lui a New York per lavorare alle sue battute. Ramis telefonò ogni giorno per seguire le evoluzioni della nuova stesura, ma Murray si rifiutò regolarmente di parlare con lui. Ad ogni modo così si andò avanti.
Ramis era un’anima gentile, un uomo sano, un artista incredibilmente umile, non esisteva un osso di arroganza in lui. Come Rubin, viveva il mondo di Hollywood da straniero. Non amava i suoi simboli, a lui interessava solo fare film che potessero divertire gli altri. Primi tra tutti i suoi bambini. Li adorava. C’erano sempre famiglie nei suoi set. La sua troupe poteva portarci i genitori o anche i figli. Con Harold tutti erano i benvenuti. Il suo era un ambiente sicuro, l’atmosfera era sempre gioiosa e lui non si arrabbiava mai. Così cercò in tutti i modi di compensare quei dissapori perché non contagiassero gli altri. Ogni giorno inventò giochi, se doveva prendere decisioni lo faceva coinvolgendo tutti i collaboratori, anche quelli tecnici, si prodigò in mille modi per tenere alto lo spirito della troupe. Le giornate furono lunghe, ma lui riuscì a trovare il modo di scaldare gli animi del suo set sollevando il morale delle persone.
Il risultato finale fu quindi il frutto dello strano equilibrio che si venne a creare tra i tentativi di Rubin di preservare la sua creatura originaria (dalle grinfie dei produttori della Columbia che ne volevano fare un giocattolo), i desideri di Murray di rendere la storia più sopra le righe e l’abilità di Ramis di portare queste il più possibile sulla linea della commedia classica.
“Groundhog Day” (in Italia, forse sulla scia del film di Troisi, fu tradotto in “Ricomincio da capo”) uscì il 12 febbraio 1993, esattamente venticinque anni fa. Ottenne un discreto successo, ricevendo recensioni non entusiastiche ma generalmente positive (Janet Maslin del New York Times la definì “una commedia particolarmente spiritosa e risonante”, per Hal Hinson del Washington Post fu “la migliore commedia americana da Tootsie”, dove tra l’altro c’era sempre Murray, Owen Gleiberman di Entertainment Weekly le assegnò un “B-“). Il film incassò settanta milioni di dollari in Nord America classificandosi al tredicesimo posto tra i film usciti nel 1993. Si aggiudicò un British Comedy Awards, un Saturn Award per la migliore attrice (Andie MacDowell) e un Premio BAFTA per la migliore sceneggiatura originale. Fu anche candidato per il Premio Hugo per la migliore rappresentazione drammatica, ma perse in favore di “Jurassic Park” .

La vita oltre la vita della marmotta
Dopo il film Rubin iniziò a ricevere molte telefonate per lavorare su nuovi progetti. Non stava nella pelle. Erano gli altri che cercavano lui. Sentiva che finalmente ce l’aveva fatta. Poteva ormai pensare e dire: “Questo è il posto a cui appartengo”. Era diventata una persona conosciuta – il ragazzo che aveva scritto “Groundhog Day” – e tutti i produttori – che appartenevano a quello stesso posto da lui così faticosamente conquistato – volevano in pratica che scrivesse di nuovo quello stesso film. Qualcosa di bizzarro. Ma non troppo. Forse qualcosa con una distorsione temporale o magari con un meteorologo. Lui scrisse un film su una donna, gli chiesero se poteva essere un uomo. Ne scrisse uno muto, gli chiesero se poteva metterci i dialoghi. I produttori lo ascoltavano ma non rispondevano alle sue proposte né realizzavano i suoi film. Rubin riuscì più volte anche a vendere le sue storie. Ma gli studios dopo averle opzionate (i produttori, così come gli editori, vivono nel perenne terrore dell’erba del vicino), o le tenevano in un cassetto oppure le stravolgevano a tal punto da renderle l’opera di un altro. Così andò avanti per anni.
La maggior parte delle persone in questa situazione avrebbe due possibilità. Cambiare lavoro, come fece il suo primo agente dopo tutti i rifiuti ricevuti, o scendere a compromessi. Rubin non assecondò né la prima né la seconda. Semplicemente proseguì ad andare per la sua strada. Continuò a scrivere sceneggiature con le proprie idee e seguitò comunque a venderle: alla Universal, alla Dreamworks, alla Amblin, alla Fox, alla Castle Rock, alla Miramax. Ma nessuna di loro venne mai prodotta.
Ogni volta che qualcuno in questi anni gli ha chiesto su cosa stesse lavorando rispondeva con frasi del tipo: “Ho un progetto”, “Ho avuto un’opzione”, “Sto scrivendo”, “Ho avuto un paio di offerte”, “Stiamo negoziando”, etc. che, come ho scritto anche altrove, sono le tipiche espressioni degli autori quando non si muove una paglia. In realtà era la verità. E le sue erano risposte sincere. Aveva davvero opzioni da grandi case di produzione. Scriveva veramente in continuazione. Ma poi non accadeva nulla. Qualche anno fa a questo proposito disse: “Sto lavorando su un progetto che ho scritto per la prima volta dieci anni fa e da allora lo sto riscrivendo. Continua a essere opzionato ma poi non succede nulla. Come ho fatto notare al produttore la settimana scorsa, mia figlia ha vent’anni, quando lo scrissi per la prima volta lei ne aveva dieci”. Quando realizzò “Groundhog Day” si era detto: “Questo è il mio momento! È ora! E, grazie a questo, da ora si ripeterà!”. Ma Hollywood – il luogo dove pensava di appartenere – non era interessato a inseguire i suoi lavori, ma a seguire le proprie logiche. E così quel momento non accadde più. Mai più.
Successe però una cosa strana. Se da un lato Rubin continuò a non fare film, dall’altro “Groundhog Day” iniziò a diventare la parte proporzionalmente più grande del suo curriculum. Con il passare degli anni, il suo film sembrò guadagnare una certa risonanza. Anche l’espressione “Groundhog Day” entrò gradualmente nel lessico comune (come era accaduto al “salto dello squalo”) e iniziò a essere utilizzata per rappresentare qualunque situazione che sembrava ripetersi continuamente senza mai cambiare (anche in contesti politici, sociali, militari, etc.). Gli amici di Rubin, ogni volta che sentivano qualcuno che la usava, lo chiamavano eccitati, finché divenne così comune che non fu più necessario avvisarlo.
Questa fortuna contagiò anche gli altri aspetti del film. Il festival di Punxsutawney, una volta capace di attirare appena un paio di centinaia di visitatori in un fine settimana, iniziò ad attrarne decine di migliaia. Anche Woodstock, la reale location del film, pensò di organizzare un festival annuale del Groundhog Day, con una cena a tema, proiezioni gratuite del film e un tour a piedi che prevedeva visite al teatro dell’opera, al bowling, al cinema, al Moose Lodge, a casa dell’insegnante di pianoforte e al Cherry Street Inn. All’altezza della famigerata pozzanghera, quella calpestata ripetutamente dal protagonista, venne collocata una placca di metallo che recitava: “Bill Murray Stepped Here”.
Gli unici che non poterono godersi questo tardivo circolo virtuoso furono Ramis e Murray. La loro lunga amicizia (e collaborazione) si interruppe definitivamente. Non venne mai data una spiegazione pubblica. L’unica cosa certa fu che il film, quel film che sarebbe stato il loro gioiello, forse la cosa migliore realizzata nella loro vita, segnò sì l’avverarsi di un sogno ma anche la fine del loro rapporto. I due uomini non si sarebbero più parlati per i successivi vent’anni e Murray si sarebbe riconciliato con Ramis solo a pochi giorni dalla morte di questi.
La vita dopo la vita del “Groundhog Day” fu una faccenda che riguardò prima di tutto quelli che nel 1993 si erano trovati a osservare la marmotta dall’altra parte, seduti sulle seggiole delle sale cinematografiche: spettatori e critici. Se a quei tempi entrambe le categorie avevano accolto discretamente quella che consideravano a tutti gli effetti solo una piacevole commedia, nel tempo, “vedendo e rivedendo”, “vivendo e rivivendo” il “vivere e rivivere” di quel fatidico GdM (un po’ come accade ai coniugi di certi matrimoni combinati) “impararono ad amarlo”.
Nel 2000, sette anni dopo l’uscita di “Groundhog Day”, i voti dei lettori di Total Film lo collocarono al settimo posto nelle migliori commedie di tutti i tempi. Nel giorno della marmotta del 2004 Andrew Buncombe si chiese sull’ Independent se questa fosse la più grande storia mai raccontata. Nel 2005 il critico premio Pulitzer Roger Ebert che nella sua recensione originale gli aveva assegnato tre stelle, nel suo libro “Great Movies” lo rivalutò assegnandogliene il massimo (ammettendo che, come molti altri spettatori, aveva inizialmente sottostimato le virtù del film e che era riuscito ad apprezzarlo veramente solo dopo visioni ripetute). Nel 2006 il film venne selezionato dal National Film Preservation Board per la conservazione nella Library of Congress. Nel 2009, il teorico letterario americano Stanley Fish incluse il film tra i dieci migliori (americani) di sempre. Nel 2011 Time Out scrisse che era la quinta più grande commedia di tutti i tempi. Il Writers Guild of America classificò il lavoro di Rubin al numero 27 nella lista delle 101 più grandi sceneggiature di sempre. Oggi si trova al trentaquattresimo posto nella lista delle 100 migliori commedie americane e all’ottavo posto nei 10 migliori film fantasy, votato da 1500 addetti ai lavori dell’American Film Institute.
Un decennio dopo il film era diventato un classico moderno, come “Star Wars”, “La donna che visse due volte”, “Rocky”, “Il padrino”, “Io e Annie”, “Ben Hur”, “Vacanze romane”, “Harry ti presento Sally” e tutti gli altri film presenti in quelle liste. Su Rotten Tomatoes la percentuale di utenti che ha dato un giudizio positivo è del 96%. Su Metacritic il punteggio è 72/100. Nel numero speciale dedicato agli anni Novanta di Total Film “Groundhog Day” è stato considerato il miglior film del 1993 (l’anno che vide l’uscita di “Schindler’s List”). E, all’apice di una meta-simulazione sfrenata, il 2 febbraio 2016 i fan di Liverpool hanno voluto vivere il loro giorno della marmotta guardando la pellicola dodici volte in ventiquatt’ore.
Così anche il film, come il suo protagonista, solo nel tempo migliorò la sua esistenza. Fu sempre più visto, fu sempre meglio criticato. Se Phil era diventato una buona persona, lo stesso accadde alla pellicola. E se il primo, grazie a questo, era riuscito finalmente a conquistare la sua amata, allo stesso modo il film riuscì in seguito a conquistare definitivamente il suo pubblico. Divenne adorato e, incredibilmente, nel tempo (e solo nel tempo), si tramutò in un un classico. Rubin a quel punto non ebbe più bisogno di quei pezzi di carta che si era fatto stampare all’inizio di questa storia. Né dello script che aveva realizzato. Quel film ora era diventato il suo (vero) biglietto magico. Quello con cui poteva presentarsi, identificarsi, mostrarsi e anche vantarsi: “Io sono quello del giorno della marmotta”.
Migliaia di persone continuarono a scrivere a Rubin per dirgli di cosa, secondo loro, parlava il suo film. Per la maggior parte di queste rappresentava la dimostrazione di come la felicità potesse realizzarsi solo ponendo i bisogni degli altri al di sopra dei propri desideri egoistici. La sua storia era diventata la metafora più gettonata dell’auto-miglioramento, della trascendenza spirituale, della rinascita, dell’altruismo, della redenzione, della reincarnazione, persino del purgatorio. E pertanto fu adottata, sulla base dell’interpretazione più idonea a ciascuna causa, da comunità di buddisti, induisti, cristiani, ebrei, cabalisti, monaci, economisti, aristotelici e nietzschiani. “Connors va alla sua versione dell’inferno, ma dal momento che non è malvagio, quello si rivela essere il purgatorio, dal quale è liberato perdendo il suo egoismo e impegnandosi in atti d’amore – scrisse Jonah Goldberg – gli ebrei trovano un grande significato nel fatto che Connors viene salvato solo dopo aver eseguito mitzvah (buone azioni) ed è tornato sulla terra, non in cielo, per dare il meglio di sé”. È stato persino definito il “film più spirituale del nostro tempo”. Non per nulla “la maledizione si risolve quando Bill Murray benedice il giorno in cui è appena vissuto – scrisse il critico Rick Brookhiser – e la sua ricompensa è che quel giorno gli viene tolto di mezzo. Amare la vita include amare il fatto che vada via”.
Si sprecarono anche le speculazioni sulla durata del ciclo temporale. In relazione alle interpretazioni spirituali del film, molti spettatori cercarono infatti di stimare per quanto tempo Phil fosse rimasto intrappolato nel loop. Durante le riprese, Ramis aveva osservato che, secondo la dottrina buddista, ci sarebbero voluti diecimila anni perché un’anima potesse evolversi al suo livello successivo (ipotesi confermata dalla seconda bozza della sceneggiatura dove Phil veniva maledetto per vivere il loop temporale per quel numero di anni). Nel 2014 il sito WhatCulture combinò varie ipotesi sulla durata (sommando, tra le altre cose, il tempo necessario per acquisire le capacità che mostra il personaggio alla fine del film: suonare il piano, scolpire il ghiaccio e parlare francese, ad esempio) e stimò che Phil aveva trascorso un totale di 12.395 giorni – poco meno di 34 anni – rivivendo il giorno della marmotta. Nessuno comunque riuscì a sapere realmente per quanto tempo Murray era rimasto fermo nello stesso giorno.
The Groundhog Effect
Nel frattempo l’idea del loop time e delle possibilità alternative iniziò a esplodere, diventando sempre più uno standard da utilizzare sia nel cinema che nelle serie tv (in “tempi” non sospetti persino il peraltro direttore del Post, in modo assai cavilloso e competente, e il sottoscritto, a dire il vero con fare un po’ cialtrone, si trovarono uno sotto l’altro a commentare la faccenda un’era geologica fa. Ah, la rete!). Al cinema il genere esplose con i vari “Una settimana da dio”, “Cambia la vita con un click”, “Family Man”, “What Women Wants”, “Pleasentville”, “Smoking/No Smoking”, “The Butterfly Effect”, “The Jacket” e soprattutto (l’avverbio si consideri limitatamente in termini di popolarità) con “Sliding Doors”, figlio però di “Destino cieco” (qui lo scrivente ammette tuttavia un manifesto debole per il regista polacco in difesa di eventuali critiche relative a questa e ad altre visioni kieslowskicentriche). Nei telefilm, invece, i meccanismi temporali distorti vennero trattati in intere serie, come “Ultime dal cielo” o “In viaggio nel tempo” (“Quantum leep”), ma anche isolatamente, in singole puntate di serie di fantascienza (“Star Trek”, ad esempio) o di cartoni animati (“I Simpson”, per dire: nel secondo episodio de “La paura fa Novanta” parte V – mandato in onda il 30/10/94 – Homer, mentre sta riparando il suo tostapane viene risucchiato in un vortice temporale e spedito nella preistoria. Ritrovatosi agli albori dell’umanità si ricorda di un assurdo consiglio del padre nel giorno del suo matrimonio: “Se mai tu dovessi viaggiare indietro nel tempo, non calpestare niente, perché anche il benché minimo cambiamento può alterare il futuro in maniera irreversibile”. Ma una zanzara preistorica gli vola vicino, lui la schiaccia e altera così il normale flusso del tempo). Persino la sit-com generazionale “Friends” nel 2000 dedicò due puntate per vedere come sarebbero andate le vite dei sei amici se le cose fossero andate diversamente.
Rubin continuò a ricevere sacchi di posta da tutto il mondo. Erano lettere, articoli, sermoni e dissertazioni inviate da psicologi, filosofi, leader religiosi, così come da amici o semplici ammiratori (tra questi ci furono un economista che aveva visto il film come una dimostrazione del paradigma di Mises-Hayek e un gruppo di tossicodipendenti ai quali il film fece capire che si erano intrappolati da soli nella loro Punxsutawneys). Le lettere, così come le telefonate e le e-mail, avrebbero raggiunto il picco ogni 2 febbraio, giorno in cui Rubin e sua moglie invitavano tutti i loro amici, preparavano un grosso piatto di stufato di marmotta (che era solo uno stufato, “ma se lo chiami stufato di marmotta diventa una festa”), poi spostavano i mobili e ballavano fino a tarda notte. Qualcuno – non ha mai saputo chi – per anni gli ha lasciato piccoli regali, palloncini e caramelle o addirittu,ra una marmotta giocattolo, nella sua veranda a Santa Fe. “È come il mio compleanno”, ha sempre detto lui.
L’uomo da un colpo solo
Tutto questo clamore, però, non gli permise ugualmente di vedere una sua storia realizzata. Se si esclude “S.F.W.” (scritto prima ma poi stravolto dalla produzione) nel 1992 scrisse “The Secret House” (acquistata dalla Universal Pictures) e “Corduroy” (Guber-Peters Films Tri-Star Pictures), nel 1994 “Small Soldiers” (Amblin Entertainment Universal Pictures), “Two Egg” e “Brush With Love” (Fox Family Pictures), nel 1995 “The Sucker List” e “The Magic Butler” (Castle Rock Entertainment), nel 1996 “Martian Time” (Jim Henson Pictures), nel 1998 “True Story” (HBO Films) e “Myth New York” (Miramax), nel 1999 “Roofus” (Miramax), nel 2000 “Spywheel” (Digital Domain Parkway Productions), nel 2004 “DoorJam”, nel 2002 “The Hanging Tale” (Lightstorm Entertainment), nel 2006 “Ghost Movie” (Dreamworks Animation), nel 2009 “Summertime” (Big Beach Films) e nel 2013 “The Water of Life” (FR Productions). Nessuna di queste sceneggiature è diventata un film.
Nel 2007, Rubin aprì un blog per rispondere alle domande dei fan e pubblicare dei dialoghi fittizi tra lui e un Phil Connors, ormai pensionato, eremita a Taos e per un po’ fu anche un blogger di successo. Poco dopo cominciò a insegnare sceneggiatura ad Harvard e a tenere conferenze accademiche in varie altre facoltà degli Stati Uniti.
Gli hanno chiesto ogni singolo giorno se quel successo, ormai sempre più lontano, gli stesse gettando addosso un’ombra gigantesca. Lui ha sempre risposto serenamente. “È quella la cosa con cui sono più associato. Non mi ha portato altro che buone cose. Quello che farò dopo non è così importante. È vero, non sono l’incredibile sceneggiatore che ha avuto questa lunga e leggendaria carriera, sono solo il ragazzo che ha scritto Groundhog Day. Ma se devi rimanere bloccato su un solo film, potrebbe essere uno peggiore di questo. Per me invece è davvero piacevole essere associati a qualcosa che è così amato”.
Il terzo tempo di Rubin
Ma la storia non finisce qui. Il musicista Tim Minchin e il regista Matthew Warchus nel 2012, erano freschi del successo del loro primo musical, “Matilda”, e volevano che “Groundhog Day” fosse il loro nuovo adattamento. Warchus sapeva che Rubin aveva lavorato per anni ad una versione musicale del film (in parte per divertimento, in parte perché era uno dei diritti che non aveva concesso alla Columbia Pictures). Ma avevano la sensazione che Rubin dovesse essere avvicinato con cautela. Sapevano che era un uomo scottato dallo star system, un ragazzo sensibile, troppo buono per il mondo nel quale era finito e troppo puro nel suo desiderio di scrivere cose interessanti per un mondo cinico e pragmatico come quello di Hollywood.
In tutta la carriera di Rubin l’unica storia felice era stata proprio “Groundhog Day”. Era stata realizzata vent’anni prima. Quella era la sua storia ed era incredibilmente importante per lui. Una sceneggiatura non può vivere da sola. Non è un romanzo. Ha bisogno di essere realizzata per poter avere un senso. E quella era l’unica creatura, realmente sua, che fosse riuscito a far nascere. Per questo non l’avrebbe mai affidata a nessuno.
Così iniziarono a corteggiarlo. Con molto tatto. Warchus accompagnò Rubin a Londra per vedere “Matilda”. Poi lui e Minchin iniziarono a collaborare con Rubin al musical, senza chiedere nulla, basando il loro lavoro solo su una semplice stretta di mano. Come ha raccontato la cronista S. I. Rosenbaum, Minchin notò che Rubin a volte tirava fuori un lato sarcastico. Faceva battute poco divertenti. E mostrava frequentemente lampi di pessimismo. Di quelli che si lanciano per non rimanere delusi dagli altri. Per proteggersi. Minchin capì che Rubin era stato ferito per anni, così lo prese da parte e gli chiese di guardarlo negli occhi: “Danny, in futuro la tua storia sarà sul palco. E, naturalmente, tu sarai seduto accanto a me, perché questa è la tua storia. Fidati di me”. Rubin gli credette, allentò i suoi freni e non fece più battute. “Groundhog Day: The Musical” debuttò all’Old Vic Theatre di Londra il 16 agosto del 2016, conquistando critica e pubblico, per poi passare a Broadway l’anno successivo. Per BroadwayWorld fu l’evento teatrale dell’anno. Vinse il Critics’ Circle Theatre Award e il Laurence Olivier Awards per il miglior musical dell’anno. Rubin ricevette anche un paio di candidature ai Tony Award e agli Outer Critics Circle Awards. Seduto tra la folla, come un padre amorevole, vide e rivide ogni sera la sua creatura sul palco, ascoltando le sue parole echeggiare. Ancora e ancora e ancora.
Per lui fu una incredibile rivalsa, soprattutto nei confronti di tutti quegli uomini di Hollywood che gli avevano voltato le spalle. Dopo aver trascorso ventitré anni in isolamento era riuscito a ottenere un’altra possibilità. “A volte penso che abbia visto la storia e adottato un po’ della sua saggezza” – constatò Warchus parlando di Rubin – è come se si fosse lanciato un’ancora di salvezza vent’anni fa”.
L’uomo del tempo
La cosa che mi fa più pensare è che non è stato il cinema a far uscire finalmente una sua storia. Ci ha dovuto pensare il teatro. Un mezzo di espressione basato sulla sua ripetitività. Sul tempo. Rubin ne trascorre molto a pensare. E la gran parte dei suoi pensieri sono dedicati proprio al tempo. In effetti, il tempo e il pensiero (quindi il risultato dell’esercitare la facoltà intellettiva), per sua stessa ammissione, sono le due cose che sente di non avere mai abbastanza. “Se fossi stato più intelligente – ha detto una volta nel 1999 – non avrei dovuto spendere tutto questo tempo a pensare e forse avrei avuto anche del tempo residuo”. Il problema con il suo tipo di intelligenza è che gli sembra di averne abbastanza solo quando ha avuto abbastanza tempo. Ha bisogno di quella quantità in più di tempo per sentirsi intelligente come chiunque altro. È un ragionamento molto onesto. E in quanto tale totalmente logico. È una dinamica direttamente proporzionale nella quale chiunque tra noi può immedesimarsi. Perché nessuno sa o sa fare tutto. E c’è sempre qualcosa nei campi che seguiamo o che siamo costretti a seguire nella quale ci sentiamo indietro, carenti, lenti, o in cui semplicemente abbiamo bisogno dei nostri tempi. Ma Rubin riesce ad andare più a fondo mostrandoci una auto-introspezione che nella sua semplicità si rivela illuminante. “Quando scrivo film, posso impiegare anche fino a tre mesi solo per inventare la cosa più intelligente che un attore può dire o fare in un determinato momento”. In quel secondo di tempo, sullo schermo, il suo personaggio appare geniale e anche il suo creatore. È un concetto elementare, ma è anche una confessione che ci mostra i meccanismi nascosti della sua creatività e del (suo) tempo. Nella realtà infatti le cose non accadrebbero così. “Se James Bond avesse dovuto sedersi per davvero, proprio lì nel casinò, e pensare a una battuta da rivolgere alla bionda con la pelliccia – dice Rubin – non sarebbe stato così spiritoso. Sarebbe sembrato solo un penoso idiota”. Beh, in questo caso, c’è solo una differenza tra un ragazzo sicuro di sé e un idiota: il tempo.
Questa confessione mi suggerisce un altro ragionamento. Dal mio fallace punto di vista il film non può rappresentare una metafora buonista né farsi portatore di una morale ottimistica. Diversamente dalle narrazioni legate ai viaggi nel tempo (come quelle su un passato da cambiare che ho citato a proposito dell’episodio dei “Simpson”, dei “Confini della realtà”, di “Quantum Leap” o di “Ritorno al futuro”), le esperienze di Phil non lasciano conseguenze. Il suo personaggio vive una completa anarchia temporale, totalmente priva di effetti. Dopo una prima fase di libertà sfrenata (spaziante dai vizi al nichilismo), questa diventa poi costruttiva, permettendogli così di raggiungere quello che più desidera e assecondando la tipica morale edificatoria americana (elemento indispensabile in qualunque commedia che si rispetti). Ma è proprio da questo punto di vista che, secondo me, il film presenta il suo insegnamento pessimista. Infatti, solo viaggiando, per un tempo imprecisato ma comunque lunghissimo, nel periodo ipotetico dell’irrealtà Phil è riuscito a ottenere ciò che altrimenti – muovendosi in una realtà temporale lineare – non avrebbe mai raggiunto. Quel tempo che si incanta come una puntina sulla stessa strofa (che naturalmente non potrà che essere: “They say we’re young/and we don’t know/We won’t find out until we grow/Well I don’t know if all that’s true/‘Cause you got me, and baby I got you babe/I got you babe/ I got you babe”) si rivela il miglior alleato di Phil. E questo ci è stato raccontato così bene perché era esattamente ciò che provava Rubin quando scriveva le brillanti battute di Phil costruendole a tavolino dopo mesi e mesi di sedute, ragionamenti e tentativi.
Tra le tante sceneggiature che ha scritto ce ne sono un paio che spera di vedere realizzate. Inevitabilmente entrambe hanno a che fare con il tempo. La prima è una versione occidentale di Sheherazade (“The Hanging Tale”): a un uomo sul punto di essere impiccato chiedono le ultime parole. Lui comincia a raccontare una storia piena di avventure, quando arriva la notte ed è ancora lì in piedi con il cappio intorno al collo gli domandano: “E poi?”. Così rimandano l’impiccagione di un giorno, poi di un altro e di un altro ancora. Finché sarà la sua stessa storia a trasmettere il senso della compassione ai suoi interlocutori inducendoli a lasciarlo andare. La seconda (“Martian Time”) riguarda una creatura di un altro pianeta che viene sulla terra. A prima vista sembra un terrestre ma poi si scopre che è differente. Perché il suo senso del tempo è totalmente diverso da quello di tutti gli altri. “Potrebbe essere davvero bello. Ci ho lavorato sopra per tre anni. Quando uscirà, la gente penserà che sono un genio”. Bene, forse lo è. Ma, come ci ha spiegato, ci vuole molto tempo per diventarlo. E come ha insegnato la sua vicenda, quando sarà, per apprezzarlo ce ne occorrerà molto anche a noi. Di tempo.
Penso che la storia di Rubin sia davvero singolare. È quella di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle un loop esistenziale. Ha passato il tempo pensando al tempo, incantando tutta la sua vita su un solo film che verteva sul loop di un uomo che incantava la sua vita su un solo giorno, quel giorno che lui, Rubin, dopo il film, avrebbe vissuto continuamente, parlando tutti i giorni delle stesse cose e venendo ricordato sempre per quell’unico colpo legato a lui. E come se non bastasse già la vertigine di questa spirale escheriana, l’incanto si sarebbe interrotto solo in favore di un secondo loop, quello teatrale, dove Phil, pur beandosi della sua nuova vita (e di un suo progetto finalmente andato in porto) avrebbe letteralmente seguito e rivissuto la sua storia, giorno dopo giorno, seduto sulle poltrone dei teatri (come gli aveva predetto Minchin) ascoltando quelle stesse battute che aveva scritto per la prima volta su un portatile Toshiba quando era un trentenne in cerca di un vero biglietto magico.
È incredibile, ma proprio da una poltrona era nato tutto. Su quella (di un cinema) aveva iniziato a creare, su questa, ora, si godeva ciò che aveva realizzato. Lui (Rubin), la sua storia (“Groundhog Day”) e il suo personaggio (Phil) nel tempo sono divenuti realmente un’unica cosa, perché hanno condiviso totalmente il loro comune destino. Quello di un successo ottenuto solo grazie al tempo. Rubin del tempo ne ha avuto un bisogno folle. Per guadagnarsi la gloria ha dovuto vivere più vite e per ri-vivere ciò che aveva vissuto ha dovuto ri-vivere nuovamente una storia di ri-viventi. Facendolo sapeva già che sarebbe stato considerato (o condannato a essere) per sempre “solo” il ragazzo che ha scritto “Groundhog Day”. Ma forse è questo il segreto dell’eterna giovinezza. E quando la ottieni significa solo una cosa: che sei riuscito a fermare il tempo.