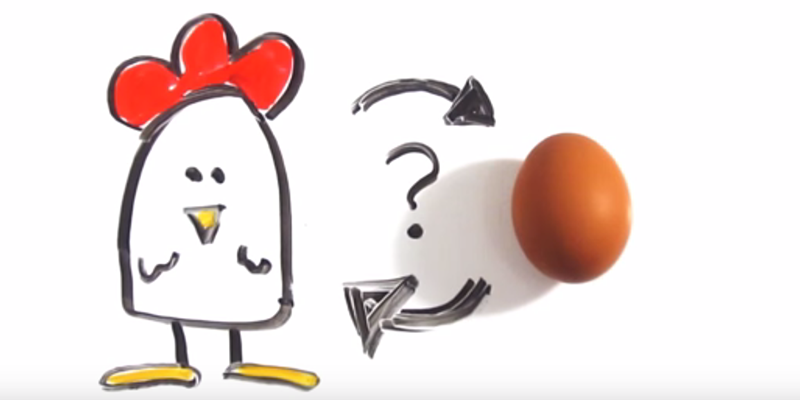Caro Roberto Saviano
Caro Roberto Saviano,
il tuo racconto sulla macchina del fango che non risparmiò Giovanni Falcone, lunedì sera, era infarcito di omissioni: nel senso, proprio, di nomi che non hai fatto o hai preferito non fare. Per farli hai avuto a disposizione una clamorosa mezz’ora televisiva, quindi è stata una scelta deliberata. E a me spiace, sia perché sono uno dei pochi che ti difende – da queste parti – sia perché in questo modo si accredita chi dice che il tuo punto debole sia un certo paraculismo: non una tendenza vera e propria all’intruppamento nella sinistra politically correct – quella no – ma quantomeno una propensione a non fartela nemica. Dalle parti di certi sancta sanctorum, diciamo così, il passo ogni tanto ti si fa felpato.
Tu hai parlato subito dell’Addaura, cioè un primo e sottovalutato attentato a Falcone: era il 20 luglio 1989 e il magistrato si trovava nella sua casa al mare, presa in affitto, in compagnia dei colleghi svizzeri Carla Del Ponte e Claudio Lehman, impegnati in un’inchiesta sul narcotraffico che tu hai definito «riciclaggio». Hai detto che «tutti, a destra e sinistra» fecero capire che Falcone quella bomba poteva essersela messa da solo. Ma non è preciso. Gerardo Chiaromonte, comunista, defunto presidente dell’Antimafia, persona perbene e tu sai perché, scrisse che «i seguaci di Leoluca Orlando sostennero che era stato lo stesso Falcone a organizzare il tutto per farsi pubblicità». In prima fila c’era quella sinistra lì, oltre a il Giornale di Montanelli (dove ai tempi scriveva l’incolpevole Marco Travaglio) e altri personaggi menzionati da una sentenza della Cassazione: tra questi i giudici Domenico Sica, il defunto magistrato Francesco Misiani e il colonnello dei carabinieri Mario Mori, futuro capo del Sisde: chi più e chi meno, misero tutti in dubbio un attentato che in troppi cercarono di derubricare a semplice avvertimento. Già, perché un processo per i fatti dell’Addaura, appunto, c’è già stato, anche se nessuno lo nomina mai: il 19 ottobre 2004 la Cassazione ha confermato condanne a 26 anni per Totò Riina, Salvatore Biondino e Antonino Madonia; 9 anni e 4 mesi per Francesco Onorato e 2 anni e mezzo per Giovanni Battista Ferrante. La Suprema Corte, in 89 pagine, ha pure detto che i servizi segreti non c’entrano niente perché la responsabilità fu di Cosa Nostra, e, come era accaduto in primo e secondo grado, la sentenza ha ricostruito l’attentato nei particolari: lo chiamano «l’infame linciaggio», però adesso quella sentenza andrebbe dimenticata dopo l’annuncio di una nuova e fumosissima inchiesta della Procura di Caltanissetta, subito cavalcata da Repubblica e da Annozero. «Perché», è giunta a chiedersi Repubblica, «le indagini sull’attentato al giudice sono partite con vent’anni di ritardo?». In realtà partirono puntualissime.
Ma dicevamo della macchina del fango: tu, poi, hai parlato del «corvo» che scriveva lettere anonime per danneggiare Falcone, una dinamica che con la macchina del fango in effetti ebbe molto a che fare. Ma la stessa macchina, e tu non l’hai detto, colpì anche più gravemente il magistrato Alberto Di Pisa che fu accusato ingiustamente di essere il corvo: e proprio Giuseppe D’Avanzo, un altro che parla sempre di fango e dintorni, scrisse che «Di Pisa è soltanto un uomo frollato dalla lunga attesa di un pubblico riconoscimento, di popolarità e potere, un piccolo uomo sbriciolato dall’invidia e dalla gelosia, precipitato nel gorgo di un risentito rancore». Perché non ricordarlo? Alberto Di Pisa è stato assolto da ogni accusa: ma la macchina del fango, per lui, non si è fermata mai. Marco Travaglio, ancora nel marzo 2009, definiva Di Pisa nemico acerrimo di Falcone» e tutto perché aveva soffiato il posto di procuratore capo a Marsala – su decisione del Csm – battendo Alfredo Morvillo, amico di Giancarlo Caselli e dello stesso Travaglio.
La macchina del fango, già: hai ricordato quando Falcone accettò l’invito del Guardasigilli Claudio Martelli a dirigere gli Affari penali, quando cioè la gragnuola delle accuse si fece ancora più infame. Il pool di Falcone e Borsellino era stato praticamente cancellato e le istruttorie antimafia erano tornate all’età della pietra. Hai fatto vedere un filmato di una serata di Samarcanda (in abbinata col Maurizio Costanzo Show) ma non hai citato o mostrato la puntata di Samarcanda del 24 maggio 1990, quella in cui Leoluca Orlando disse che Falcone aveva una serie di documenti sui delitti eccellenti ma li teneva chiusi nei cassetti, anzi, in otto scatole chiuse in un armadio. L’accusa verrà ripetuta a ritornello anche da molti uomini del movimento di Orlando, tra i quali l’avvocato Alfredo Galasso. personaggio che tu hai fatto vedere nel filmato, come no, senza neppure spiegare chi era: lo hai soltanto definito «perbene». Ma allora lo erano tutti, perbene. La sinistra in sostanza accusava Falcone di connivenze pericolose solo perché aveva fiutato alcune calunnie del pentito Pellegriti ai danni di Salvo Lima e Giulio Andreotti: l’11 settembre Falcone 1991 dovette addirittura discolparsi davanti al Csm dopo un esposto di Orlando, sodale di Galasso: ma erano persone perbene, giusto? Hai detto che qualcuno definì Falcone «guitto televisivo»: era un giornalista di Repubblica, e allora perché non nominarlo? Ecco la frase precisa, Roberto: «Non si capisce come mai Falcone non abbandoni la magistratura… s’avverte l’eruzione d’una vanità, d’una spinta a descriversi, a celebrarsi, come se ne colgono nelle interviste dei guitti televisivi». Sempre nel filmato con l’avvocato Galasso, poi, Falcone si spingeva a dirsi favorevole alla responsabilità civile dei giudici, eresia per cui oggi qualche deficiente gli attribuirebbe direttamente qualche vicinanza alla P2. E qui capisco che tu abbia preferito trasvolare.
E così hai fatto con tutti gli articoli dell’Unità contro Falcone, titoli come «Falcone superprocuratore? Non può farlo, vi dico perché», scritto dal membro pidiessino del Csm Alessandro Pizzorusso; parlo della stessa Unità che poco tempo prima aveva titolato «Falcone preferì insabbiare tutto». Hai citato le parole dolorose di Ilda Boccassini, e hai fatto bene, ma ne hai menzionato solo una parte. C’erano anche queste: «Avete fatto morire Giovanni Falcone, lo avete fatto morire con la vostra indifferenza… a Palermo non poteva più lavorare, per questo ha scelto la strada del ministero… Lui non voleva essere lasciato solo ed essere… Due mesi fa ero a Palermo in un’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati. Non dimenticherò quel giorno. Le parole più gentili erano queste: Falcone si è venduto al potere politico… L’ultima ingiustizia l’ha subita proprio da voi di Milano… Mi telefonò quel giorno, e mi disse “che tristezza, non si fidano del direttore degli Affari Penali”».
Certo, Roberto, non potevi citare tutto e tutti, lo so. La tv è maledetta, il tempo è sempre poco: e pensa che tu ne hai avuto come nessuno. Il problema è che altri nomi, altri personaggi, altre testate, altri presunti e più recenti macchinatori del fango, tu li hai invece pronunciati o fatti intuire con furba chiarezza. Un filo troppa, secondo me.