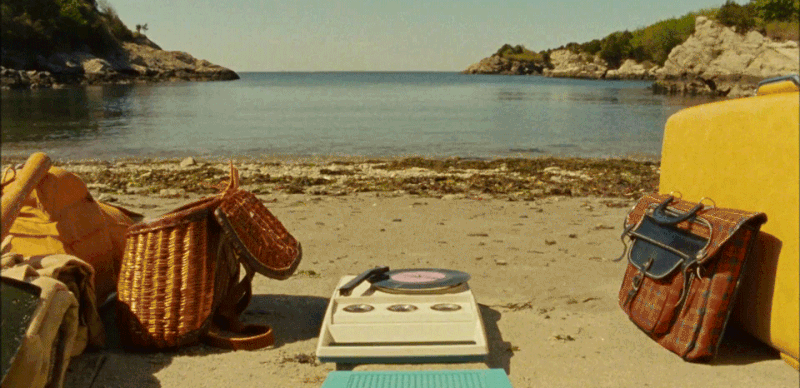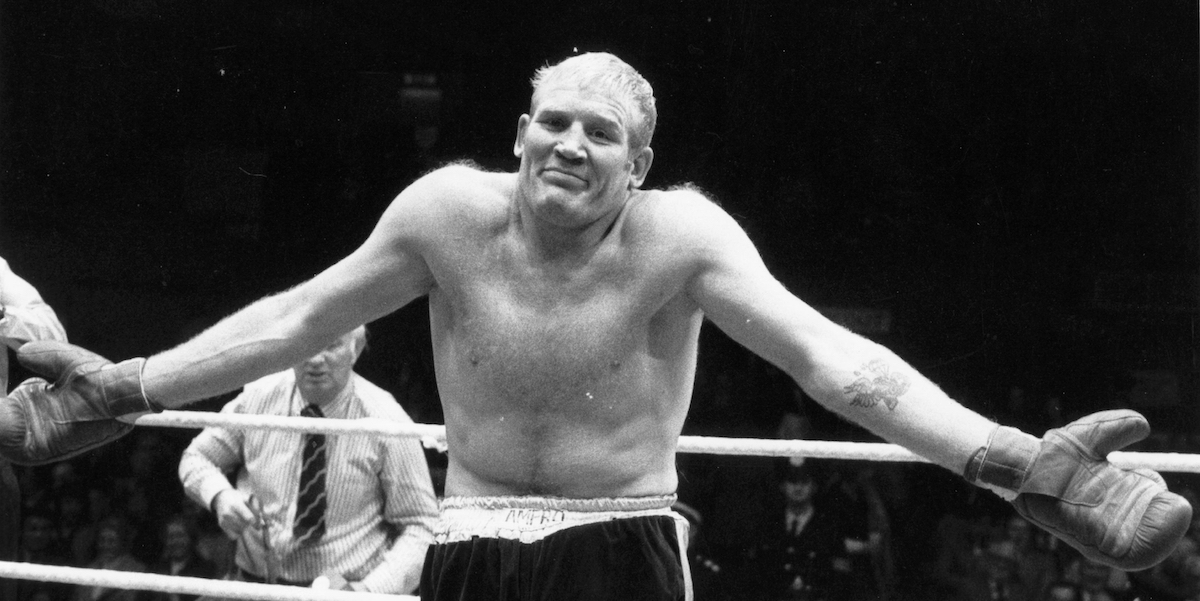L’effetto che “Perfect Days” fa a Tokyo
«È stato un po’ strano guardare il film, che ha tutta l’aria di essere un film d’essai, in un multisala di Shinjuku con Godzilla che sbuca sul tetto. Ma dai primi minuti ho provato una forte nostalgia: la casa abitata dal protagonista è identica a quella in cui ho passato i cinque anni all’inizio della mia vita a Tokyo. Le case costruite in quel periodo e sopravvissute alla modernità sono tutte fatte allo stesso modo, hanno tutte le stesse forniture di serramenti, lavandini, balaustre alle finestre e persino le stesse luci con le cordicelle per accendere e spegnere quando, al mattino, bisogna lavarsi i denti nell’unico lavandino della casa che serve anche da lavello della cucina»

II poster del film Perfect Days è una foto di un uomo sdraiato sul futon, in una camera con il pavimento di tatami, che legge un libro. Vedere questa immagine sul muro di una delle stazioni della metro di Tokyo o nei grandi pannelli sullo spiazzo davanti all’incrocio di Shibuya, quando è uscito il film, faceva un effetto leggermente straniante, come se per un errore fossero stati affissi manifesti di un’altra epoca.
Sono andato a vedere il film poco dopo la fine delle vacanze di capodanno, ho invitato il mio compare di visioni cinematografiche, Naoya, con cui quasi sempre dopo la visione parte una conversazione su quello che abbiamo visto, tradizione rispettata anche stavolta di fronte a un menù completo di cotoletta alla giapponese con riso e insalata.
Naoya non ha ancora trent’anni e comprensibilmente non aveva mai sentito nominare Wim Wenders; in Giappone non è così conosciuto mentre molti che conosco sono entrati in contatto con il cinema di Ozu proprio grazie al suo Tokyo Ga. Naoya è però abbastanza scafato da dirmi, come prima cosa dopo la proiezione: «Sembra che il regista abbia voluto riprodurre l’esperienza della visione di un film di Ozu per un pubblico moderno».
Dai primi minuti il film mi ha procurato una forte nostalgia: la casa abitata dal protagonista è identica a quella in cui ho passato i cinque anni all’inizio della mia vita a Tokyo. Le case costruite in quel periodo e sopravvissute alla modernità sono tutte fatte allo stesso modo, hanno tutte le stesse forniture di serramenti, lavandini, balaustre alle finestre e persino le stesse luci con le cordicelle per accendere e spegnere quando, al mattino, bisogna lavarsi i denti nell’unico lavandino della casa che serve anche da lavello della cucina.
Nel parlare del film non ho troppa paura di rivelare la trama [leggi: di fare spoiler], perché la storia è immersa nella poetica del “non succede niente”, in una combinazione di estetica giapponese e ritmo tedesco del racconto. Il protagonista, il signor Hirayama, è un uomo silenzioso e molto dedito al lavoro, lo sentiamo pronunciare le prime parole del film dopo un quarto d’ora circa, quando parla con un bambino.
Si occupa della pulizia dei gabinetti pubblici fatti costruire dal comune di Shibuya negli ultimi anni in un progetto di riqualificazione urbana della circoscrizione che punta, con l’aiuto degli architetti più famosi del Giappone, ad avere i cessi pubblici più eleganti del mondo e, grazie al lavoro di impiegati come Hirayama san, anche i più puliti e accoglienti.
Alcuni di questi bagni permettono, tramite una connessione bluetooth allo smartphone, di aprire le porte senza toccarle e di scegliere la tonalità delle luci e la musica di sottofondo da ascoltare durante l’utilizzo. Il protagonista fa la spola tra il quartiere dove abita, Asakusa nella circoscrizione di Taitō, e la zona in cui lavora, la più modernizzata Shibuya.
Più che seguire una storia, assistiamo a una vita, o forse al ritmo della stessa, decisamente abitudinario e basato sull’etica del lavoro di Hirayama san, interpretato con grande mestiere da Kōji Yakusho. Il film gioca decisamente sul tempo e in una battuta dei rari dialoghi il protagonista è definito come uno che abita un altro mondo rispetto agli altri, in particolare rispetto alla sorella con cui avrà un incontro rivelatore di traumi passati.
Più che una distanza tra mondi, però, la loro mi sembra una differenza di tempi: Hirayama ascolta la musica sui nastri delle audiocassette, legge i libri di carta, usa un cellulare di quelli pieghevoli, fa un lavoro manuale che non prevede supporti digitali, fotografa e fa stampare la pellicola per poi cestinare gli scatti dopo aver strappato la carta fotografica, va a lavarsi al bagno pubblico.
– Leggi anche: I bagni pubblici di Tokyo così speciali da farci un film
Un’altra particolarità, mi fa notare Naoya, è che è piuttosto raro spostarsi a Tokyo in macchina, e questo pone l’uomo in una bolla separata dal ritmo di marcia del resto della città, ma gli permette di ascoltare i vecchi successi degli anni settanta sull’autoradio.
Ho letto da qualche parte che la proverbiale puntualità dei giapponesi è nata con l’introduzione dei treni e delle ferrovie: i rigidi orari di partenza e arrivo hanno impedito di trovare scuse per i ritardi e così il tempo, da arbitrario e approssimativo, è diventato assoluto e inflessibile per tutti. Il tempo che scorre nel film cambia le cose e i rapporti in modo lento, impercettibile, come le piante annaffiate con dedizione che crescono giorno per giorno senza farsi notare nei vasi di casa.
È stato un po’ strano guardare Perfect Days, che ha tutta l’aria di essere un film d’essai, in un multisala di Shinjuku con Godzilla che sbuca sul tetto. In generale l’esperienza è stata piacevole, ma alcuni elementi mi hanno distratto dal piacere di godermi la credibilità dal film. La recitazione di alcuni personaggi mi è parsa completamente fuori registro, in particolare il giovane collega di Hirayama sembra appartenere a un altro genere di film.
Il suo tono è quello di un personaggio comico che potrebbe comparire in un dorama, uno degli sceneggiati giapponesi che aggiungono il segmento umoristico affidandolo a un caratterista che aggiunge un po’ di allegria alle scene. È come una maschera, che nei film europei non si vede mai, a meno che non si tratti di un film comico o farsesco; per me è stato un po’ come se in un film di Nanni Moretti ci fosse una macchietta affidata a comici come Gabriele Cirilli o Martufello non reinventati in chiave drammatica.
Anche la descrizione della distanza esistenziale tra Asakusa e Shibuya mi è sembrata un po’ troppo caricata: l’immagine di un quartiere tradizionale vibrante e accogliente, con gestori di bar che fanno cerimonie all’arrivo dei clienti o libraie chiacchierone è piuttosto tirata per i capelli e direi oleografica. E qui forse ho percepito il grosso distacco tra il film di Wenders e quelli di Ozu sensei (se volete mostrare rispetto verso un maestro, in giapponese potete usare la parola sensei – maestro, appunto – al posto di san. Attenzione però, vi porrete subito nella posizione di adepti quindi scegliete bene i vostri maestri).
Come si capisce benissimo nel primo documentario di Wenders dedicato a questa città, Tokyo Ga, la realtà, nei film di Ozu, non ha bisogno di essere esagerata, non ci sono messaggi nostalgici troppo espliciti e nemmeno personaggi che vivono fuori dal tempo, anche se chiaramente non manca la descrizione delle distanze tra persone, specie se appartenenti a generazioni diverse.
Per un certo periodo, quando abitavo nella casa simile a quella di Hirayama di cui dicevo, anche io mi sono spostato quotidianamente dalla circoscrizione di Taitō ku, dove si trova Asakusa, e Ginza, dove lavoravo, una zona decisamente più elegante e attenta alla moda. All’inizio prendevo, come tutti, la metropolitana, poi ho comprato una vecchia Vespa 50s che, con la complicità del portiere del palazzo dove lavoravo, lasciavo sul marciapiede con la promessa che lui mi avrebbe chiamato in caso di arrivo dei vigili.
Una caratteristica tipica di Tokyo è la distanza quasi epocale tra i suoi diversi quartieri, vicini e facili da raggiungere quanto caratterizzati da atmosfere diversissime. Oggi questa varietà si è ridotta di molto, la forma della città si è uniformata e all’emergere dalle stazioni della metro non si ha più quella sensazione di smarrimento, quasi si fosse capitati in una dimensione parallela.
L’ultimo film di Miyazaki, in lingua originale, ha il titolo di un libro (Kimi tachi wa dou ikiru ka – Voi come vivete?) e anche in Perfect Days c’è un riferimento per bibliofili. Dietro consiglio della libraia, Hirayama compra un libro della scrittrice Aya Kōda, quasi sconosciuta fuori dal Giappone e autrice di molte opere autobiografiche in cui è presente il padre, un celebre romanziere nato alla fine dell’Ottocento. La scelta di citare questa autrice fa pensare a un omaggio sia alla città di Tokyo, di cui è originaria la famiglia Kōda, sia alla visione di questa donna sulle relazioni tra i membri di una famiglia. Inoltre il libro comprato e letto nel film si intitola “ki”, lo si intravede dalla copertina in cui appare la parola che significa albero, uno dei caratteri più semplici che i giapponesi imparano nel primo anno delle elementari.
– Leggi anche: Al cinema per l’ultimo film di Miyazaki
L’impressione che ci fossero dei problemi di recitazione ha trovato d’accordo me, Naoya e altri amici giapponesi che avevano visto il film e con cui ho discusso nei giorni successivi. Mi è però piaciuto che il film di Wenders presenti un campionario di figure femminili molto interessanti: c’è la ōkami (padrona del locale dove andare a bere), la nipote del protagonista, l’impiegata che pranza solitaria sulle panchine al parco, la commessa, la ragazza che lavora probabilmente in un girls’ bar da quattro soldi in cui cerca di trascinare il ragazzo a cui piace.
Il racconto e il montaggio sono scanditi su un ritmo che a me è parso molto più tedesco che giapponese, se posso generalizzare per nazionalità. La visione potrebbe quindi stancare chi si aspetta colpi di scena o eventi inaspettati, ma in generale funziona anche perché, forse, vuole far capire che la vita non è altro che tutto quello che succede “Im Lauf der Zeit” (Nel corso del tempo).
Nell’ultima inquadratura una didascalia spiega che la parola komorebi (la luce che filtra dalle foglie degli alberi) esiste solo in giapponese ed è vero, ma si usa più nei libri che spiegano la cultura giapponese agli stranieri che nelle conversazioni tra giapponesi.