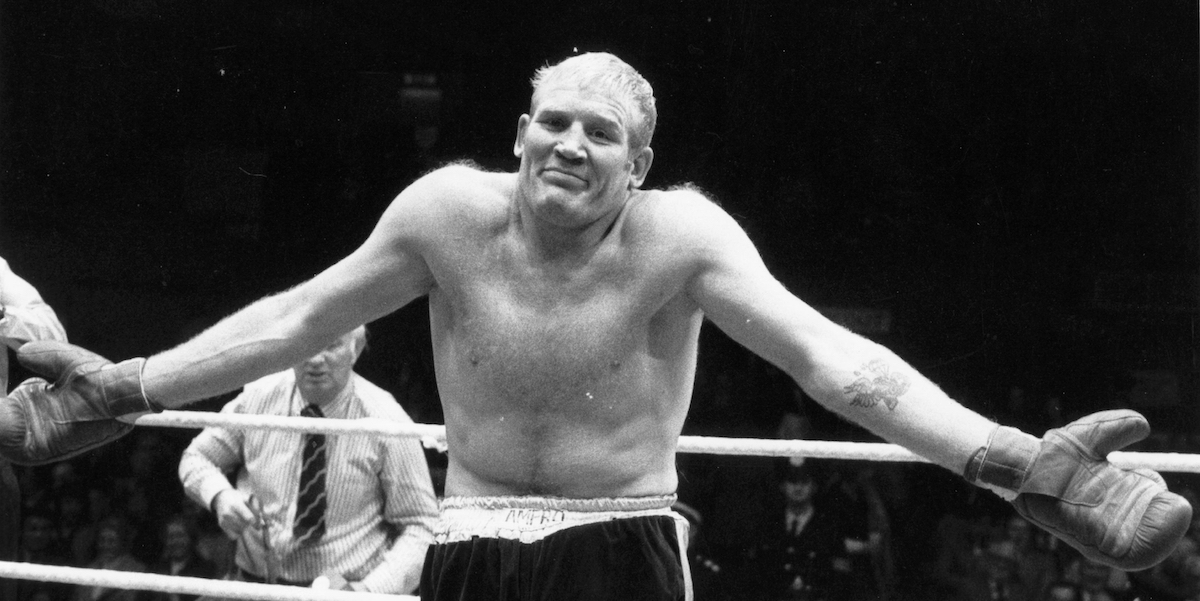Il maschilismo pop
«Non ho mai discusso con i miei amici dell’evidente sessismo a cui anche la nostra formazione musicale, tra sentimentalismi e ironie, ci ha abituato, stillandoci in un siero incolore i costituenti elementari: da un’idea di sessualità maschile tanto più virile quanto più incontrollabile e persino violenta. Non ne ho mai discusso perché per molti di loro, e certamente anche per me, questo non è mai stato un problema»

Qualche settimana fa un mio amico ha condiviso online un pezzo, Rapput di Claudio Bisio e Rocco Tanica, una hit del 1991, commentando «l’anno che secondo non pochi gruppi d’opinione sarebbe l’ultimo in cui siamo stati veramente felici». Avevo sedici anni nel 1991 e non mi ricordo se fossi felice, sicuramente sapevo a memoria Rapput, anche perché fu il singolo più venduto di quell’anno; imparai bene il testo scioglilingua per cantarla a squarciagola tutta l’estate con i miei amici, cazzoni, nerd, fan di Elio e le storie tese, molti cominciavano a strimpellare e formare band.
Nei versi che, mi sono reso conto, potrei ricordare ancora oggi, ce ne sono diversi tipo questi: «Poi ’sti pescatori greci non potrebbero pescare in altomare / E impiccarsi con le reti senza andare a importunare le ragazze / Come te che normalmente sono brave / Ma travolte dagli eventi non disdegnano di fare la puttana», oppure «Il mio amore, sì il mio amore, / nonostante qualche dissapore, / Come una libellula selvaggia io sorvolerei, / però dimmi cos’hai fatto con il greco sulla spiaggia./ Senza fiato, senza bronco / Tu sei ritornata, ma ti stronco / Se ti lascio in faccia i segni del saldatore so che capirai».
Tra le altre hit di quella mia adolescenza fine anni Ottanta inizio anni Novanta ce ne sono altre che potrei canticchiare facilmente. Per esempio Jovanotti che in La mia moto (1989) dice: «Lei non è mai gelosa / Non è mai preoccupata / Per essere sorridente / Basta una lucidata» o «Sei come la mia moto / Sei proprio come lei / Andiamo a farci un giro / Fossi in te io ci starei»; oppure Raf, sempre 1989, che in Ti pretendo canta: «Se tu mi guardi non rispondo / Davvero non rispondo di me, io non ti voglio / Ti pretendo, è inutile che dici di no / Io questo amore lo pretendo / Sei l’unico diritto, l’unico diritto che ho», o Vasco Rossi che in Delusa (1993) commenta così quell’educazione vouyeristica di massa che è stata Non è la Rai: «Sei tu che quando balli così mi vuoi provocare / E lo sai cos’è che scateni tu dentro di me / E sì, continua pure così, che vai bene / E lo sai, ti dirò sempre di sì, io muoio per te / Sei tu che quando balli così in televisione / Chissà com’è orgoglioso di te tuo papà / E sì che il gioco è bello così, solo guardare / Però quel Boncompagni lì secondo me…»; o Voglio una donna con cui Roberto Vecchioni vinse da outsider il Festivalbar del 1992: «Prendila te quella col cervello / Che s’innamori di te quella che fa carriera / Quella col pisello e la bandiera nera / La cantatrice calva e la barricadera / Che non c’e mai la sera», oppure «Prendila te la signorina Rambo / Che s’innamori di te ’sta specie di canguro».
Come per tutta la mia generazione, la mia educazione pop è stata altrettanto se non più importante di quella scolastica: la musica, la televisione, la comicità, il cinema, i fumetti erano il modo in cui si diventava grandi. Per questo a risentire Rapput, La mia moto, Delusa, Voglio una donna, si prova una sensazione strana. Lo vogliamo chiamare imbarazzo? Una singolare forma di cringeness per cui ci si vergogna dell’imbarazzo che non abbiamo provato?
Non ho mai discusso con i miei amici dell’evidente sessismo a cui anche la nostra formazione musicale pop, tra sentimentalismi e ironie, ci ha abituato, stillandoci in un siero incolore i costituenti elementari: da un’idea di sessualità maschile tanto più virile quanto più incontrollabile e persino violenta («Quando mi guardi così / io non rispondo di me», «È inutile che dici di no / Stavolta a compromessi non scendo»); al doppio standard, per cui se un uomo va in vacanza e si scopa tutta l’isola è un grande fico, se lo fa lei diventa una puttana anche se di norma è una brava ragazza; fino alla riproduzione del tabù della sessualità femminile attiva.
Non ne ho mai discusso con i miei amici forse anche perché per molti di loro, e certamente anche per me, questo non è mai stato un problema. Molti direbbero, anche io l’ho evidentemente pensato, che le invettive di Rapput sono talmente parossistiche che fanno ridere proprio per quello, e che «sta specie di canguro» è messa lì da Vecchioni solo per far rima con «tenere come un muro» due versi dopo, o che semplicemente Elio e le storie tese o Vasco non si toccano.
Ho provato a entrare nel merito della questione nelle ultime settimane, proprio a partire da quel Rapput buttato lì, in una bolla composta di persone che in continuazione e con puntiglio si interrogano sulle più disparate questioni dei consumi culturali e dell’immaginario. L’esito è stato piuttosto significativo: una polarizzazione di genere netta.
Gli uomini hanno detto: fa ridere, non c’è niente di male né nel testo né nel successo, l’oggetto è colui che canta ovvero si ride del disagio del cornuto più che del dileggio verso di lei, il ragazzo cornuto e sedicente violento fa ridere proprio perché il mio percorso esistenziale e intellettuale mi ha portato a essere in grado di apprezzare l’efficacia dei testi nella consapevolezza dei contesti, è una parodia del rap ed il rap utilizza quasi esclusivamente questi “argomenti”, state davvero diventando calvinisti e coi calvinisti non si ragiona, eravamo felici sì poi è arrivato Di Pietro, e poi: è ironia, è un rovesciamento, la cancel culture, i layer, etc… Le donne hanno commentato: faceva cagare allora, fa cagare adesso.
L’esempio di questa discussione su Rapput è paradigmatico. Il confronto sulla questione maschile da parte dei maschi avviene poco (per niente) nel discorso pubblico, e quando (se) avviene sembra non riuscire a avere categorie efficaci per portarla da qualche parte. Questo, ovviamente, mi riguarda: il partire da sé rischia di essere una balbuzie e in questo senso un’ammissione.
La domanda resta lì, più imbarazzante che aperta: quanto è ancora confusa la consapevolezza di cosa anche queste tracce abbiano prodotto nella crescita estetica, morale, di genere, relazionale mia e della mia generazione?
Se vogliamo essere onesti, occorre almeno porsi un dubbio radicale: alle volte non sembra che quella l’ideologia di base, quel senso di appartenenza, quel bagaglio culturale minimo in cui ci riconosciamo noi maschi adulti italiani anche over 40, over 50, culturalmente emancipati, consapevoli, mescoli a un adolescenzialismo interminato, un malcelato cameratismo da gita del liceo e quella che potremmo definire una vera e propria cultura incel? E, in più, che questi sentimenti siano stati generati e vengano riprodotti di continuo da questo genere di consumi?
Di certo questa mancata problematizzazione ha, come minimo, avuto come effetto l’indulgenza plenaria sulla permanenza di questo maschilismo nella musica contemporanea italiana. Due anni fa è uscito, per un piccolo editore, Prospero, un libro che anche se poco strutturato nella teoria prova almeno a descrivere proprio questa mappa molto estesa di tracce di Maschilismo orecchiabile, come recita il titolo: orecchiabile e al tempo stesso brutale, irricevibile, inascoltabile, eppure così diffuso nelle canzonette, nel pop italiano. L’autore, Riccardo Burgazzi, passa al vaglio più di un centinaio di testi, dai Pooh a Lucio Battisti alla trap. Il canone maschilista ne risulta in definitiva quasi indistinguibile dal canone della musica leggera italiana, quello che cantiamo a un compleanno al karaoke o con la chitarra d’estate.
Se vogliamo invece analizzare come funziona la relazione tra produzione musicale, creazione di stereotipi sessisti e legittimazione poetica della violenza di genere, possiamo leggerci Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale, dove Elisa Giomi e Sveva Magaraggia usano anche loro un repertorio che va da Battisti a Emis Killa per mostrare come permangano e ricorrano di generazione in generazione, dal cantautorato alla trap, alcuni stilemi sessisti, spesso violenti; e come dall’altra parte la retorica maschilista si aggiorni per contrasto all’emancipazione femminista, passando dal paternalismo romanticheggiante allo slut shaming esplicito.
Ancora più interessante è notare come, sempre negli anni tra fine Ottanta e Novanta, questo immaginario pop abbia definito anche il punto di vista femminile, per cui, per esempio, in una canzone bandiera come Quello che le donne non dicono (1988, Fiorella Mannoia canta su testo di Enrico Ruggeri) «emerge una costruzione altrettanto aberrante ma esattamente speculare: saper sopportare il comportamento poco rispettoso del partner è, per le donne, testimonianza della propria forza. Nonostante tutte le scorrettezze “nelle sere tempestose / portaci delle rose / nuove cose / ti diremo ancora un altro sì!”».
Queste mappe illuminano anche un’altra questione: quanto la struttura – il sistema dell’industria musicale – incide sulla sovrastruttura – l’immaginario delle canzoni? Possiamo riconoscere allora come non si tratti soltanto di una visione maschilista ingombrante nei ritornelli che ci restano in testa, ma anche dello sproporzionato gender gap nella musica italiana che ascoltiamo. (Tenendo conto che affrontare questo nodo, ovviamente, potrebbe influire positivamente sui contesti, ma non risolvere le molte questioni che riguardano la cultura sessista della musica pop).
Sulla rivista inGenere si può trovare un piccolo speciale di approfondimento sulle donne nell’industria discografica.
Tra le molte cifre e riflessioni c’è anche una citazione del rapporto 2020 dell’Imaie, l’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, che in un’analisi di lungo periodo mette in luce come, nel contesto italiano, su 389.219 registrazioni musicali considerate, le donne hanno ricoperto 56.618 incarichi da comprimari, con una percentuale pari al 9,42%, a fronte dei 544.694 di comprimari maschili, corrispondenti al 90,58%. 71.105 (8,32%) sono invece le posizioni primarie ricoperte da donne e 783.539 (91,68%) quelle ricoperte da uomini.
Oggi sta mutando il contesto, o il pop italiano è ancora profondamente maschilista come quello che ascoltavo tra la fine del liceo e l’università?
Ma anche se le cose stessero cambiando in meglio (è così?), occorre non eludere la domanda che ci siamo fatti in precedenza e che è fondamentale nel momento in cui si passa dall’essere semplici ragazzini consumatori a adulti che orientano, educano, discutono di e realizzano prodotti culturali: che genere di maschilismo è quello con cui la mia generazione è cresciuta? Nell’apparente innocuità, in quella cosiddetta goliardia (ossia in quel fraintendimento culturale in cui la violenza o il sessismo vengono spacciate per divertimento) c’è un elemento che potremmo definire di backlash. Backlash: The Undeclared War Against Women è il libro che la scrittrice statunitense Susan Faludi pubblica proprio nel 1991, l’anno di Rapput (in italiano la traduzione intitolata Contrattacco, fuori commercio da tempo, è dell’anno successivo): per backlash intendiamo quei fenomeni di ciclica interruzione e retrocessione rispetto a conquiste e passi avanti compiuti riguardo i generi e l’ordine di genere. È il contrattacco che il patriarcato, l’ideologia maschilista, il sistema di potere maschile muovono proprio quando vengono messi in crisi.
Come accade questo? Se il dibattito femminista nel rock e nel pop nel mondo anglosassone, per esempio, ha ormai una bibliografia sterminata – da poco è uscito per Sur edizioni Un lavoro da donne, nella cui prefazione Claudia Durastanti scrive: «Sono abbastanza certa che quando la magnifica girl in a band Kim Gordon e la scrittrice Sinéad Gleeson hanno deciso di curare un’antologia dedicata a cantanti, giornaliste, compositrici, donne stavano pensando a delle artiste e a delle lavoratrici: come evidenzia già il titolo, l’antologia parla della conquista di uno spazio di autonomia e di riconoscibilità nel mondo della musica» –; in Italia una riflessione sul genere e la musica è legata davvero a una meno che abbozzata presa di coscienza. Così, quando si taccia di maschilismo l’universo musicale italiano, le alzate di spalle si mescolano con gli attacchi, pieni di backlash, espressi in quelle formule note come «non riconoscete l’ironia», «non si può più dire niente», «l’arte non dev’essere libera?», aggiungendo una profluvie di meme e layer che spostano l’oggetto del dibattito ancora prima che venga messo a fuoco.
È andata sempre così? Andrà sempre così?
Poche settimane fa si commemoravano i settanta anni non compiuti di Massimo Troisi. Tra le scene meno ricordate del suo cinema ce n’è una di No, grazie, il caffè mi rende nervoso, in cui il giornalista Michele (Lello Arena) viene spinto dalla sua collega Lisa (Maddalena Crippa) a intervistare il musicista James Senese con domande che lei gli ha preparato, tra cui un paio che riguardano «il rapporto con noi donne». Senese gli risponde malissimo, e Michele-Arena è talmente imbarazzato che vorrebbe nascondersi. Lisa guarda Michele con pietosa commiserazione.
Qualche giorno dopo Troisi si sono commemorati anche gli ottant’anni di Lucio Dalla; e mi sono ricordato di una scena di Borotalco di Carlo Verdone. Ci sono i due protagonisti che fanno un colloquio di lavoro per un posto come rappresentanti porta a porta dell’enciclopedia musicale I colossi della musica. Mentre Nadia (Eleonora Giorgi), sicura di sé, risponde sfrontata alle domande, in un’esaltazione senza mezzi termini della musica di Lucio Dalla, Sergio (Verdone) si arrampica sugli specchi, biascica svarioni, con un’espressione molto simile a quella di Arena con Senese.
Mi sono venute in mente queste due scene quando ho pensato a una cosa che mi aveva detto Carlo Verdone in un’intervista di qualche anno fa. Ricordò l’elemento dirompente che la sua generazione di comici aveva intercettato nelle piazze, nelle assemblee, nei teatri, nelle riviste, nella vita di tutti i giorni. Il femminismo.
Se era vero che nei contesti famigliari e formativi i modelli patriarcali e sessisti fossero ancora dominanti, era anche vero che dopo il femminismo degli anni Settanta non si potevano più raccontare le relazioni nella commedia all’italiana con le allusioni machiste, il cameratismo, l’indulgenza sulla violenza fisica e simbolica, se non rischiando di relegarsi nella cosiddetta commedia sexy se non nel softporno.
La generazione della Smorfia, di Maurizio Nichetti, di Nanni Moretti, dei Giancattivi, aveva a che fare con donne emancipate, autodeterminate, libere, che ridicolizzavano uomini imbelli, incapaci di esprimere il desiderio, mammoni, paralizzati da fisime e da ruoli, incolti, caricaturalmente aggressivi.
Era l’inizio degli anni Ottanta; poi evidentemente qualcosa per molti e per molto tempo è andato storto.