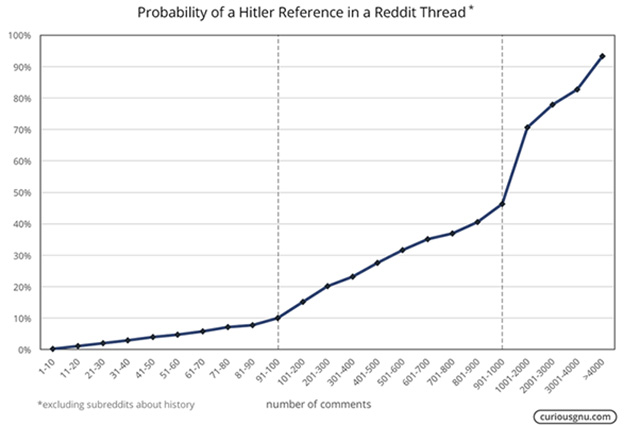Contro i virgolettati a caso
Quando parli con chi lavora nei grandi quotidiani e nei loro siti, e fai presente la questione delle virgolette, in genere alzano gli occhi al cielo. A sentire loro è normale che i nostri quotidiani, in qualsiasi formato, siano pieni di virgolettati che non corrispondono alle parole pronunciate dalla persona cui sono attribuiti. È normale ed è anche giusto, secondo loro, perché non c’è lo spazio, quando si parla si è sempre prolissi, e per rendere le notizie chiare e incisive si deve sintetizzare. Funziona così. La virgoletta assume così un altro significato rispetto a quello originale: segnala con grande concisione che Tizio ha espresso i concetti contenuti nelle virgolette. Li ha espressi con quelle parole? Quasi certamente no, ma a quanto pare non c’è nessun problema.

Eppure esiste, nel mondo delle interviste anglosassoni, una serie di espressioni che da noi non usano. Per esempio “I need a quote” o “Can you rephrase that, please?”: sono le richieste dei giornalisti che hanno la necessità di farsi dare dall’intervistato un virgolettato chiaro e letterale, che in genere stanno anche registrando, da citare nel testo. Se intervisti un inglese o un americano, e magari è stato confuso nell’esposizione oppure ha espresso un concetto importante con una frase di troppo, quando glielo chiedi lui ripete da bravo in modo più chiaro o più conciso. Perché anche lui sa che funziona così: il virgolettato deve uscire dalla sua bocca per finire in pagina. Le virgolette sono uno spazio sacro. E lo sono per diverse ragioni che non sono assolutamente frutto di puntiglio o di “nazismo” formale. Anzi.
Per prima cosa il virgolettato è sacro per ragioni di responsabilità. Se qualcuno dichiara qualsiasi cosa, ed è attribuita a lui, ne risponde. Questo ha un valore sia nel momento della domanda che dopo, e fa sì che le parole vadano dette con più attenzione, scritte con più cura, lette con più interesse.
Se riduciamo all’osso, l’informazione è fatta di tre parti: eventi, dichiarazioni e opinioni. Gli eventi sono opera del giornalista che li racconta e le opinioni sono di chi le esprime. Le dichiarazioni, siano essere raccolte a caldo dopo l’esplosione di una palazzina per una fuga di gas, o pronunciate sul divano da uno scrittore intervistato a casa propria con un gatto in braccio, devono essere riportate fedelmente. È una tutela per tutti: giornalista, intervistato e lettore. Le virgolette indicano il confine tra lo spazio a discrezione del giornalista e quello inviolabile dell’intervistato. La rigidità di questa regola diventa evidente quando qualcuno nel parlare omette di ripetere un elemento della frase: negli articoli degli anglosassoni, se viene aggiunta una parola per rendere la dichiarazione comprensibile, la parola è sempre tra parentesi quadre. Nessuno si preoccupa del fatto che, se si parla di John, tra “John ha rischiato la vita. Siamo felici che sia ancora tra noi” e “[John] ha rischiato la vita. Siamo felici che sia ancora tra noi” non ci sia nessuna differenza. Il punto è un altro. La parola aggiunta va segnalata, le virgolette non sono a senso: sono letterali e non si discute.
L’assenza dell’obbligo di rispettare le virgolette ha un effetto – o viceversa: uovo e gallina – sul sistema della stampa e della politica nel nostro paese. Sui nostri quotidiani pullulano le voci, gli avrebbe detto, i “riferiscono da ambienti vicini al segretario”. Tutte queste cosiddette indiscrezioni costituiscono una porzione importante di quella decina di pagine di politica interna contenuta nei nostri quotidiani ogni giorno. Potrebbero esistere senza i virgolettati, ma ne sono piene. È uno spazio molto consistente, superiore in genere a quello dei quotidiani di altri paesi. Visto il numero di partiti, di portavoce e di leader, forse sarebbe difficile riempire tutto quello spazio appoggiandosi solo al loro contributo ufficiale. E allora la voce di corridoio, la diceria, il “fanno sapere” o il “mal di pancia” servono per costruire una nuvola che sfugge alle categorie note: non è un fatto, non è un’opinione e non è una dichiarazione, ma un misto volatile delle tre. In pratica non si sa cosa sia, ma se la si guarda da vicino sembra abbia una qualche sostanza politica. Uno o due giorni dopo, il corridoio tace, nessuno fa sapere più nulla, le pance sono distese e non dolenti. Il tutto fino al successivo “riferirebbero”. Non sarà che effettivamente questo cincischiare permette di assumersi poche responsabilità, scrivere tanti articoli e andare avanti?
Pensiamo all’atteggiamento dei Cinque Stelle delle ultime settimane, in cui accanto alle scarse o nulle dichiarazioni ufficiali delle figure di spicco (Di Maio, Di Battista, Toninelli etc.) c’erano voci e mezze frasi di “ambienti”, di “esponenti”, di eventuali aree, linee o correnti. Il divieto di dichiarazioni ufficiali veniva aggirato con delle dichiarazioni anonime tra virgolette. È una dinamica che può produrre articoli pieni di citazioni solo quando si è abituati al fatto che le dichiarazioni siano indicazioni o mosse prima che parole. Si arriva così al paradosso per cui il giornalista, per dare peso a una elucubrazione che sta più dalle parti dell’ipotesi che del fatto, usi delle virgolette aggiustando il contenuto. E allora scrive una frase che apparterrebbe a una persona dall’identità più o meno chiara, ma che comunque in quella forma probabilmente non è stata mai pronunciata, che non va nemmeno smentita per essere depotenziata perché quasi non esiste. Possiamo anche fidarci del cronista e delle sua assoluta buona fede, ma nessuno risponderà mai di quelle parole, qualunque cosa siano. In effetti, a pensarci bene, non sono nemmeno parole: sono vapore acqueo, fantasie, momenti che andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
I giornalisti che non scrivono/pretendono virgolettati esatti con paternità non sono disonesti, ma sono funzionali a un sistema di politica e informazione che ha forzato le regole per stare più larghi. Ho il sospetto che questa “comodità” – ribadisco sia la gallina che l’uovo – favorisca un dibattito politico che è tutto volatile, di sponda, anonimo, più simile allo schiaffo del soldato che a un incontro di boxe con avversari che si fronteggiano. E non è solo la politica italiana ad essere così, ma la politica italiana fa fatica a essere altro rispetto a questo.
C’è un’altra ragione per cui il virgolettato è inviolabile, e cioè il fatto che, quando non lo è, la sua elasticità non ha limite. A seconda delle circostanza, il giornalista metterà mano alle parole per trovare una sintesi. E visto che questa sintesi la sta costruendo lui, la costruirà come gli serve. Le parole pronunciate da una persona non sono più un fenomeno come nel giornalismo di cronaca, un fatto incontestabile, la frattura di una gamba, l’esplosione di un tombino: diventano uno spazio disponibile agli aggiustamenti per renderlo più affilato, più efficace. E sulla questione dell’efficacia in contrapposizione con la verità in questi anni ci stiamo giocando tutto. Quando poi il giornalista passa il pezzo alla persona che lo “cucinerà”, che sta in redazione e non va a Montecitorio, che si occupa del confezionamento, le licenze di quest’ultimo saranno ancora più ampie e lontane dalle parole originali. Il risultato in genere è un titolo con virgolette ancora più finemente lavorate al tornio. Può avere un avversativo di troppo, una formulazione più netta, più possibilista, più polemica, il tutto per seguire un ordito che ha senso in quel pezzo, o forse viene dal lontano, o magari è l’unico sbocco interessante per un articolo che altrimenti fa venire il latte alle ginocchia. Ora questo ordito, sia chiaro, è normalissimo che ci sia, è il cuore del giornalismo, nessuno chiede, desidera o pretende che il mestiere di giornalista punti solo a una relazione neutra degli eventi. Ed è anche chiaro che il titolista fa un lavoro che vive di una sua alchimia. Ma se il virgolettato del pezzo è letterale, il titolista non può contraddire apertamente l’articolo: lo può riassumere, può condensare una dichiarazione, evidenziare un passaggio, ma non può spostarsi troppo. Se invece siamo nel mondo delle sintesi efficaci tra virgolette, la libertà è assoluta.
Nel grande dibattito sulle notizie false nel nostro paese non è stato nemmeno sfiorato questo tema. Evidentemente non è considerato un tema centrale. Ma perché negli altri paesi la natura ufficiale e confermata di una dichiarazione ha peso, mentre da noi sembra una sciocchezza accessoria? Perché il modello anglosassone è preso ad esempio così spesso, ma con alcune eccezioni? Questo è un dettaglio che francamente non si capisce. Certo, i problemi sono tantissimi: c’è da fare la seconda domanda, c’è il giornalismo di inchiesta, c’è il quarto potere che non deve essere intimidito, ci sono l’Ordine e il calo delle vendite. Ma vogliamo cominciare dal fatto che quello che è tra virgolette è una citazione letterale delle parole uscite dalla bocca della persona? Non è così difficile. Se qualcuno si dilunga o si confonde, si chiede di ripetere. Oppure si pubblica com’è. O in alternativa si racconta benissimo, senza un virgolettato, ciò che non funziona e non si è potuto avere in un formato migliore. Non è una proposta mia: è come fanno negli altri posti.
Tutto questo solo per il bene della stampa, che al momento sta in una terra di mezzo tra il brio contagioso della spazzatura e l’attendibilità. Ho idea che fare un passo ulteriore nella direzione dell’attendibilità sia un modo per provare ad aumentare la distanza rispetto al ciarpame, e poter continuare a dire, da addetti all’informazione, la frase più sostanziale pronunciata da Rossella O’Hara in Via col vento: “Non soffrirò mai più la fame, né io né la mia famiglia”.
PS – Questa dei virgolettati artistici, desunti, ad minchiam, inventati o come vi pare è una questione delicata. Come molte questioni delicate, ha anche un aspetto piacevole. Ormai io ci ho fatto una malattia. Ormai esaminare gli effetti di questa convenzione mi diverte. Siamo arrivati al punto di produrre virgolettati che hanno la sintassi ellittica dei titoli, e in alcuni casi raggiungono livelli di densità psichedelici. Per esempio questo, preso dal Fatto Quotidiano di qualche giorno fa:

Chi parla? Cosa dice? Perché parla così?! ¯\_(ツ)_/¯
Segnalo anche i virgolettati inventati dentro agli articoli di retroscena, caposaldo del nostro giornalismo politico che vive dell’elasticità di cui sopra. Mi piace molto in particolare quando, a corredo di una spiegazione di strategie e tattiche piena di cognomi, si alleggerisce con – per esempio, che ne so – Martina che dice a Renzi: “Matteo, così non va, non possiamo aspettare. Tocca a noi fare la prima mossa”. C’è sempre il nome proprio, che fa intimo ed evita la ripetizione del cognome, oltre a spiegare bene chi parla. È sostanzialmente teatro.
Per finire, un altro scrigno di meraviglie sono i cosiddetti Q&A, cioè i domanda e risposta senza discorso indiretto, con la domanda in neretto e la risposta in tondo. Lì ci sono due deformazioni buffe. La prima è la consistenza marmorea di quelle interviste limate così tanto da diventare dei vecchi noir: secche, iperconcise, sferzanti, mai un tentennamento, lo storico interpellato sull’ISIS diventa Humphrey Bogart. L’altra è quella in cui le domande sono molto più lunghe delle risposte: ci sono spanne di nero intervallate da due o tre timide righe più chiare. E io mi chiedo sempre se l’intervistato abbia veramente fatto scena quasi muta davanti alle introduzioni chilometriche dell’intervistatore, o se a furia di voler bene alle proprie domande e limare le risposte si sia prodotto questo ribaltamento paradossale.
- Luca Sofri – Quello che sappiamo, lo sappiamo dai titoli