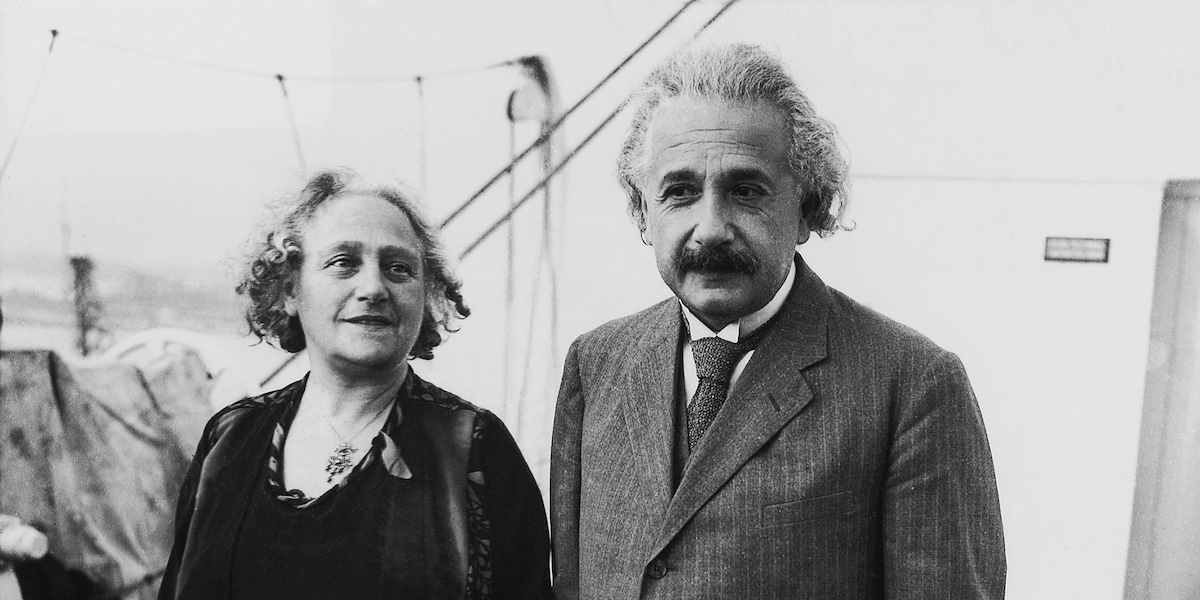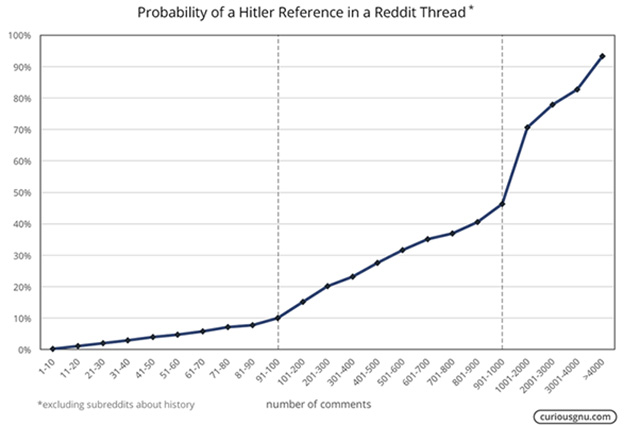«Mi chiamo Khaled e sono un trafficante»
Un trafficante di esseri umani, in Libia: un estratto dal libro della giornalista Francesca Mannocchi, che ne racconta la storia

Negli ultimi anni sono state raccontate centinaia di storie di migranti, persone che hanno deciso di lasciare tutto nel loro paese di origine e provare la pericolosa traversata del Mediterraneo centrale partendo dalla Libia, il paese più instabile di tutto il Nord Africa. Si sono scritti documenti, rapporti e inchieste sulla estesa rete di trafficanti di esseri umani che in Libia gestisce le partenze verso l’Italia, e sulla violenza spesso disumana e gratuita subita dai migranti nei campi di detenzione libici. Si è raccontato poco, però, degli stessi trafficanti.
Francesca Mannocchi – giornalista esperta di Nord Africa e di Medio Oriente e regista insieme ad Alessio Romenzi del documentario ISIS, Tomorrow, presentato alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia – ha scritto un libro facendo parlare uno questi trafficanti, Khaled. La sua è una storia complicata, che si intreccia con i grandi eventi libici degli ultimi anni, dalla rivoluzione del 2011 contro Muammar Gheddafi alla difficile transizione verso qualcosa che doveva essere la libertà, e che invece è diventata una lotta tra milizie per il potere e per i soldi. Mannocchi fa parlare Khaled della sua infanzia e del complicato rapporto col padre – uno di quelli che stanno nella “zona grigia”, e che Khaled individua come il vero male della Libia di oggi – e poi di come sia finito a gestire una sua rete di traffico di esseri umani e del perché, alla fine, si consideri innocente. Il libro si chiama Io Khaled vendo uomini e sono innocente.
***
Ho cominciato a lavorare con Husen il ciccione all’inizio del 2013.
Prima cazzate. Piccoli viaggi spostando i negri di qua e di là. Ero ancora all’università, sì, ingegneria come te, volevo seguire le tue orme, essere l’uomo che volevi essere prima di morire: a essere onesti, tutti in famiglia volevano che fossi come te. Non hanno mai smesso di paragonarmi a te, la tua immagine ha sempre avuto più presenza di me in casa. Tu eri il martire, io il sopravvissuto.
È così che è andata. Husen il ciccione mi ha chiamato un paio di volte, ha a cuore la tua memoria, per quelle due volte che gli hai salvato il culo al fronte. È grasso come un cane grasso e come i cani non dimentica. Mi chiamava: «Organizza il gruppo di eritrei. Vai a prendere i siriani a sud. C’è la guardia del centro di Al Kararim che fa uscire di nascosto trenta negri stanotte, valli a recuperare e portarli a Garabulli».
E più viaggi e più soldi. Soldi e armi, negri e soldi, negri e armi.
Ci servono i soldi per pagare gli uomini, per corrompere i funzionari, per comprare le barche, per comprare le armi, e abbiamo bisogno degli uomini e delle armi per difendere il nostro territorio per fare piú soldi.
È come una droga Murad.
Era come aver premuto il pulsante di avvio di una macchina, ma poi il pulsante si rompe e tu non puoi fare niente.
Vai avanti e basta. Sempre più persone coinvolte, sempre più armi, sempre più soldi.
L’olio che fa girare la macchina sono i negri. Il vero oro della nostra Libia.
Non posso più fermarmi adesso, so che lo capiresti, mi hai detto di correre, di guardarmi le spalle e rimanere vivo, e continuo a correre da allora. So che ho bisogno di rimanere forte, ho visto cosa fanno ai deboli. E non voglio finire così.
Tutti hanno dimenticato, fratello, ora ci chiamano milizie, dicono che siamo criminali e ci odiano. Dicono che siamo gli ostacoli della democrazia, la minaccia del Paese. Dicono così quelli che non hanno mai sparato un colpo e non sanno nemmeno come è fatto un proiettile. E vogliono consegnare il Paese ai nemici di ieri, a Haftar.
E sono pronti a darci la caccia, Murad.
Non posso più fermarmi adesso, non posso fermarmi perché ho già pagato quello che dovevo.
Ho perso te, ho perso le illusioni.
Mi restano i soldi, nient’altro.
Non mi lamento, non ho rimpianti, fratello mio.
La Libia è una giungla, un mare dove il pesce grande
mangia il piccolo e non è colpa nostra.
È sempre lui, Santana.
Ci ha insegnato la paura e quando lui è morto, il demone che ha lasciato in ognuno di noi è emerso.
Siamo tutti piccoli Santana, tutti piccoli dittatori di noi stessi.
Scuoti la borsa dei roditori
Una volta, durante la rivoluzione, ho chiesto ad Abidi come era stato possibile per Gheddafi mantenere il potere così tanto tempo.
«Se c’era tutta quella gente in strada a protestare e combattere, – gli ho detto, – non aveva il consenso che voleva farci credere».
Era solo la paura a tenere la gente addormentata?
E lui, Abidi, mi ha citato un detto popolare beduino. Dice che se hai una borsa di topi e vuoi impedire ai roditori di scappare, devi continuare a scuotere la borsa. Queste parole descrivono la Libia, mi aveva detto. Quello che teneva la borsa era Santana e i topi eravamo tutti noi. Noi libici, chiusi dentro la busta di Gheddafi.
In effetti era così che funzionava: appena qualcuno stabiliva un po’ di potere, anche il più piccolo, in un ufficio, un ministero, un villaggio, una municipalità, Gheddafi spostava le cose, spostava le persone, annullava i poteri.
Così dominava la Libia, e restava al suo posto, muovendo le pedine in una partita a scacchi che è durata quarantadue anni.
Gli dai una mano e si prendono il braccio. Devo imparare anche io. Se avessi imparato prima, quel coglione di Ahmed non mi avrebbe ingannato. Tutti uguali, prima vengono a piangere miseria e poi cercano il modo di rubare. Anche lui la stessa lagna, «Khaled ti prego, dicono in giro che paghi sempre, lo sanno tutti che con te si lavora bene. Fammi lavorare, faccio il guardiano ai negri, ai negri ci penso io, Khaled, andavamo a scuola insieme, lo sai che di me ti puoi fidare, ho moglie e quattro figli, ho bisogno di qualche dinaro in più, mia moglie sta sempre lí a chiedere e compra questo e compra quello e non ci sono i soldi per tutto. Fammi fare qualcosa».
Morto di fame.
Ma guarda te. Si vedeva già alla scuola secondaria che era più furbo che intelligente. E infatti.
Mi tocca pure sopportare la madre in ginocchio a casa di mia madre a scongiurarla di farlo liberare: «Ti prego, – le dice, – Umm Murad, di’ a tuo figlio di darmelo indietro, vivo o morto».
Forse Ahmed ha imparato a lagnarsi dalla madre.
Non si merita nemmeno un proiettile, questo miserabile. Si merita solo una lezione.
«Ahmed, – gli avevo detto, – devo partire per una settimana, sarò in Turchia. Devo vedere le case, voglio comprarne una». Meglio investirli così i soldi, pensavo. Compro due case, metto da parte qualcosa e smetto. Ahmed lavorava bene, puntuale. Preciso, mica come Ibrahim, che non sa trasportare dieci teste di negri in orario.
Gli avevo detto: «Ahmed, ti lascio le chiavi dei magazzini, mi raccomando. Il tempo è brutto per dieci giorni, questo carico non può partire. Hanno pagato tutti, quindi falli mangiare e lascia stare le donne».
È la mia regola. I ragazzi lo sanno, ma non capiscono, l’unico modo per mantenere l’ordine è minacciarli con la mia punizione. In questo lavoro, l’unico tipo di pubblicità è il passaparola, i negri mi consiglieranno ai loro parenti. Più barche arrivano, più fiducia guadagno, mica mi rovino il nome come Husen, io.
Glielo dico sempre, ai ragazzi: «Io non sono uno dei grandi squali, lavoro quanto mi basta per comprare le case e poi smetto. Se fate i bravi, guadagniamo tutti».
«Insomma, – ho detto, – io parto, però di venerdì restate qui in due, armati, a dormire. Gira voce che la banda di Khoms approfitta sempre del giorno di festa per rapire i negri. Ti chiamo quando torno, se hai bisogno chiama tu. Ma cerca di non avere bisogno, che voglio riposarmi una settimana».
Vado a Istanbul, vedo questo appartamento nel quartiere di Cihangir, carino ma strade troppo strette e troppa confusione, turisti, giovani ubriachi, artisti. Mi annoiano questi rumori, certo la casa era bella spaziosa, tre stanze, un salone, due bagni e anche un garage che lì serve sempre, vicino Taksim, con quel casino. Ma no, troppa confusione.
Allora ne ho visto un altro a Maslak, il quartiere finanziario. Un po’ più piccolo e più costoso ma bello, grandi vetrate, i palazzi alti di fronte, elegante, belle porte. Anche arredato, così mi evito la noia di andare a scegliere i mobili. Tavoli di legno sul terrazzo e c’erano già le piante in salotto e all’esterno. L’agente immobiliare mi ha detto: «È solo o è sposato?» E io ho riso e gli ho detto: «Non mi serve mica la moglie, avete pensato a tutto voi. Porto qui mia madre che cucina e sono a posto». La casa era bella e per come va la lira turca bisognerebbe comprarne tre, mica una. Ho detto: «Ci penso ancora qualche giorno, torno a sbrigare due ultimi affari in Libia e direi che chiudiamo l’acquisto». Ho pensato: Torno in Libia, aspetto le partenze dei due carichi che ho in sospeso, poi riparto per Istanbul e compro.
Devo trasferire i soldi, pensavo, le transazioni in entrata e in uscita dalla Libia sono paralizzate, a meno che non abbia una lettera di credito come fanno i pesci grossi, ma io sono un pesce medio. E loro pagano un prezzo alto per rimanere in cima alla partita. L’ultima guerra a Tripoli, troppo sangue e troppi morti, solo per i soldi. L’ha capito chiunque ormai che non era una guerra per spartirsi le zone di influenza a Tripoli, che era una guerra prima per il denaro che per altro. Tutti, tranne i giornali occidentali che non capiscono mai niente. Scambiano i topi per elefanti.
La Settima brigata ha fatto la guerra alle milizie che controllano le lettere di credito, volevano la loro parte dei soldi. Farli uscire dalla Libia, portare il bottino al sicuro. Ma io sono troppo piccolo per questa roba, i soldi devo spostarli in modo classico, hawala, le transazioni del mercato nero, mando qualcuno con un sacco pieno di soldi al mercato dell’oro di Tripoli, il rivenditore prende la borsa, l’uomo fa una telefonata e qualcuno dall’altra parte del mondo consegna un’altra busta di soldi a me, pratico come un Western Union, ma senza tasse.
Niente tasse, niente sportelli e veloce. Basta una telefonata e tutti sono felici. E io mi compro una casa.
Fahmi potrebbe occuparsene, come ha fatto con l’altro sacco pieno di soldi dal mercato dell’oro, quello per la casa a Tunisi, potremmo fare allo stesso modo, lui si tiene la sua parte e siamo a posto.
Quella casa era proprio un affare per come va l’economia lì, adesso. Non si smette di guadagnare dalle disgrazie degli altri, ho pensato. E ridevo da solo, verso l’aeroporto, in taxi.
Così sono tornato prima senza avvertire nessuno, fammi vedere come se la cavano i ragazzi, mi sono detto. Non mi avevano cercato mai.
Ho parcheggiato, c’era la macchina di Ahmed davanti al capannone e non c’era nessuno fuori. Ho pensato: quel coglione si è fatto ammazzare nel sonno e hanno portato via il carico.
Scendendo dalla macchina ero sicuro che si fossero fatti fottere.
Ma la porta del capannone era chiusa, quella del garage accanto invece, il garage piccolo dove tengo le taniche d’acque e le scorte di cibo, era aperta.
Ho riaperto la macchina, ho preso la pistola e l’ho caricata lentamente, sentivo le urla, ma più che urla era un suono bestiale come quando si sgozza il capretto per l’Eid.
Ero certo che qualcuno avesse ferito Ahmed o uno dei ragazzi, e avesse sbattuto il corpo lì a marcire in attesa che crepasse.
Ho girato intorno al magazzino per vedere se c’erano segni o se c’era qualcuno in giro, e quando sono stato sicuro che non ci fosse nessuno fuori, ho camminato dritto verso il garage, e dalla porta ho visto un negro per terra in ginocchio, mani e piedi legati con una corda. Un fazzoletto intorno alla bocca, era lui che gridava, e c’era Ahmed di spalle con un accendino in una mano e la plastica nell’altra e bruciava la plastica che finiva sulla schiena del negro. E quando la plastica arrivava sulla schiena lui provava a gridare e il grido restava bloccato dal fazzoletto e il suono che usciva era bestiale, proprio come il capretto prima di essere sgozzato.
Ahmed era di spalle a bruciare la plastica e a terra alla sua destra c’erano dei cavi elettrici, le forbici e un bastone. Poi gli ha tolto il fazzoletto e ha cominciato a gridare.
– Come si chiama il frocio di tuo fratello, forza negro, diccelo, che gli mandiamo le foto, vedrai se pagano.
E quello continuava a gridare: – Stop please, stop. Stop. I’ll tell you.
E Ahmed diceva ai ragazzi, ai miei ragazzi: – Forza, fate le foto, una di lato e una davanti –. E quelli facevano le foto.
– Vediamo quanto vale la vita di questo negro, quanto possiamo chiedere al fratellino per non farti crepare? Duemila, tremila dollari?
– Stop, please stop. Give me the phone.
– Ah, finalmente ti sei deciso.
Ahmed ha slegato le mani al negro e quello ha preso il telefono, digitato qualcosa, e il telefono dall’altra parte ha cominciato a squillare.
Ahmed l’ha ripreso in mano e ha afferrato il bastone e una voce maschile ha risposto al telefono e Ahmed ha cominciato a bastonare la schiena del negro e la faccia del negro cadeva a terra e Ahmed lo rialzava tirandolo su dalla corda che teneva legate le mani e lo picchiava e gli dava colpi col bastone e ginocchiate e diceva: – Duemila dollari in due giorni qui, sennò lo ammazzo –. Il telefono era in vivavoce e dall’altra parte si sentiva qualcuno piangere e dire: – Sir, please stop, – e ancora, – Stop please.
– Duemila, tre giorni. Ora ti do indicazioni su come fare, tu prepara i soldi. Senza soldi lui muore. Ti mando anche le foto, così le tieni a mente.
Un altro colpo sulla schiena e ha chiuso la telefonata.
@ 2019 Giulio Einaudi editore s.p.a.