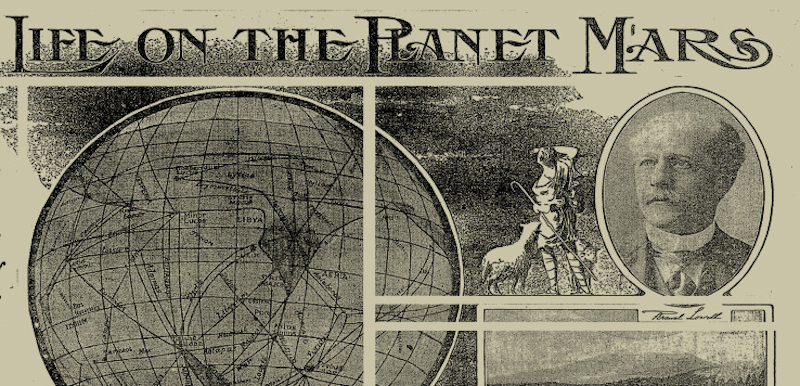Come nacque “Impressioni di settembre”
La storia di una grande canzone italiana raccontata da uno dei suoi autori, Mauro Pagani, nel suo libro "Nove vite e dieci blues"

“Impressioni di settembre”, la celebre canzone della Premiata Forneria Marconi, uscì a ottobre. Era il 1971, e il singolo in cui era contenuta era il primo del gruppo. Fu la prima canzone italiana in cui venne utilizzato il celebre sintetizzatore moog, tra gli strumenti distintivi del rock della fine degli anni Sessanta e dell’inizio dei Settanta, ed ebbe un grande successo fin da subito. Mauro Pagani, membro fondatore del gruppo e co-autore del testo, ha raccontato come nacque nella sua autobiografia, Nove vite e dieci blues, da poco uscita per Bompiani: ne pubblichiamo un estratto.
Lunedì 7 novembre, alle 21, Pagani presenterà il libro insieme al direttore del Post Luca Sofri al Circolo dei lettori di Torino.
***
Nella primavera del 1971 Massimo Bernardi, promoter del Titan Club di Roma e del tour italiano di Jimi Hendrix, ebbe la brillante idea di organizzare un grande evento a Viareggio dedicato alla musica nuova che si stava impossessando della scena italiana. Lo intitolò “Festival di musica di avanguardia e di nuove tendenze”, e ci invitò. Per poter partecipare bisognava presentare un brano inedito. Franco Mussida, che stava attraversando un periodo di grazia, arrivò con un brano nuovo, pensato durante uno dei cento viaggi in furgone di quei giorni e strutturato nottetempo nel bagno di casa. Lo trovammo subito eccezionale, carico di energia ma anche di dolcezza e lirismo; finalmente qualcosa di nuovo, che ci raccontava e ci rappresentava. Subito mi chiusi da qualche parte e scrissi un testo. Erano gli anni dei King Crimson, ma anche dei Genesis, degli Yes, dell’Incredible String Band. Di tutta quella poetica, insomma, in qualche modo legata a William Blake e alla tradizione mistica e onirica inglese, che tanto allora mi ispirava e mi affascinava. Mi inventai Hans, principe dei sogni e dell’inconscio, e gli dedicai la canzone. Con La carrozza di Hans vincemmo il festival a pari merito con gli Osanna e con Mia Martini.
Poco dopo Franco, baciato di nuovo dal buon dio delle canzoni, arrivò con un piccolo, autentico capolavoro, che avrebbe preso il bel titolo di Impressioni di settembre. Quelli della Numero Uno si resero conto che aveva tutte le caratteristiche di un singolo di sicuro successo e decisero saggiamente che forse avremmo avuto bisogno di aiuto per scriverne il testo. Il buon Mariano Rapetti, direttore delle edizioni e socio dell’etichetta, chiese a suo figlio Giulio, in arte Mogol, allora già autore di testi famosi, di darmi una mano.
Così una mattina, lusingato da un lato, preoccupato e innervosito dall’altro, prendo la macchina e mi dirigo verso il Poggio, meraviglioso angolo di Brianza, regno incontrastato della famiglia Rapetti. Ero preoccupato soprattutto perché Mogol era in quegli anni monarca assoluto del mercato, capace di scrivere “Tu chiamale, se vuoi, emozioni”, ma anche, e con il medesimo trasporto, “Non piangere salame dai capelli verderame” oppure “Motocicletta, dieci HP. Tutta cromata, è tua se dici sì”.
Fu un giorno strano, di tante parole dette e troppe non dette.
Giulio mi chiede di raccontargli cosa mi gira per la testa. Tiro fuori il mio taccuino e leggo: di un’alba di settembre che sta per arrivare, del profumo del fieno e del granoturco maturo, del cinguettare delle allodole e degli storni. Del cielo ormai quasi rosa, e del profumo dei gelsi. Dei giorni della mia adolescenza passati a rubare uva e a fare il bagno nelle rogge, dei sogni e dei tormenti che in quei giorni mi bruciano dentro. Del giorno che, a un certo punto, arriva sempre: caldo e luminoso, e benedice tutto. Poi cominciamo a camminare per i bellissimi prati di quel piccolo paradiso, chiacchierando e prendendo appunti. Per la precisione, lui intento a vagare qua e là giocando con le parole, io, solerte e attento, a pochi passi, con il nobilissimo compito di prendere nota.
Che è tutto ciò che feci, travolto da un Giulio al massimo della forma e da quell’irrefrenabile diluvio di rime baciate. In fondo ero solo un ragazzino senza esperienza, che poco sapeva e ancor meno aveva fatto. Non riuscii a far sì che dal nostro incontro nascesse un testo un po’ misterioso, criptico e immaginifico come avrebbero dovuto essere, secondo me e secondo noi, le liriche di una band prog di quegli anni. Ne venne fuori invece un testo semplice, diretto, quasi fanciullesco: facile da comprendere, facilissimo da condividere. Lezione numero uno di quel mattino d’estate: l’impervia strada che conduce al successo nel pop non ama curve e tornanti, predilige i rettilinei. Su di essa è bene correre in avanti, ma non troppo, provare a essere originali se si vuole, ma solo quanto basta, senza esagerare.
La Numero Uno era raggiante. Ci prenotarono uno studio che si chiamava Sax Record dove registrammo il nostro primo singolo, che poco dopo uscì nei negozi: da un lato Impressioni di settembre, dall’altro La carrozza di Hans. I nostri discografici pensavano giustamente che i tempi fossero maturi, ma noi eravamo un po’ scettici. C’era molta attesa: entrare nelle classifiche dei 45 giri avrebbe voluto dire iniziare un tragitto promozionale e di concerti diverso dal nostro, che prevedeva per esempio esibizioni televisive in playback, regola di fatto obbligatoria in tempi nei quali quasi nessuno dei canali televisivi era dotato di attrezzature adeguate e tecnici specializzati per i live. A noi invece interessava comparire nell’altra classifica, quella degli album, che ormai era in netta espansione, dominata da tutti i gruppi stranieri emergenti. Per tutti gli anni sessanta gli artisti italiani pubblicavano periodicamente 45 giri, poi, arrivati al quinto, ne ricavavano un album, che comprendeva tutte e dieci le facciate già pubblicate. Era come provare a rivendere le proprie produzioni una seconda volta: poca spesa, tanta resa. All’estero invece, da anni, quasi tutto funzionava al contrario. Ai singoli toccava il ruolo di apripista: il loro compito principale era quello di promozionare album già concepiti e pensati come tali, spesso nati come veri e propri concept album. In fondo, noi ne avevamo già uno tra le mani. Molti dei testi, infatti, come quello di È festa, erano nati prima della musica, ispirandola.
I pezzi nuovi continuavano ad arrivare, uno dopo l’altro, uno più bello dell’altro. Erano giorni in cui leggevo e rileggevo, leggevo e prendevo appunti. I miei amori prediletti erano Bob Dylan, Pete Sinfield, ma anche Ferlinghetti, Ginsberg, Gregory Corso e tutti gli inarrivabili esponenti, folli, della Beat Generation. Scribacchiavo, parlavo da solo come ai bei tempi e annotavo ogni parola che mi passasse per la mente. Non era facile scrivere testi per la Premiata di quegli anni. Mussida e Premoli componevano (e per anni avrebbero continuato a farlo) divorati da una insopprimibile passione per le tronche e da nessuna attenzione, affetto o almeno comprensione per il mio disperato, quasi patetico, bisogno di piane e sdrucciole. Così era, e così mi doveva andar bene. La melodia originale, regina incontrastata del brano, andava difesa a ogni costo. Per non parlare poi di un’altra loro inclinazione: quella per i testi brevi. È festa? Quattro righe, corte, naturalmente. Buone sì e no per un proverbio, una massima, chessò, un aforisma.
Così decisi di costruirmi uno spazio intorno libero e destrutturato, nel quale riuscire a raccontare almeno un po’ del miscuglio di sogni e desideri che mi accendevano. Spazio che divenne subito terra di conquista del Fuggiasco, che dopo mesi di resa incondizionata aveva ricominciato ad agitarsi. Il passo successivo fu quello di provare a comporre un vero e proprio concept, che contribuisse a dare identità e spessore all’intero album. Una sorta di melting pot di parole e di immagini, nel quale le parti di testo realmente cantate si mescolassero agli appunti, agli schizzi, agli scarabocchi di quei giorni fervidi. Provai a raccontare la storia di un unico, intenso, imperdibile minuto, durante il quale ci fosse concesso di rivisitare ogni cosa, ogni desiderio, ogni sogno. Per poi buttare tutto e ripartire da capo, alla cieca, in volo per chissà dove.
Intanto il singolo continuava a scalare la classifica. Merito del talento compositivo di Franco, ma anche dell’arrangiamento. In particolare, fece la sua parte il suono originale ed evocativo del moog, primo sintetizzatore portatile, trasportabile e di costo accessibile, progettato da quel genio di Robert Moog.
Ogni cosa era al suo posto, scelta con garbo e con impegno. Senza dimenticare il testo, perfetto per il mercato discografico di quegli anni. E di questo umilmente ancora ringrazio. Confesso che, ogni tanto, qualcuna delle surreali visioni che allora mi giravano per la testa ancora oggi torna a svolazzarmi dentro, per prendermi maliziosamente in giro.
Quando il 45 giri arrivò al decimo posto decidemmo che era arrivato il momento di cambiare l’ordine delle cose. Chiedemmo alla Numero Uno (che per fortuna ci ascoltò) di toglierlo dal mercato e in una settimana entrammo in studio per registrare l’album. La sala era davvero bella: la Fonorama, di Carlo Alberto Rossi. Il fonico era Gaetano Ria, che vantava tra l’altro una lunga esperienza di lavoro di cesello negli studi dell’RCA di Roma al fianco di Ennio Morricone. Come produttore venne scelto Claudio Fabi, anche lui proveniente dallo staff dell’RCA, socia della Numero Uno. Avevamo tutti ormai una certa esperienza, ma tutti ci stavamo lanciando in un mondo nuovo e pieno di incognite. Ognuno era tornato a studiare e stava crescendo, noi per primi: Franco Mamone, che vantava ormai una navigata esperienza di locali e balere, ma poco sapeva di discografia; Claudio Fabi, musicista dotato e preparato, ma che poco sapeva di prog; Gaetano Ria, esperto di orchestre e di sale di registrazione e meno di band. Ma fummo tutti bravi. Registrammo, mixammo e consegnammo Storia di un minuto. Anche la copertina, disegnata per noi da Wanda Spinello e da suo marito Caesar Monti, si rivelò azzeccatissima, semplice e insieme immaginifica. Devo ricordare anche il contributo di Marco Damiani, amico e per un po’ coinquilino bresciano, divenuto nel frattempo fidato e insostituibile fonico live del gruppo. Dipinse per noi ad acquerello un bellissimo vascello volante, librato da qualche parte in mezzo al cielo, che fu riprodotto all’interno della copertina apribile.
A un mese esatto dall’uscita dell’album, un pomeriggio ricevo la telefonata dell’amico Paolo Giaccio, giornalista di Roma, che conduceva Per voi giovani, programma radiofonico di punta dei pomeriggi RAI. Sorpreso e persino un po’ commosso, Paolo mi dice che l’indomani, leggendo la classifica della settimana degli album, annuncerà che la Premiata Forneria Marconi è balzata direttamente al primo posto: prima volta per un gruppo nella storia della discografia italiana. Rimango senza parole, poi ringrazio, saluto, e corro a dirlo agli altri.
Per un paio di giorni andammo avanti a festeggiare: in fondo il tutto era cominciato da zero non più di un anno prima. Non potemmo, tra un bicchiere e l’altro, non sganasciarci dal ridere pensando alla faccia antipatica del direttore di sala del Covo di Santa Margherita che cacciava i Quelli, infastidito da così tanto scalmanato rock’n’roll.
Ci trovammo con Franco Mamone, per gli amici “Neddy”, per decidere cosa fosse più giusto fare. Già da qualche mese ci eravamo accorti che le nostre esibizioni continuavano a crescere, per numero e spettatori, al Nord e al Centro. Da Napoli in giù, niente. Il mercato del Sud allora era dominato al novanta per cento dalle feste di piazza: sagre patronali, spesso finanziate da collette e donazioni, organizzate dai comuni, da comitati vari o dalle pro loco. Perlopiù terreno di caccia di quegli artisti che frequentavano Sanremo, i festival, i Dischi per l’estate e rassegne televisive di ogni sorta. Grande assente era il circuito delle balere di grandi dimensioni, che nei fine settimana si trasformavano in vere e proprie sale da concerto, sulle cui piste da ballo migliaia di ragazzi si sedevano ordinati e ben stretti l’un l’altro, per poi tornare a scatenarsi a concerto finito. In alcuni di quei locali, in Emilia e in Romagna soprattutto, tornavamo a suonare sette o otto volte nell’arco dell’anno: tanto era il pubblico, e tanta era la passione.
Franco conosceva due fratelli, i Vernassa, che da anni gestivano il circuito dei teatri meridionali, piccole e medie sale di provincia, dove durante la stagione invernale si esibivano a turno decine di compagnie di prosa e di rivista di ogni stile e livello. Raggiungemmo un accordo per i mesi estivi, durante i quali di solito in teatro non si lavorava; poi ci ingegnammo per trovare soluzioni ai mille problemi e alle mille incognite che l’intera operazione sembrava generare (quanto a incognite eravamo dei veri specialisti!). Problema numero uno: contenere i costi. Molti dei teatri erano piccoli e il loro pubblico era abituato a spendere poco. Decidemmo che due concerti al giorno avrebbero migliorato gli incassi. Équipe tecnica: una sola persona, che montava, smontava, faceva da sound engineer e guidava il furgone. Due facchini sul posto, se possibile tre: che aiutassero a caricare e scaricare il furgone. Per tutto il resto si navigava a vista.
Così riuscimmo a esibirci in quasi tutte le città importanti del Sud. Ne venne fuori una tournée di quarantacinque concerti, mediamente di due ore e mezza l’uno, in venticinque giorni, cambiando città (quindi di fatto debuttando) ogni giorno.
Quasi sempre gli impianti elettrici dei teatri erano antiquati e insufficienti per il consumo della nostra attrezzatura, pensati e costruiti per i quattro faretti che a malapena illuminavano il palco. Questo voleva dire che il nostro fonico, uno scozzese di nome Ivor Burnett, assunto in quanto unico in grado di far funzionare sempre e comunque il mellotron – uno strumento terribilmente delicato con i suoi nastri preincisi, che troppo spesso mal reagiva ai sobbalzi del furgone –, doveva srotolare dal nostro pulmino i duecento metri di cavo trifase che ci eravamo procurati il primo giorno di tour, poi doveva cercare la centralina elettrica più vicina, aprirla, e senza chiedere il permesso a nessuno collegarcisi con grande attenzione e abilità. Ogni tanto qualche tecnico comunale provava a chiederci conto di tutti quei metri di cavo, ma bastava ricordargli che sarebbe toccato a lui comunicare a centinaia di spettatori eccitati l’annullamento del concerto a causa di un’insufficienza elettrica per vederlo sparire nel nulla, secondo la migliore tradizione italiana di quegli anni. Comunque, non successe mai nulla. Ivor, sergente elettricista della fanteria inglese congedato di fresco, sapeva il fatto suo.
Preferivamo viaggiare soli, noi cinque, senza estranei o rompicoglioni in mezzo ai piedi. Forse un aiuto ogni tanto sarebbe servito, ma a noi piaceva così: un po’ allo sbaraglio, solo noi e la nostra amata Citroën Pallas.
© 2022 Giunti Editore S.p.A. / Bompiani