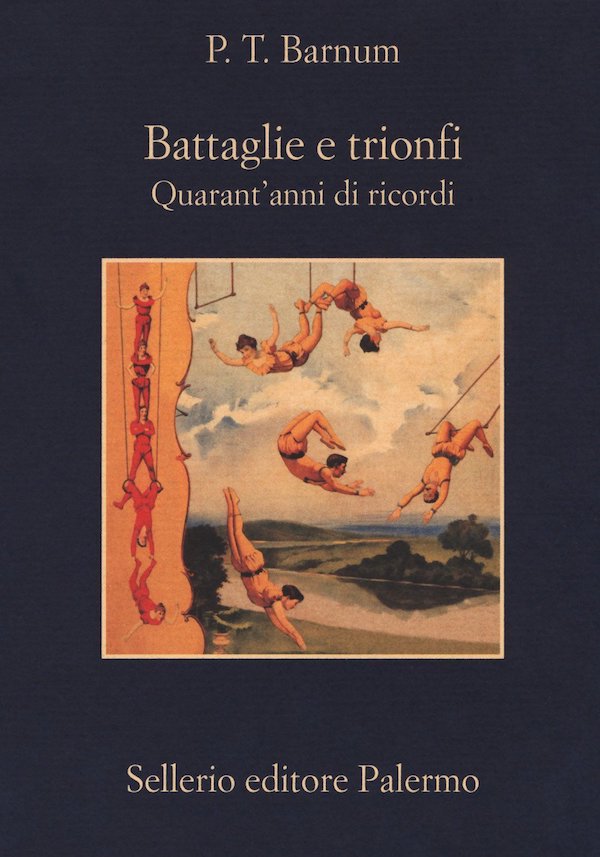Come si faceva pubblicità il primo grande uomo di spettacolo
P.T. Barnum, quello del circo Barnum, ebbe prima di tutti grandi intuizioni di comunicazione, come si legge nella sua autobiografia pubblicata da Sellerio

Quando nei mondi della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento arrivano nuovi grandi successi, si fanno sempre inevitabili e sensati paragoni con grandi successi del passato e con chi in altri contesti aveva fatto cose simili: come Lady Gaga con Madonna, per capirci. Ci sono però alcune persone che hanno fatto talmente tante cose per primi, o comunque hanno avuto brillanti intuizioni per migliorare quello che c’era prima di loro, per cui questa cosa non si può fare: Phineas Taylor Barnum, meglio noto come P.T. Barnum, è sicuramente uno di questi. Il fondatore del famoso circo Barnum, vissuto tra il 1810 e il 1891 e interpretato di recente da Hugh Jackman in The Greatest Showman, anticipò moltissimi dei meccanismi che poi tutti hanno cominciato a usare nel mondo dello spettacolo, con una grande libertà permessa dalle ingenuità del suo pubblico, che non era ancora abituato a essere tale.
Barnum era capace di capire cosa sarebbe potuto piacere alle persone e cosa avrebbe potuto stupirle ma soprattutto sapeva come attirarle e convincerle a pagare un biglietto per entrare in un museo di curiosità o assistere a uno spettacolo. Le attrazioni del suo museo e del suo circo – tra cui finte sirene e altri manufatti ingannevoli e persone deformi – oggi non avrebbero molto successo e comunque non sarebbero moralmente accettabili, ma quello che pensava sulla pubblicità è ancora valido e le sue strategie di comunicazione possono ancora essere prese a esempio. Lo si capisce bene leggendo Battaglie e trionfi. Quarant’anni di ricordi, una delle sue biografie, pubblicata originariamente nel 1869 e in Italia, da Sellerio, lo scorso giugno. Non era mai stata tradotta in italiano prima, nonostante a lungo sia stata un grandissimo bestseller.
Pubblichiamo un estratto dal settimo capitolo, dedicato al “museo” che Barnum gestì a New York dal 1841 al 1865. Oggi non lo considereremmo tale: era una specie di collezione di strani oggetti e animali anche vivi mostrati senza un criterio scientifico.
***
Avevo una padronanza assoluta dell’arte pubblicitaria, praticata non solo per mezzo dell’inchiostro tipografico, di cui mi son sempre servito con generosità, e al quale devo tanta parte del mio successo, ma anche volgendo a mio vantaggio ogni minima circostanza. Il mio chiodo fisso era che il Museo diventasse la meraviglia della città e che fosse sulla bocca di tutti. Spesso, d’istinto, coglievo al volo ogni opportunità, persino prima che mi fossi fatto un’idea chiara di come potevo sfruttarla, ma a quanto pare, in qualche modo, la cosa maturava da sé e finiva per rivelarsi utile ai miei scopi. A titolo di esempio, una bella mattina un uomo robusto dall’aspetto cordiale entrò in biglietteria a elemosinare qualche spicciolo. Gli domandai perché non lavorasse per guadagnarsi da vivere. Rispose che non riusciva a trovare uno straccio d’impiego e che sarebbe stato ben lieto di fare qualsiasi lavoro per un dollaro al giorno. Gli allungai un quarto di dollaro, gli dissi di comprarsi la colazione e tornare, ché lo avrei assunto per un dollaro e mezzo al giorno. Quando lo rividi gli diedi cinque mattoni comuni.
«Ora», dissi, «vada a posare un mattone sul marciapiede all’incrocio fra Broadway e Ann Street; un altro vicino al Museo; un terzo in diagonale lungo la via d’angolo fra Broadway e Vesey Street, davanti ad Astor House; riponga il quarto sul marciapiede dirimpetto alla chiesa di St. Paul; poi, col quinto mattone in mano, percorrendo il circuito, si sposti in rapida marcia da un punto all’altro, e cambi il mattone in corrispondenza di ciascuno senza rivolgere la parola a chicchessia».
«A che scopo?», chiese l’uomo.
«Non importa», risposi. «Le basti sapere che le frutterà quindici cent all’ora. Perché lo scherzo riesca dovrà fingersi sordo come una campana, assumere un’espressione seria, non rispondere a nessuna domanda e non far caso a nessuno, ma attenersi fedelmente alle mie istruzioni, e a intervalli di un’ora, al rintocco dell’orologio di St. Paul, mostrare questo biglietto davanti alla porta del Museo; poi lei entrerà, camminando con aria solenne, in ogni sala dell’edificio; e infine uscirà e si rimetterà all’opera».
Dopo aver commentato: «per me non fa alcuna differenza, a patto che possa guadagnarmi il pane», l’uomo sistemò i mattoni e cominciò il giro. Mezz’ora dopo si erano assiepate almeno cinquecento persone a osservare i suoi misteriosi movimenti. Avanzava con passo e contegno marziale, e con l’aspetto austero di un giudice non batté ciglio alle pressanti domande degli astanti sulle motivazioni della sua singolare condotta. Al termine della prima ora, i marciapiedi dei dintorni pullulavano di persone ansiose di risolvere l’enigma. Successivamente l’uomo, come da accordi, entrò nel Museo, dove per un quarto d’ora indugiò in una solenne perlustrazione delle sale, e poi riprese a compiere il suo giro. Ogni singola azione venne ripetuta a distanza di un’ora fino al calar del sole, e tutte le volte che l’uomo entrava nel Museo una dozzina di persone e anche più compravano i biglietti e lo seguivano nella speranza di placare la propria curiosità. La cosa andò avanti per diversi giorni – tanto da assicurare al Museo entrate ben maggiori della paga corrisposta all’uomo –, finché un agente di polizia, che avevo messo a parte del mio piano, non mi costrinse a fermare l’«uomo dei mattoni», lamentando che l’ostruzione del marciapiede causata dal pigia pigia era diventata un serio pericolo. Questo rivolo incidente suscitò parecchie chiacchiere e fu fonte di grande divertimento; mi portò pubblicità; e mi aiutò concretamente nel mio obiettivo di creare un angolo vivace vicino al Museo.

P.T. Barnum (AP Photo/File)
(…) Fin dall’inizio mi diedi da fare per offrire ai miei clienti quante più novità possibili, anche se esiterei a definirlo un atto di generosità, perché si trattava esclusivamente di un’operazione commerciale. Accrescere del doppio la soddisfazione dei miei visitatori significava indurli a tornare e a portare i loro amici. Il mio obiettivo era che le persone parlassero del Museo; che ne divulgassero le meraviglie; che tutti gli uomini e le donne del paese proclamassero: «Negli Stati Uniti non c’è nessun luogo che rivaleggi col Museo Americano di Barnum, la cui magnificente collezione è visibile per soli venticinque cent». Era la miglior pubblicità che potessi desiderare, e possedevo i mezzi per continuare a goderne. Inoltre sapevo che si trattava di una pubblicità legittima, perché meritata e insieme spontanea. Così, in aggiunta alla collezione permanente e alle ordinarie attrazioni del palcoscenico, mi arrovellai per rifornire il Museo di una serie di novità temporanee: misi in mostra curiosità viventi quali rinoceronti, giraffe, orsi grizzly, orangutan, grossi serpenti e tutto quanto riuscissi a comprare col denaro o grazie all’intraprendenza.
Consapevole che una visita alle varie curiosità valesse più di tre volte la cifra richiesta per il biglietto d’ingresso, confesso che non usai i dovuti scrupoli circa i metodi volti a richiamare l’attenzione del pubblico sulla mia impresa.
Allora come oggi era consuetudine stimolare l’interesse della comunità con locandine sgargianti che promettevano di tutto in cambio di niente o quasi. Ammetto che non mi curai di offrire un esempio migliore ai miei intraprendenti concittadini. Seguivo la moda dell’epoca; e se le mie «millanterie» furono più persistenti, la mia pubblicità più audace, i miei manifesti più sfolgoranti, le mie immagini più esagerate e le mie bandiere più patriottiche degli altri impresari, ciò non avvenne perché avevo meno scrupoli di loro, ma perché ero dotato di maggiore energia e molta più ingegnosità, e perché le mie promesse poggiavano su basi assai più solide. Malgrado tutto questo non basti a giustificarmi, posso per lo meno accampare un’attenuante nell’aver esibito una panoplia di oggetti meravigliosi, istruttivi e divertenti di tale conclamata meritorietà che mi risulta che nessun visitatore sia uscito dal Museo lagnandosi di essere stato defraudato del proprio denaro. Questo vale a compensare qualsiasi eccentricità cui io sia ricorso per propagandare il mio Museo.
(…)

La “sirena” custodita al Peabody Museum of Archaeology and Ethnology dell’Università di Harvard
Una curiosità che servì in grado eccezionale al mio onnipresente fine di estendere la notorietà del Museo fu la cosiddetta «Sirena delle Fiji». Contrariamente a quanto si è supposto, essa non fu creata su mia commissione. Essendo un uomo di spettacolo famoso e di successo, da ogni dove mi venivano portati ogni sorta di strani oggetti perché li vendessi o mettessi in mostra. Nell’estate del 1842, Mr. Moses Kimball, del Museo di Boston, venne a New York e mi mostrò quella che riteneva essere una sirena.
L’aveva comprata da un marinaio il cui padre, un comandante, l’aveva a sua volta acquistata a Calcutta nel 1822 da qualche marinaio giapponese. Posso qui menzionare che questo stesso reperto era stato esposto a Londra nel 1822, come ebbi modo di verificare visitando la città nel 1858, quando m’imbattei in un annuncio su di essa in un vecchio fascicolo del Times; inoltre, un amico mi diede una copia del Mirror, pubblicata il 9 novembre 1822 da J. Limbird, al civico 335 dello Strand, contenente un’incisione della medesima creatura e due pagine in cui veniva descritta, insieme a un rapporto su altre sirene catturate in diverse regioni del mondo. Il Mirror asseriva che questo esemplare era «la grande fonte di attrazione della metropoli britannica, e ogni giorno tre o quattrocento persone pagavano uno scellino per vederla».
Era questa la curiosità finita nelle mani di Mr. Kimball. Richiesi al mio naturalista di effettuare una perizia sull’animale: disse che non capiva come potesse essere stato fabbricato, perché non aveva mai visto una scimmia con denti e membra così particolari, né un pesce con pinne tanto peculiari; d’altronde non credeva nelle sirene. Ciò nonostante decisi di noleggiare questa rarità nel tentativo di modificare l’atteggiamento di generale scetticismo verso l’esistenza delle sirene, e per destare la curiosità del pubblico affinché la si venisse a vedere ed esaminare invocai il potente ausilio dell’inchiostro tipografico.
Non appena il Giappone si aprì al resto del mondo, si scoprì che alcuni «artisti» di quel paese fabbricano una gran varietà di animali favolosi con un’inventiva e una perfezione meccanica di destrezza tale da trarre in inganno. Senza dubbio la mia sirena era un artefatto del genere. La utilizzai principalmente per pubblicizzare le regolari attività del Museo, e questo tipo di réclame indiretta è l’unico aspetto che posso elogiare di un’esibizione speciale di cui, lo confesso, non vado fiero. Avrei potuto pubblicare colonne su colonne di annunci sui giornali presentando e incensando l’enorme collezione di reperti autentici di storia naturale da me allestita, ma essi non avrebbero attirato la stessa attenzione che ottenni con qualche paragrafo sulla sirena. In lungo e in largo per il paese i quotidiani riproducevano gli annunci sulla sirena, che in virtù della sua singolarità richiamava l’attenzione dei lettori. Insomma, la fama del Museo, come quella della sirena, si era ormai diffusa da un capo all’altro dell’America. Mi impegnai per mantenere vivo l’entusiasmo, conscio che ogni dollaro seminato per la pubblicità ne avrebbe resi a decine o forse centinaia nel raccolto futuro, e dopo aver acquisito tutta la popolarità possibile e immaginabile per mezzo della sirena esibita al Museo e dei relativi annunci, spedii questa curiosità in giro per il paese, dando istruzioni al mio agente di pubblicizzarla dovunque come «Proveniente dal Grande Museo Americano di Barnum a New York». L’effetto fu immediato; il denaro fluì con rapidità e venne prontamente investito in nuove campagne pubblicitarie.
(…)
Altri e non meno efficaci veicoli pubblicitari – bandiere e striscioni – vennero poi ad adornare l’esterno dell’edificio. Nel balcone sulla facciata facevo suonare una banda e annunciavo «Musica gratis per tutti», al che la gente reagiva dicendo: «Be’, ma questo Barnum è un filantropo!», e si riversava ad ascoltare i concerti gratuiti che organizzavo all’aperto. Tuttavia mi sforzai sempre di scegliere e mantenere la banda meno costosa in circolazione, una banda le cui cacofonie spingessero la folla dentro il Museo, fuori portata d’orecchio. Ovviamente la musica era di infima qualità. Quando la gente si aspetta di avere «qualcosa per niente» è destinata a essere turlupinata, e di solito se lo merita, e senz’altro alcuni dei miei clienti saranno rimasti amaramente delusi nell’ascoltare l’orchestra; ma quando entravano e pagavano per divertirsi e istruirsi, non lesinavo energie affinché non solo ricevessero in cambio una congrua contropartita, ma si sentissero pienamente soddisfatti. In cima al Museo feci piazzare dei fari di Drummond, che, nella notte più buia, proiettavano fiotti di luce su e giù per Broadway, dal Battery al Niblo’s, talmente sfolgoranti che si sarebbe potuto leggere il giornale per strada. Erano le prime luci di Drummond che mai si fossero viste a New York, e la gente non faceva che parlarne, in tal modo pubblicizzando il mio Museo.
Traduzione di Andrea Asioli