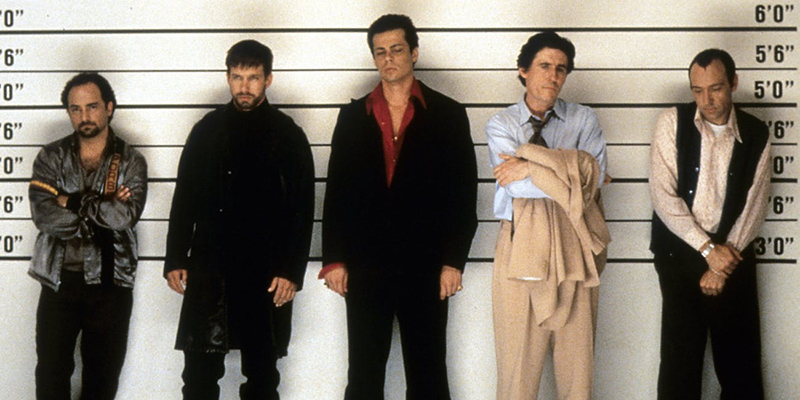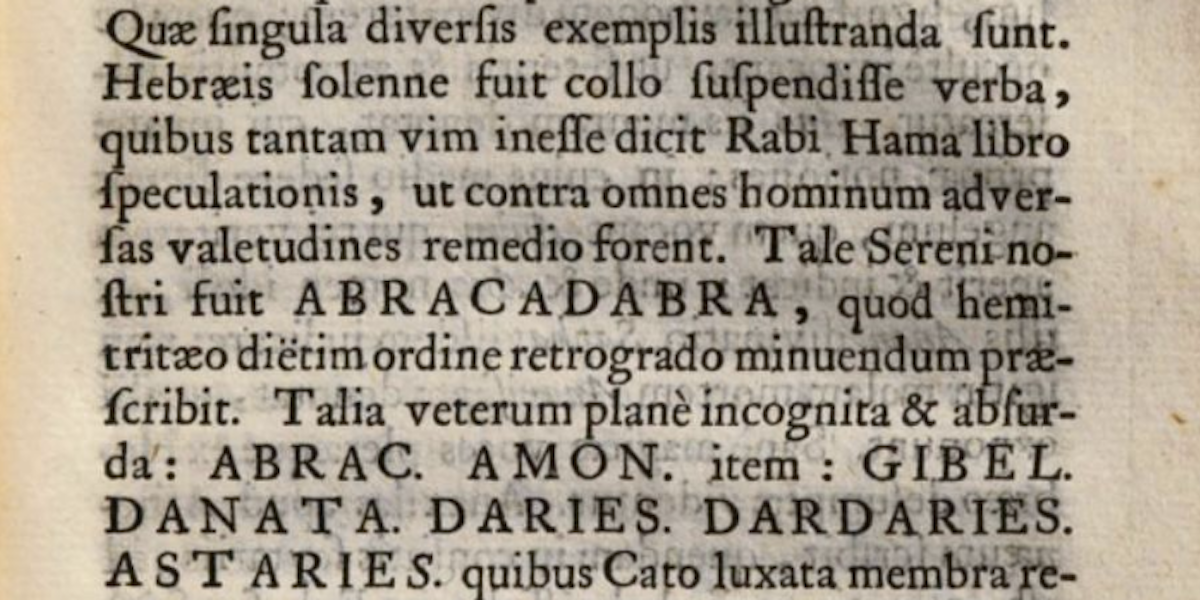Come funziona l’informazione italiana
Un'esauriente descrizione dei percorsi delle notizie e del lavoro dei giornali contemporanei nel nuovo libro di Aldo Giannuli

(Marc Piscotty/Getty Images)
Aldo Giannuli, storico e saggista esperto di storia italiana del Novecento, ha pubblicato un nuovo libro per Ponte alle Grazie che si intitola Come i servizi segreti usano i media: a dispetto del titolo allarmante e un po’ paranoico, alcuni capitoli sono delle ottime e complete descrizioni dei meccanismi dell’informazione italiana e dei suoi funzionamenti. Come il secondo che qui mostriamo, “Viaggio nell’informazione”.
Come nasce una notizia. Le fonti di base
Per comprendere il rapporto fra servizi e informazione (sia in entrata che in uscita) occorre capire come si formano le notizie e lungo quale percorso diventano i pezzi che leggiamo sui giornali o guardiamo in tv.
Una visione ingenua vorrebbe che ogni pezzo fosse il frutto delle ricerche del giornalista: dal produttore al consumatore. Le cose non stanno così: anche se parte di quello che leggiamo è effettivamente elaborato da chi firma, di solito il processo è molto più lungo e complesso. Cercheremo di fare un «viaggio dentro la notizia» per esaminare come la notizia diventa articolo.
In buona parte dei casi, all’origine della notizia c’è il comunicato o la conferenza stampa di qualche ente, organizzazione o azienda su un determinato avvenimento: la scoperta di un omicidio fatta da una questura, l’andamento delle operazioni militari in zona di guerra spiegate dallo Stato Maggiore, la proclamazione di uno sciopero da parte di un sindacato, la decisione di una banca centrale di alzare il tasso di sconto, l’andamento della giornata in borsa affari. Meno frequentemente c’è l’intervista a qualche personaggio o al testimone di un particolare evento.
E fin qui parliamo dell’informazione ufficiale, per sua natura di parte e tutta da verificare ma non sempre verificata. Poi c’è l’informazione «ufficiosa» proveniente dalla stessa fonte: notizie soffiate confidenzialmente nell’orecchio di qualche giornalista. Di solito si tratta di quelle dichiarazioni di cui la fonte non intende assumere esplicitamente la paternità, o perché troppo polemiche nei confronti di altri, o perché si ritiene che in questo modo siano più efficaci, o ancora perché ciò sarebbe politicamente inopportuno. Ad esempio, se un comando militare vuol far sapere che giudica errate e controproducenti le decisioni dell’autorità politica, difficilmente lo dirà in una conferenza stampa, piuttosto preferirà far sapere al giornalista amico che c’è maretta oppure gli farà arrivare la notizia del tale episodio, che dimostra quanto infelice e intempestiva sia stata quella tale decisione del governo.
Accade talvolta che queste soffiate riflettano anche dissensi interni all’ente da cui provengono: ad esempio, può esserci rivalità fra i comandanti militari o spaccatura nel gruppo dirigente di un partito o dissenso nel board di una banca, e la notizia confidenziale può rispecchiare la posizione di uno dei contendenti nei confronti dell’altro.
Naturalmente, la fonte ufficiosa è, per definizione, non citabile, cosa che presenta un problema molto serio: entro quali limiti è possibile accettare dichiarazioni ufficiose? Magari c’è un’informazione di primissima importanza che l’opinione pubblica vuol conoscere, ma la fonte non è menzionabile. Fuori discussione tradire la fonte e rivelarla: il giornalista deve essere leale e se promette l’anonimato alla fonte è un impegno d’onore garantirlo. Molti giornalisti sono scorretti e pubblicano con tanto di virgolette: sbagliato, in questo modo si rischia di inaridire questo genere di fonti e sarebbe un danno. Ricordiamoci che senza una fonte di questo tipo non sarebbe stata possibile un’inchiesta come quella sul Watergate. D’altra parte, la confidenza sarebbe stata fatta sicuramente a voce e la fonte sicuramente smentirebbe, lasciando tutti nel dubbio se la cosa sia vera o se la sia inventata il giornalista.
In effetti, il rischio delle fonti ufficiose, a maggior ragione di quelle non citate, è proprio quello che il giornalista si inventi tutto pur di fare uno scoop. Ovviamente, il giornalista copre con la propria credibilità il silenzio sulla fonte: se un importante giornalista scrive «Apprendiamo da fonte autorevole…» si può pensare che, trattandosi di uno stimato professionista che non ha bisogno di certi espedienti, rischiando la sua attendibilità, la notizia sia molto probabilmente vera. Il guaio è che a questo ricorrono anche i principianti.
Ci sono stati anche casi di libri di giornalisti interamente costruiti su fonti anonime, il che non è accettabile.
Il problema è complicato dal fatto che la legge (peraltro giustamente) fornisce una serie di garanzie sul segreto professionale ai giornalisti, che possono rifiutarsi di rivelare le loro fonti anche in sede giudiziaria. La cosa sta suscitando crescenti polemiche (soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Italia) e si sta facendo strada una giurisprudenza sempre meno favorevole ai giornalisti, che si vedono spesso condannati. Se e come usare questo tipo di fonti è una scelta ampiamente discrezionale del giornalista, tuttavia buona norma vorrebbe che egli accompagnasse a queste «rivelazioni» un minimo di accertamento, consultando documenti, altre fonti ecc., e magari portando qualche elemento di riscontro; anche perché c’è un altro rischio: che il giornalista sia in perfetta buona fede e la «fonte ufficiosa» ci sia davvero, ma gli stia raccontando una sonora frottola per propri scopi. Insomma, che la fonte stia gestendo il giornalista anziché farsi gestire.
Da questo punto di vista il giornalista ha la possibilità di farsi mettere sulla buona strada dalle sue «fonti private». È infatti normale che un giornalista abbia sue fonti personali più o meno retribuite: talvolta si tratta di una figura di secondo piano, magari una dattilografa o un centralinista che possono sapere qualcosa di interessante, e qualche altra volta di persona più altolocata. Si tratta delle cosiddette «gole profonde.» Ma, dato che molti intervistati e molte «gole profonde» appartengono al mondo delle istituzioni, delle aziende o delle organizzazioni e ne sono spesso voce diretta o indiretta, si deduce che, nella maggioranza dei casi, l’informazione viene da qualche palazzo.
Le «gole profonde» si dividono, grosso modo, in due categorie: quelle che lo fanno per soldi e quelle che lo fanno per altra utilità (ad esempio mettere in giro notizie che danneggino avversari politici oppure ottenere in cambio altre informazioni, vendicarsi di un capo dispotico oppure ottenere un trattamento di favore per qualche propria iniziativa). Comunque per interesse. Ma non ci sono mai fonti disinteressate? Si, l’ultima è stata segnalata dal WWF 27 anni fa, ma da allora non se ne ha più notizia. Chi è «gola profonda» lo è stabilmente, quindi in modo professionale: è logico che abbia qualche interesse a farlo, forse non pecuniario ma almeno ideologico, comunque si tratta pur sempre di una fonte interessata.
Diverso è il caso delle «fonti occasionali», dove è più probabile imbattersi in qualcuno che non abbia secondi fini e magari lo faccia per «amore di verità»: è più comune di quanto si immagini. Il problema della fonte occasionale è piuttosto un altro: il rischio di incappare in un mitomane o, più semplicemente, in una persona che ha frainteso qualcosa o che, anche involontariamente, esagera.
Nei primi anni della rivoluzione bolscevica la stampa occidentale si trovò esclusa dalla Russia, per cui i corrispondenti si concentrarono a Riga, in Lettonia, da dove cercavano di fare il loro mestiere raccogliendo notizie da nobili, pope e alti ufficiali in fuga dalla Russia. Risultato:
[Il New York Times] tra il 1917 ed il 1919 raccontò 91 volte che il governo bolscevico era caduto… 4 volte che Lenin e Trotskij si stavano preparando alla fuga; 3 volte che Lenin e Trotskij erano fuggiti dalla Russia; 3 volte che Lenin era stato arrestato ed 1 volta che Lenin era stato ucciso.
La «gola profonda» è un professionista e sta attento a valutare le informazioni che passa, perché sa che un piede in fallo potrebbe pregiudicare il suo rapporto con chi lo gestisce, pertanto valuta freddamente e senza coinvolgimento emotivo quello che vede. La fonte occasionale, al contrario, spesso non ha distacco emotivo e si lascia condizionare dai suoi stati d’animo: è una fonte più «genuina» ma anche più «grezza». E la professionalità, anche in questo caso, è un valore.
Le agenzie
La notizia, peraltro, nella maggior parte dei casi non arriva direttamente al giornale o alla televisione, ma passa per il tramite delle agenzie. Infatti, solo pochi media molto forti (la Rai, ad esempio) riescono a coprire con la propria rete di corrispondenti l’intero suolo nazionale e non sempre un avvenimento merita la spesa di un inviato speciale. Questo è tanto più vero a livello internazionale, dove nessuno dei media, per quanto importante e ramificato, riesce a coprire più di alcune grandi città. Si ricorre allora alla rete di agenzie giornalistiche: spesso alcuni pezzi riproducono direttamente il notiziario di qualche agenzia.
Le agenzie sono molto meno numerose delle testate giornalistiche, pertanto agiscono in regime di oligopolio.
Possono essere di tre tipi:
• aziende private, come l’inglese Reuters – la più antica, diffusa e autorevole – o, in Italia, l’Agenzia Giornalistica Italia (AGI) o l’Adnkronos;
• organismi fondati da pool di testate, come la Associated Press o, in Italia, l’ANSA;
• organi più o meno ufficiali di Stato o di partito come era (era?) la TASS a Mosca, o la Pekin Information a Pechino.
L’agenzia di gran lunga più importante in Italia (e quinta nel mondo) è l’ANSA, che rappresenta la continuazione della storica «Agenzia Stefani» e costituisce la principale fonte di qualsiasi organo di informazione. Seguono l’Agenzia Giornalistica Italia (AGI, fondata dall’allora presidente dell’Eni Enrico Mattei), che recentemente ha dato vita, insieme al Sole 24 ore, all’agenzia online da Pechino «AGI-China24», la migliore agenzia italiana specializzata nel mondo cinese; poi l’Italpress (sportiva), l’Agenzia Nova (specializzata nel mondo balcanico) e l’Adnkronos. Adnkronos che merita qualche nota supplementare in un libro che ha questo oggetto: nata negli anni Cinquanta dalla fusione fra l’«Agenzia di Notizie» e la Kronos ad opera di Felice Fulchignoni, che era il capo del gruppo romano del «Noto servizio» (il cosiddetto «Sid-parallelo»), una pagina di eccezione nel rapporto fra agenzie giornalistiche e servizi segreti più o meno ufficiali, più o meno deviati. Ci sono poi agenzie minori o locali o specializzate.
Delle agenzie stampa Mino Pecorelli (un vero intenditore del ramo) scrisse:
Le agenzie di stampa sono il grande rubinetto dal quale sgorga il greggio. Insieme ne sono anche il filtro. Da esse i giornalisti attingono la materia prima detta «notizia», da fornire al lettore-consumatore sotto forma di informazione, già depurata e raffinata dalle scorie. Comandare il rubinetto, cioè determinare ed orientare il flusso del prodotto greggio, quindi ritardare, filtrare o negare le notizie, significa ridurre e censurare, entro limiti più o meno vasti, il diritto dell’informazione. La scelta delle notizie erogate, o l’eliminazione di quelle censurate, è sempre legata a considerazioni di carattere politico e, in senso più esteso, economico.
Ovviamente, un giornalista può sempre cercare di mantenere una certa indipendenza nel cercare le notizie, anche rispetto alle agenzie, ma, ad esempio, sulla linea di fuoco non c’è grande libertà di movimento e meno ancora ce n’è nelle retrovie, dove l’esercito bada che i giornalisti troppo intraprendenti non abbiano vita facile. E peggio ancora se non si tratta di guerre aperte ma di guerriglie. Certo, c’è chi ci prova a suo rischio e pericolo, e i casi di Vincenzo Baldoni o di Giuliana Sgrena sono troppo eloquenti perché se ne debba dire.
Già da questo si capisce che, dal punto di vista dei servizi segreti, il nodo strategico decisivo sono proprio le agenzie. Se si vuole diffondere o far sparire una notizia è molto più produttivo operare su tre o quattro agenzie di stampa (a volte ne basta una sola) che non cercare di intervenire su tutte le testate giornalistiche e televisive: un lavoro enorme e dispersivo che, per di più, espone al rischio di fuga di notizie sul tentativo del servizio. Il lavoro sulla singola testata verrà fatto in casi particolari, quando sia necessario e sufficiente operare su una testata particolarmente prestigiosa o come singolo sviluppo di una più ampia operazione, o ancora quando occorra un’azione di dettaglio su una determinata area politica o geografica. Ma, quando si lavora «all’ingrosso», è il mondo delle agenzie quello che serve.
Il pezzo e il ruolo del giornalista
Una volta raccolte le notizie utili al suo lavoro, il giornalista scriverà il suo pezzo. Ma qui i problemi, al posto di diminuire, aumentano.
In teoria, il giornalista dovrebbe riferire di notizie certe e controllate e strettamente attinenti al tema del suo pezzo, senza omettere nulla di importante. Ma, se in teoria le cose sono così chiare, in pratica lo sono molto meno. Contrariamente a quello che si pensa, le notizie certe (del tipo: «Ieri è morto il celebre cantante rock») sono meno di quello che sarebbe desiderabile, mentre molte sono insicure, incomplete, ambigue o non riscontrate:
• Accordo sulla legge elettorale, scelto il modello kenyota. Chi lo afferma? È tutto risolto o ci sono aspetti rilevanti ancora da definire? Siamo sicuri che la fonte non ci nasconda una correzione ispirata al modello danese?
• Catturato Bin Laden. Abbiamo solo la versione americana di come sono andate le cose: è vera o no? E in che cosa può non essere vera? Siamo sicuri che era lui?
• Crollo dei titoli di Stato italiani in borsa. Il dato certo è che lo spread è salito in un giorno di 97 punti, ma cosa c’è dietro? Una fluttuazione spontanea del mercato, un’operazione concordata fra pochi grandi finanzieri per fare una grande speculazione, o una manovra politica contro l’Italia per colpire l’euro?
Abbiamo appena detto che gran parte delle notizie arriva da fonti interessate, magari mosse da motivazioni distinte (la fonte ufficiale, quella ufficiosa e la «gola profonda» hanno di per sé interessi diversi) ma comunque pur sempre interessate e non sempre affidabili. Dunque, non resta che ragionare sui dati raccolti e procedere con la verifica incrociata delle fonti, magari cercando fonti occasionali e riscontri esterni alla solita triade. Ma spesso manca il tempo di fare tutto questo, perché occorre misurarsi con la concorrenza, perché non si può dare al lettore la sensazione di aver «bucato la notizia», perché comunque le verifiche arriverebbero fuori tempo massimo, quando la vicenda non interesserebbe più nessuno. Se i giornali dovessero pubblicare solo notizie certe, riscontrate e non ambigue, rischierebbero di dare solo necrologi, leggi, statistiche, notizie vecchie e comunicati ufficiali (che sono notizie vere, nella misura in cui è vero che tizio ha detto una certa cosa, ma non nel senso che ha detto la verità): sai che spasso!
Quando mancano dati certi, non resta che procedere per ipotesi. Il giornalista, nella grande maggioranza dei casi, «va a naso» fiutando la «bufala». E un giornalista di razza ci prende con molta frequenza, magari non in modo preciso al 100%, ma avvicinandosi molto alla verità. Qualche volta addirittura prevedendola. Ricordo di aver conosciuto negli anni Settanta un giornalista bravissimo – anche se non esattamente uno stakanovista – che aveva un repertorio di pezzi «precotti», che scongelava in base alla stagione o alla tipologia di evento (sciopero generale, siccità, incidente sul lavoro, riapertura delle scuole e doppi turni ecc.) con i ritocchi necessari. A volte mandava l’articolo prima che il fatto si verificasse e poi se ne andava a passeggio. Così una volta mandò un pezzo su una manifestazione antifascista che si sarebbe svolta in serata: «1500 studenti, lavoratori e partigiani sono sfilati per le vie della città… gli slogan più gridati sono stati… alla fine della manifestazione tafferugli fra i giovani della FGCI e quelli di Lotta Continua». Perfetto, solo che nel pomeriggio un commissario di Polizia di Stato fu ucciso in un conflitto a fuoco con due malavitosi, per cui la questura chiese e ottenne che, in segno di lutto, la manifestazione fosse disdetta. Era tardi, per cui non si fece a tempo a fermare il pezzo e, all’indomani, il giornale dava notizia di una manifestazione mai avvenuta. Quello che è più divertente è che, in effetti, se la manifestazione ci fosse stata, le cose sarebbero andate esattamente in quel modo e anche gli incidenti fra FGCI e LC si sarebbero verificati come da copione.
Nella maggior parte dei casi, dunque, il giornalista più che altro valuta la verosimiglianza della notizia e fa qualche sommario accertamento per verificare se ci ha preso. Naturalmente, non sempre è possibile stabilire con sufficiente approssimazione se la cosa possa essere vera o no, per cui resta un forte dubbio. Allora c’è la grande risorsa di «san Condizionale» (il vero protettore dell’ordine e, nei casi peggiori, con «santa Condizionale»), per cui una parte delle cose dette si risolve con dei magnifici «potrebbe», «sarebbe», «avrebbe», che scaricano una parte della responsabilità su chi le ha dichiarate. Ma, come potete capire, un articolo e soprattutto un titolo non possono essere una sequela di «potrebbe, sarebbe, avrebbe», per cui si ricorrerà a una serie di sapienti accorgimenti retorici (similitudini, metafore, climax ecc.) e a un uso accorto di sinonimi più sfumati, che otterranno l’effetto di dare l’impressione di un pezzo sostanzialmente affermativo, lasciando aperta la via di una dignitosa ritirata. Ottima è la tecnica dell’«approssimazione successiva», per cui si inizia in modo dubitativo, si passa alla valutazione probabilistica di verosimiglianza, poi si ricorre a qualche antanaclasi e infine si conclude trionfalmente con un bell’indicativo. Fateci caso.
Naturalmente, tutto questo è severamente deprecato nei manuali di giornalismo, che esortano alla pratica della virtù e allo scrivere chiaro e conciso. Però, in effetti, in molte situazioni non c’è modo di fare altrimenti.
L’importante è che il lettore ne sia consapevole e stia al gioco.
Ancora più delicato è il tasto di cosa dire e cosa non dire. In primo luogo è ovvio che nella sua «istruttoria» il giornalista raccolga anche molte notizie che non c’entrano assolutamente nulla con il tema del suo pezzo, e altre ancora che forse c’entrano ma forse no. Qui è ovvio che c’è un elevato grado di discrezionalità, e non può essere diversamente: quello che a uno sembra lapalissianamente in relazione con il fatto trattato, a un altro sembrerà gratuitamente tendenzioso. Non tutti ragioniamo nello stesso modo. E non tutti abbiamo le stesse simpatie…
Ci sono poi diversi altri motivi che possono indurre un giornalista a tacere parte di quel che sa: la pubblicazione di un certo particolare svelerebbe l’identità della sua fonte, un punto gli sembra sospetto, un altro prematuro e bisognoso di approfondimenti successivi (e magari poi non c’è più occasione di tornarci su). Poi ci sono i problemi di spazio, quelli di opportunità (una certa notizia danneggerebbe il nostro paese sui mercati internazionali, un’altra rivelerebbe alla malavita una tecnica di investigazione che è bene mantenere coperta…) e quelli di natura deontologica (rispetto della privacy, coinvolgimento di minori, rischio di esporre una persona a pericoli).
Come si vede, non è sempre semplice decidere di dare alle stampe tutto quel che si sa, ma questo comporta anche il rischio che la decisione di non dare una notizia dipenda da motivazioni scorrette: tutelare un politico amico o il partito cui si è vicini, oppure, peggio ancora, interessi economici propri o della propria famiglia, o magari di un importante inserzionista che investe molto nella pubblicità su quel giornale. In altri casi possono esserci motivi più «egoistici»: tenere per sé una notizia in vista di un’inchiesta più completa che forse si farà, timore di rappresaglie che possono anche portare alla morte, come nel caso di inchieste di mafia (e non tutti siamo eroi), senza escludere l’ipotesi di un uso alternativo e più remunerativo delle informazioni (si chiama «ricatto»). Ovviamente l’uso, più o meno corretto, che il giornalista farà di quello di cui è venuto a conoscenza dipende dalla sua deontologia professionale; in ogni caso è evidente che nessun operatore dell’informazione, neanche quello eticamente più impeccabile, rende pubblico tutto quel che sa. E nelle maglie di questo rapporto fra detto e non detto passano molte manipolazioni.
Ultimo, ma non meno importante, viene il problema delle scelte linguistiche del giornalista. Un tono ironico è cosa ben diversa da un tono freddo di pura registrazione. Così come usare un termine inglese ogni sette parole non è affatto una scelta neutrale: indirizza verso una certa visione del mondo e ottiene effetti politici importanti. Usare un linguaggio colto indirizza verso un tipo di pubblico piuttosto che un altro. Analogamente, l’abuso di espressioni tecniche discrimina i lettori che hanno i mezzi per capire lo scritto da quelli che non li hanno, rafforzando le barriere di quella scala gerarchica dell’informazione di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Viceversa, usare un linguaggio troppo semplificato, eliminando del tutto le espressioni tecniche, significa fare dello sguaiato populismo, ed è ugualmente dannoso rispetto alla comprensione dei fenomeni. Questo è particolarmente vero quando si parla di finanza: un gergo infernale, fatto di misteriosi acronimi, fitto di espressioni in inglese, farcito di formule ed espressioni ultra-specialistiche, il cui compito specifico è quello di espellere la gente dal dibattito su questi temi, confermando l’idea che sono cose da banchieri, economisti, politici. Il «sottomessaggio» è: «L’uomo della strada non capirà mai nulla di queste cose, pertanto se ne tenga lontano. Si limiti a subirne gli effetti in silenzio e non dia fastidio». Anche le scelte linguistiche non sono dunque neutrali e fanno parte del «trattamento» della notizia.
L’inchiesta e lo scoop
Un aspetto particolare del lavoro del giornalista è l’inchiesta. Abbiamo detto quali sono i problemi che pone la dipendenza da fonti in vario modo interessate. Nulla vieta però al giornalista di cercare fonti occasionali non interessate e di condurre inchieste sul campo, andando personalmente a caccia di informazioni. Il problema è che le inchieste costano tempo e, in proporzione, producono molto poco (per intenderci: in termini di righe). Nel frattempo, occorre riempire ogni giorno la foliazione del giornale (o il tempo del notiziario televisivo) con la produzione ordinaria di pezzi giornalistici per i quali le fonti occasionali non sempre ci sono e comportano sempre il rischio piuttosto elevato di imbattersi in bufale inconcludenti. Un’inchiesta può durare anche mesi (soprattutto se si tratta di un lavoro importante), durante i quali il giornalista non produce altro (o quasi). Dunque, delle due l’una: o il direttore decide che a turno i suoi giornalisti si stacchino dalla «produzione ordinaria» e si dedichino a qualche inchiesta, oppure decide di tenere a libro paga alcuni giornalisti solo per questo tipo di lavori. Nell’uno e nell’altro caso si tratta di un costo secco di esercizio e, in ogni modo, l’inchiesta rappresenterà sempre una parte quantitativamente limitata del prodotto informativo che arriverà al lettore/ascoltatore/spettatore.
E questo è il motivo per cui di inchieste se ne leggono sempre meno. Ma l’inchiesta è il pezzo nobile del giornale, quello che dà al lettore non solo le notizie su un fatto in sé, ma anche gli strumenti per capirne tanti altri e per orientarsi. La qualità di un giornale (o di una tv) è direttamente proporzionale allo spazio che dedica alle inchieste.
Strettamente connesso all’inchiesta è lo scoop, il sogno di ogni giornalista (e l’esca migliore di cui disponga qualsiasi servizio segreto). Lo scoop è una notizia in esclusiva, la notizia per eccellenza. Spesso si tratta di una singola notizia che viene «sparata» sul giornale in prima pagina: il giornalista abile (o fortunato) ha trovato il testimone oculare del delitto, magari prima ancora della polizia, o ha scovato un documento importantissimo. In questi casi la mano dei servizi è spesso presente, ma, ovviamente, molti sono scoop veri e propri.
A volte lo scoop viene da un’intervista di un personaggio famoso che dà un annuncio inatteso ed esplosivo (Moratti: «In realtà ho sempre tenuto per il Milan»; Berlusconi: «Il comunismo fu una bella cosa e giovedì faccio voto di castità»; il Trota che dice cose banali ma «azzecca tutti i congiuntivi», cose così).
Molto particolare è lo «scoop di interpretazione», che si basa su fatti già noti ma che nessuno ha mai collegato e che, attraverso il nuovo nesso, assumono un significato ben diverso da quello sin lì attribuito a ciascuno di essi. Questa mancata connessione di solito dipende dal fatto che si tratta di fatti molto distanti fra loro: nel tempo, nello spazio, o perché riguardano materie molto diverse.
Questo genere di scoop, tipico del lavoro di inchiesta, spesso si basa su pezzi scritti da altri giornalisti. Infatti, i giornalisti attingono spesso da colleghi per i loro pezzi: non si tratta di plagio (per lo meno non sempre) ma di una pratica che ha diverse ragioni (rielaborare informazioni prese da diverse fonti, bisogno di inserire una determinata informazione in un pezzo di commento ecc.). Il «valore aggiunto» è quello del collegamento, che consente di rileggere l’intera vicenda in un’ottica completamente nuova.
La ripresa di materiale altrui accade con molta maggiore frequenza di quanto non si pensi e ha una conseguenza abbastanza importante: il carattere «epidemico» degli errori, che vengono costantemente riprodotti. Vorrei fare due esempi: chi leggesse alcune cronologie sulla violenza politica negli anni Settanta – una per tutte quella di Mauro Galleni in Rapporto sul teerrorismo – apprenderebbe della morte dello studente Vincenzo Caporale, di Lotta di lunga durata, per sfondamento del cranio, durante scontri di piazza con i carabinieri a Napoli il 22 febbraio 1973. In realtà, Vincenzo Caporale non era di Lotta di lunga durata ma di Lotta Continua e, soprattutto, non morì affatto. All’origine dell’errore c’è Il manifesto che titolò Lo studente Caporale, 19 anni, è morente perché colpito alla nuca da un calcio di moschetto, definì erroneamente Caporale come «militante del Partito Comunista d’Italia (Lotta di lunga durata)» e riferì di un «elettroencefalogramma piatto» (che equivale alla morte clinica). Anche Lotta Continua, nello stesso giorno, dette la notizia che Caporale era «clinicamente morto». Per fortuna la diagnosi era sbagliata e Caporale, anche se dopo ben 66 giorni di coma, riprese conoscenza e superò la crisi: a darne notizia fu Lotta Continua.
Ma Galleni per la sua cronologia consultò Il Manifesto e non Lotta Continua e immaginò che all’«elettroencefalogramma piatto» necessariamente doveva essere seguita la morte. Da allora, questa falsa notizia è riportata da infiniti libri e siti sulla storia di quegli anni (basta digitare «Vincenzo Caporale» per sincerarsene). Se è vero che le notizie premature di morte allungano la vita, Caporale (attualmente direttore della ASL 2 di Napoli) supererà di slancio i 200 anni. Questo è il classico caso della notizia «rivista e accresciuta» per cui, se una fonte specializzata afferma che negli USA ci sono 150.000 donne affette da anoressia, un giornalista scrive che «150.000 donne stanno morendo di anoressia» (cioè quattro volte i caduti americani in Iraq!).
Ancora più divertente è il caso dell’ufficiale dei carabinieri Remo D’Ottavio, attendente del generale Giorgio Manes (grande accusatore di Giovanni De Lorenzo per il caso SIFAR. Manes morì a Montecitorio, poco prima di essere ascoltato dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta, il 25 giugno 1969, per un attacco cardiaco che destò molti sospetti, anche perché il memoriale che avrebbe consegnato alla Commissione sembra sia scomparso. Dopo qualche tempo, Remo D’Ottavio (che aveva battuto a macchina quel rapporto) si sparò un colpo di pistola al cuore, si disse per una delusione d’amore, cosa che parve doppiamente sospetta e quella di D’Ottavio venne inserita nella lunga lista delle morti «sospette». Una ventina di anni dopo esplose il «caso Gladio», che riattualizzò le cupe vicende della strategia della tensione e dei tentativi di colpo di Stato; fra le altre cose, ricomparvero gli elenchi delle «morti strane» e cronologie che riportavano regolarmente la vicenda di D’Ottavio. Solo che lo sfortunato ufficiale non era morto, essendo sopravvissuto fortunosamente al suo tentativo di suicidio, e aveva anche fatto una notevole carriera, diventando ufficiale superiore. Scrisse pertanto una lettera a diversi quotidiani per informarli che era vivo, che effettivamente era stato lui a spararsi al cuore e proprio per una delusione d’amore. Lettera pubblicata con tante scuse e felicitazioni per la scampata morte da parte dei giornali, solo che uno di essi, nello stesso numero in cui pubblicava a pagina 8 la lettera dell’ufficiale, a pagina 13 riproduceva la solita cronologia con la notizia della strana morte di D’Ottavio e, tutt’ora, la rete è piena di questa notizia ripetuta all’infinito. Certi errori sono indistruttibili e non rettificabili.
Simile è la vicenda di Martin Šmíd, uno studente cecoslovacco brutalmente ucciso a manganellate dalla polizia, come riferì una giovane donna ad alcuni giornalisti. Era un momento in cui c’era fame di notizie su quel che fermentava nell’Est e la notizia volò pubblicata dalla Reuters; la France-Press scrisse, anzi, che i giovani assassinati erano tre. Unica a fare qualche accertamento fu l’Associated Press, il cui corrispondente, Ondřej Hejma, appurò che in nessun ospedale c’era notizia di qualche Martin Šmíd morto in quei giorni, anzi non fu possibile neppure stabilire se esistesse uno studente con quel nome e tutte le agenzie finirono con il rettificare la notizia.
Titolo, impaginazione, foto
Dopo che il giornalista avrà finito di scrivere il suo articolo, c’è ancora un percorso da fare perché esso arrivi al lettore: il pezzo deve essere impaginato, titolato, «illustrato»; spesso, poi, una collocazione particolare, un accostamento malizioso, un titolo o un sottotitolo, una foto «ben scelta» possono dare il senso al pezzo molto più di quello che c’è scritto.
In primo luogo la collocazione: va da sé che mettere un pezzo in prima pagina è ben altra cosa che metterlo nelle pagine interne. E anche tra le pagine interne c’è differenza: se il pezzo è nella prima parte del giornale o più in fondo, dove il lettore deve proprio andare a cercarselo, se su pagina dispari (che accentua la visibilità) o pari (che la diminuisce), ma anche nella stessa pagina cambia molto se l’articolo compare in taglio alto, medio o basso. La collocazione contiene un giudizio sull’importanza della notizia: se è in prima (almeno con un richiamo) la maggioranza dei lettori la vedrà e capirà che quello è il tema del giorno, ma un taglio basso o un semplice richiamo ne ridimensioneranno l’importanza al rango di notizia per pubblico specializzato o destinata a un consumo «leggero», da chiacchiera al bar. Le pagine interne, con la divisione in rubriche, indirizzano il pezzo – e la notizia che contiene – verso una certa fascia di pubblico. In qualche caso la collocazione è oggettiva: una recensione sull’ultimo libro di Eco va nelle pagine della cultura, l’intervista a Ronaldo in quelle dello sport e la notizia dell’ultimo successo di Bolle va in quelle degli spettacoli. Ma non sempre le cose sono così nette e c’è una certa discrezionalità: un libro su Piazza Fontana andrà nelle pagine di cultura o in cronaca (dove lo leggono più persone)? Magari dipende da quanto si è impegnato l’editore o dalla decisione del giornale di dare più o meno rilievo a quel genere di notizie. L’ennesimo caso di violenza a sfondo omofobo va nella cronaca nera o nelle pagine della politica interna? Se si deciderà di dare più spazio all’aspetto della violenza nelle città la collocazione sarà la prima, se invece si darà rilievo alle reazioni parlamentari e al rilancio della legge contro l’omofobia la notizia sarà inserita nelle pagine di politica interna. E via di questo passo.
L’impaginazione consente anche qualche accostamento malizioso che cambia il senso del pezzo: se a fianco all’intervista a Bossi, che parla di tutt’altro, metto la notizia della protesta degli studenti albanesi che sostengono che la laurea data al Trota dequalifica il loro titolo di studio, la cosa ha un vago effetto esilarante e induce a non prendere troppo sul serio quello che dice il vecchio leone leghista.
Poi c’è il problema della titolazione: la grande maggioranza dei lettori si accontenta del titolo e non legge l’articolo. D’altra parte, le statistiche dicono che gli italiani dedicano alla lettura dei quotidiani (quando li leggono) 13 minuti al giorno, e in quel breve lasso di tempo non va molto al di là dei titoli. Nella maggior parte dei casi la titolazione sarà più o meno neutra, senza alcuno sforzo di fantasia: Raggiunto l’accordo fra Eni e Gazprom, Hollande vince su Sarkozy, L’Italia in recessione e così via, ma ci sono titoli che fanno da «chiave di lettura»: se in un pastone di politica interna che parla delle convulsioni del PD (sai che notizia!), della decisione di Berlusconi di candidarsi, del rifiuto di Grillo di fare liste con qualsiasi partito, ecc., il titolo mette in rilievo l’ultima dichiarazione di Casini sulla riforma elettorale, vuol dire che il lettore capirà che quello è il fatto importante, e se darà un’occhiata al pezzo lo farà cercando mentalmente quello che riguarda Casini, che magari sta in quattro righe in fondo. Ci sono titolisti assolutamente diabolici che fanno carte false per dire esattamente il contrario di quello che c’è nel pezzo (ne so qualcosa io nei miei trenta anni di collaborazioni giornalistiche!).
A volte il titolo è una sintesi di tale efficacia che illumina la scena come un lampo e rende non necessaria la lettura del pezzo: Di sicuro c’è solo che è morto fu il titolo che Arrigo Benedetti dette alla straordinaria inchiesta di Tommaso Besozzi sulla morte di Salvatore Giuliano. In quelle otto parole c’è tutto il senso dell’articolo. A volte un titolo vale un intero corsivo: Il papi della Patria non è un titolo, è una rasoiata di rara crudeltà, e Il Pastore tedesco, con la foto di Ratzinger, vale un attentato. Altre volte invece un titolo sbagliato allontana il lettore, che gira nervosamente la pagina: se un pezzo sulla dissalazione delle acque marine e sulla purificazione degli scarichi fognari è titolato Una fogna tutta da bere, magari il lettore, che sta prendendo il suo cappuccino, si indispone.
Comunque, quello che conta è il titolo: detto in due parole, la notizia è il titolo, in qualche caso con la modulazione di occhiello e sottotitolo o con il catenaccio che contribuiscono a dare la «chiave di lettura». Che è quello che conta, più del fatto stesso. Stesse considerazioni possono essere fatte per i pezzi televisivi che, anzi, sono ancor più condizionati dal supporto delle immagini.
Come si scelgono e si valutano le notizie
Come è ovvio, la gerarchia delle notizie – dallo spazio che gli si dedica alla posizione nella «gabbia» del giornale – non è affatto neutrale. Non esiste un criterio oggettivo per stabilire che un fatto è più importante di un altro. Ovviamente, il 12 settembre 2011 tutti i giornali del mondo, nessuno escluso, dedicarono l’intera prima pagina (e parecchie pagine interne) all’attentato alle due Torri e, se ci sono le dimissioni di un governo, tutti i giornali del corrispondente paese ne faranno la notizia centrale di prima. Ma di notizie così, che si impongono da sole, ce ne sono pochissime. Nella maggior parte dei casi la selezione avverrà sulla base di una serie di criteri: l’effettivo peso dell’avvenimento da commentare e il confronto con gli altri giornali, per cui bisogna a tutti i costi evitare la sensazione di aver «bucato» un avvenimento importante; la particolare contingenza che impone un argomento piuttosto che un altro; l’autorevolezza del giornale o, all’opposto il suo carattere irriverente, che obbligano a un certo stile piuttosto che a un altro; la «sensibilità» politica della proprietà e del direttore; il tipo di pubblico di riferimento e l’idea di quel che potrebbe gradire che ne hanno il direttore e il capo redattore; l’identità dei maggiori inserzionisti del giornale, cui non bisogna dispiacere o almeno dispiacere il meno possibile; le mode del momento ecc. Come si vede, una serie molto complessa di considerazioni che, di volta in volta, privilegiano l’uno o l’altro aspetto.
Di particolare rilievo sono il pubblico dei mass media e l’idea che si fanno delle sue esigenze i maggiori responsabili del giornale. Se si ha un pubblico più avanti negli anni, magari di ceto medio-alto e di orientamento politico moderato o conservatore, una serie di notizie, come le unioni gay o il dibattito nella CGIL, avrà meno spazio e sarà trattata con più freddezza, mentre si guarderà con maggiore attenzione alle scadenze istituzionali, trattate con rispettoso aplomb. Viceversa, se un giornale ha un pubblico a forte composizione giovanile e con atteggiamenti ribellistici, tendenzialmente di sinistra, darà spazio alle notizie sulle unioni gay e tratterà le notizie di Palazzo in modo polemico, talvolta irridendole.
Non sempre, però, tali valutazioni sono azzeccate e anzi, con una certa frequenza, direttori, proprietà e caporedattori coltivano idee del tutto gratuite sulle aspettative del proprio pubblico. Ci sono pregiudizi assolutamente infondati quanto inestirpabili: la maggior parte dei giornalisti è convinta che il pubblico sia composto da deficienti e, in particolare, lo pensa delle donne. Anni fa mi capitò di parlare con il direttore del supplemento «femminile» di un noto quotidiano, che era ai suoi primi numeri. Gli feci presente che la formula era quella solita da cento anni (moda e cosmesi + storie di corna celebri + salute e cucina), con, in più, quale ammiccamento porno-soft (Come sedurre l’uomo che ti piace, Cosa guardi nel corpo di un uomo alla spiaggia? ecc.) e che, insomma, qualche pezzo più impegnato (politica, economia, cultura) non avrebbe sfigurato. Mi rispose: «Ma cosa vuoi che freghi alle donne della politica economica o della politica estera USA? Non è roba da donne».
E infatti, nel linguaggio giornalistico, i «femminili» sono, appunto i settimanali che seguono la formula appena citata, mentre quelli che parlano di politica, economia e cultura sono, per antonomasia, i «maschili», perché, appunto, queste sono cose da uomini. Insomma, «le donne sono troppo cretine per interessarsi a queste cose, però anche gli uomini sono troppo cretini per capirle davvero». E il bello è che non c’è giornale che non si strappi le vesti su quanto siano poche le donne manager o parlamentari, ma che poi, dovendo fare una campagna per conquistare fette di pubblico femminile, come prima cosa non aumenti la dose di gossip.
Anzi, negli ultimi tempi c’è stato un boom del gossip, che sembra aver conquistato anche il pubblico maschile. Il tema delle escort ormai campeggia su tutta la stampa. Mentre altri argomenti, forse più ostici ma sicuramente ben più rilevanti, ricevono un’attenzione del tutto marginale. Si pensi al caso della manipolazione dei tassi Libor ed Euribor che ha alterato per anni il mercato dei prestiti interbancari. Questa manipolazione ricade fatalmente sui clienti delle banche e non si tratta per niente di pochi euro. Non c’è dubbio che sia una notizia di interesse generale (chi non ha una carta di credito, un mutuo o una rata da pagare?) e si immagina che essa debba apparire in prima pagina, e starci per settimane. Magari, per mettere il tema alla portata di tutti, si sarebbe potuta pubblicare in prima pagina una tabella su quanto questo è costato al signor Rossi sul suo mutuo, sulla sua carta di credito, sulla sua rata auto ecc. (probabilmente diverse migliaia di euro in 4 anni). Ci fosse stato un giornale ad averlo fatto! Salvo la stampa finanziaria specializzata, il tema è subito caduto nel dimenticatoio. Il fatto è che le banche sono come i defunti: nihil nisi bonum.
Per spiegarci meglio, facciamo un esempio. Abbiamo queste notizie da impacchettare:
• 38o vertice europeo sull’improvvisa risalita dello spread, ogni decisione rinviata a settembre.
• Risoluzione ONU sui diritti del popolo rohingya in Myanmar.
• Un discorso del presidente della Repubblica di nessuna utilità.
• Scandalo: il cancelliere dello Scacchiere fa sesso con la sua segretaria.
• Sciopero alla Fiat di Pomigliano.
• Approvata in Portogallo la legge sulle unioni gay.
• Prete pedofilo arrestato in Baviera.
• Assessore del PdL perquisito: aveva la tangente appena riscossa.
• Congresso dell’UDC, la relazione di Casini.
•
Ora vediamo come, presumibilmente, le confezionerebbero i seguenti giornali:
• Un autorevole giornale modello Times.
• Un importante quotidiano confessionale.
• Un popolare del tipo Daily Mirror.
• Un battagliero organo di opposizione di sinistra.
• Una testata vicina a un partito di centrosinistra.
• Un foglio vicino a un partito di centrodestra.
• Un importante organo di informazione economico-finanziario.
Probabilmente:
Il quotidiano autorevole. Prima pagina: apertura centrale al vertice europeo; discorso del presidente di spalla; editoriale del direttore sull’unità politica dell’Europa (Il sogno dell’Unità: quel giorno che Mazzini…), taglio medio per la relazione di Casini, foto dei leader europei presenti al vertice e primo piano del capo dello Stato. Tutte le altre notizie nelle pagine interne, meno quella sulla Fiat, che non comparirebbe affatto.
Il quotidiano confessionale. Prima pagina: taglio centrale sulle unioni gay, a fianco un pezzo sulla crisi dell’euro con un occhiello che sottolinea le responsabilità di Lisbona. Editoriale di padre Torquemada: Unioni contro natura e decadenza dell’Europa. Nessuna foto. Uno «strillo» rinvia al congresso UDC nelle pagine interne. Nessuna notizia sul prete pedofilo, sullo scandalo del lord dello Scacchiere né sull’assessore arrestato.
Il popolare alla Daily Mirror. Prima pagina: al centro lo scandalo sessuale, di fianco lo sciopero alla Fiat, nel taglio basso il prete pedofilo, uno strillo sul vertice europeo, con un box che spiega cos’è lo spread e perché è un guaio che aumenti. Qualche foto vagamente pruriginosa. Nelle pagine interne le unioni gay in Portogallo. Nulla sulle altre notizie.
Il combattivo quotidiano di opposizione. Prima pagina: centrale sull’assessore PdL, corsivo dal titolo Forza Busta!, affiancato da una foto del capo del PdL, taglio basso sul discorso del presidente presentato polemicamente, una serie di strilli (la pagina è piccola) sul vertice UE, sulla risoluzione ONU, sullo scandalo sessuale e sulle unioni gay, nelle pagine interne il prete pedofilo e lo sciopero Fiat; la relazione di Casini nella pagina degli spettacoli.
L’organo di centrosinistra. Prima pagina: centrale il discorso del presidente, affiancato dalla relazione di Casini (con foto dei due); sotto, il vertice europeo; editoriale del direttore: L’ora delle decisioni gravi; richiami sul vertice UE, la risoluzione ONU e l’assessore del PdL perquisito. Non comparirebbero affatto lo scandalo sessuale, lo sciopero alla Fiat, le unioni gay e tanto meno il prete pedofilo.
L’organo di centrodestra. Data l’ampiezza della pagina e il carattere molto piccolo dei titoli, avrebbe più notizie. Prima pagina: un colonnino sulla sinistra ospiterebbe l’opinione di un economista sul perché dello spread, il titolo centrale su due colonne sarebbe dedicato alla riunione europea. Di spalla un’opinione sull’eccesso di perquisizioni e intercettazioni (Uno stato di polizia, nessun cenno allo sfortunato assessore). Nelle pagine interne le notizie del prete pedofilo e delle unioni gay confluirebbero in un pezzo intitolato I nuovi termini della questione genitale. Nessuna foto.
Il giornale economico-finanziario. A tutta pagina il balzo dello sperda, con un editoriale (L’unione politica: fate presto!); di spalla l’intervento di un noto economista, in basso il discorso del presidente, un box di rinvio al congresso UDC. Nelle pagine interne le altre notizie. In prima, foto del vertice e grafico che mostra l’andamento dello spread.
Questi potrebbero essere i comportamenti tipo, ma ci sono anche mode momentanee che possono far variare considerevolmente il valore di una notizia. Ad esempio, se c’è un’ondata di scandali sui preti pedofili, la notizia del prete bavarese sarebbe ripresa da tutti (salvo il quotidiano confessionale).
Ancor più rilevante è il caso dell’emergenza, che è il momento più pericoloso per i mass media: c’è la rivolta in Libia, non si sa se ci sarà una guerra, giornali e telegiornali aprono tutti con le notizie da Tripoli sparando titoli a tutta pagina. Occorre essere all’altezza della situazione e rispondere alla fame di notizie dei lettori. Una notizia che altri non hanno vale oro, e tutto fa brodo: certo un’intervista con Muammar o una sua foto nel suo bunker sarebbero un terno al lotto, ma in loro mancanza vanno bene anche le confessioni della cugina ninfomane del Rais. Qualsiasi cosa. Ed è questo il momento in cui i controlli si allentano: se uno vi porta la foto di Gheddafi nella sua tenda, che fate? Sì, l’uomo è quasi completamente di spalle, si scorge solo una porzione del profilo, che in effetti gli somiglia abbastanza. La foto non è proprio il massimo della nitidezza, però di lato si vede una copia di Le Monde di tre giorni fa, dunque lo scatto è certamente recente, e l’ufficiale con cui sta parlando somiglia in modo impressionante al capo della sicurezza visto al suo fianco in decine di riprese televisive.
Tempo per fare controlli su come la fonte abbia avuto la foto non ce n’è. Ha detto: «Prendere o lasciare. Se non vi interessa vado da quelli di Informazione notte». Che si fa? Correre il rischio di vedere la foto pubblicata da quegli odiosi di Informazione notte che sono i diretti concorrenti sulla piazza e devono ancora pagarla per la buca che ci hanno dato in Kosovo? «Jamais! Rischiamo!» E così la foto finisce in pagina accanto all’intervista a un esperto militare che, sulla base dei labili segni orografici che è possibile scorgere e di una cartina che si intravede nelle mani dell’uomo della sicurezza, azzarda a localizzare il posto: una località sconosciuta del Fezzan sudoccidentale, al confine con il Niger, paese in cui il Rais può contare su molte protezioni. Dunque Gheddafi si sta preparando a espatriare abbandonando la partita.
Grandissimo scoop!
Solo che: l’ufficiale della sicurezza è effettivamente lui, ma da tre settimane è passato con gli insorti, con i quali ha confezionato la foto: l’uomo di spalle ha effettivamente qualche somiglianza con Gheddafi, ma non è lui, e la copia di Le Monde è stata messa a bella posta, come la cartina in mano all’ufficiale con tanto di frecce e cerchi a matita. Quanto ai segni del territorio, erano così generici che poteva essere anche il Gobi settentrionale. Scopo: far arrivare all’opinione pubblica il messaggio che Gheddafi è sul punto di crollare e basta solo una spallata per vincere. Buona la consulenza dei servizi inglesi, che hanno avuto la signorilità di mettere Le Monde e non il Times e che hanno fornito graziosamente la «fonte» in grado di piazzare la foto sul mercato. La cosa, magari, si scoprirà diversi mesi dopo, ma l’articolo che denuncia il falso cadrà completamente nel vuoto, perché nel frattempo «la Libia non fa più notizia», pochi leggeranno l’articolo, mentre la maggioranza di quelli che ricorderanno quella foto resterà convinta della sua autenticità.
Questo è un esempio del tutto inventato (fatto tanto per dare con immediatezza il ragionamento), autentico è invece il caso di una delle foto pubblicate nei primi giorni della rivolta libica in cui si vedevano diverse persone – presumibilmente arabi – che si aggiravano fra fosse appena scavate con mucchi di terra pronti per riempirle. La didascalia, che compariva su quasi tutti i giornali, parlava di «fosse comuni», a documentare le atrocità del regime libico. Il sottosegretario Carlo Giovanardi disse che si trattava di un falso e venne linciato, in particolare dall’opposizione di sinistra che lo accusò di voler coprire il regime di Gheddafi. In realtà la foto, una volta ben osservata, fa vedere non una fossa comune, ma un’ordinatissima fila di fosse individuali e una serie di persone come ce ne sarebbero per qualsiasi sepoltura. Quello di Gheddafi era un regime ripugnante che occorreva far cadere (anche se i suoi successori non sembrano molto migliori di lui) e le atrocità effettivamente ci sono state, ma quella foto non dimostra assolutamente nulla: può darsi che in quelle fosse, magari scavate in precedenza, ci siano finiti i caduti degli scontri di quei giorni, ma questo non si evince affatto dall’immagine. Forse quella foto si riferisce a un altro momento assolutamente normale e forse è stata scattata in un altro paese arabo, dato che nulla indica che si tratti necessariamente della Libia. Dunque, se non si può parlare propriamente di falso (come potrebbe essere un fotomontaggio) è però vero che la didascalia era, quantomeno, azzardata, e pertanto, per una volta, ha avuto ragione Giovanardi.
Peraltro, quello delle fosse comuni è un tema vecchio come il cucco che è stato usato anche a proposito della caduta di Ceauşescu in Romania, del Kosovo, dell’Iraq, della Somalia ecc.
Qualche considerazione riassuntiva
Come si vede, tra il fatto in sé e la percezione del lettore (o ascoltatore) c’è di mezzo un lungo e complesso trattamento, al termine del quale molti elementi sono stati eliminati e forse qualcuno aggiunto, altri modificati, altri ancora riferiti in modo più o meno suggestivo e il tutto è stato offerto con una chiave di lettura particolare, forse giusta, comunque inevitabilmente di parte, perché persino le scelte linguistiche, come abbiamo detto, non sono neutrali.
La separazione dei fatti dalle opinioni, principio sacro del giornalismo anglosassone, resta un idealtipo verso cui si può tendere, ma non lo si può mai raggiungere in toto. Il punto è che non esiste una versione oggettiva dei fatti. Persino la ripresa filmata di un evento contiene elementi di manipolazione. In primo luogo perché, non potendo trasmettere l’intera ripresa per ragioni di tempo, occorrerà scegliere quali sequenze dare e quali tagliare e questo già contiene un giudizio soggettivo del montatore. In secondo luogo perché, per quanto un operatore possa cercare di filmare tutta la scena, le riprese saranno comunque limitate e qualcosa resterà fuori, per cui nessuno può garantire che quel qualcosa sia del tutto inutile e non significativo. Poi resta sempre il problema dell’inserimento del filmato nel palinsesto: se in posizione favorevole o svantaggiata, se prima o dopo un determinato servizio che, per suggestione, può modificare la chiave di lettura. Infine occorrerà pure fare un commento e questo, inevitabilmente, sarà altamente soggettivo e introdurrà elementi di forzatura (anche solo inconsapevoli) in una direzione o in un’altra.
D’altra parte la forzatura interpretativa e la lettura più o meno di parte non stanno solo nella penna del giornalista, ma anche negli occhiali del lettore: se una persona è convinta che tutti i rumeni siano dei delinquenti, leggerà anche un articolo del giornale della Caritas con quel pregiudizio e le sue convinzioni saranno al massimo scalfite da quel che legge. Un giornale non esiste in sé, esiste come rapporto fra chi scrive e chi legge, per cui è sempre fatto «in due». E anche i lettori o gli ascoltatori hanno una loro visione consolidata del mondo (come altro potrebbe essere?) che condiziona quello che leggono e ascoltano.
Insomma, come diceva Salvemini: «L’obiettività è un’illusione, la probità intellettuale un dovere». Si può e si deve cercare di essere onesti intellettualmente, anche se la piena oggettività è un risultato irraggiungibile. Questo non vuol dire che leggere i giornali e ascoltare la televisione sia perfettamente inutile perché vi girano solo bugie e, quando va bene, ricostruzioni tendenziose. In primo luogo perché una bella fetta dell’informazione, anche se non raggiunge livelli di assoluta obiettività (sempre impossibili), esprime però livelli accettabilissimi di onestà intellettuale e una buona professionalità.
In secondo luogo perché l’effetto distorsivo si riduce automaticamente se il lettore è consapevole del fatto che anche il migliore specchio ingrandisce o rimpicciolisce l’immagine, pur se di poco. Ovviamente, sempre che il lettore sia sufficientemente smaliziato e, soprattutto, abbia sufficiente distacco laico, evitando di scambiare un quotidiano per la Bibbia e un telegiornale per la discesa dello Spirito Santo, anche se si tratta del giornale del suo partito e della sua rete preferita. Nella maggior parte dei casi, gli inganni cui va incontro il lettore non sono quelli che gli ha teso il perfido giornalista manipolatore, ma gli autoinganni che gli gioca il suo desiderio di vedere la realtà in un certo modo.
In terzo luogo (e questo è ciò che rende la democrazia pluralista infinitamente superiore a tutti gli altri regimi politici), il confronto fra le distorsioni di ciascuno crea una certa compensazione reciproca, per cui, chi vuole, riesce a guadagnare una visione un po’ più obbiettiva. E alla fine, nonostante tutto, la cosa funziona.
Foto: Un’ufficio nella redazione dell’Unità, 16 settembre 1953 (Silvio Durante / LaPresse)