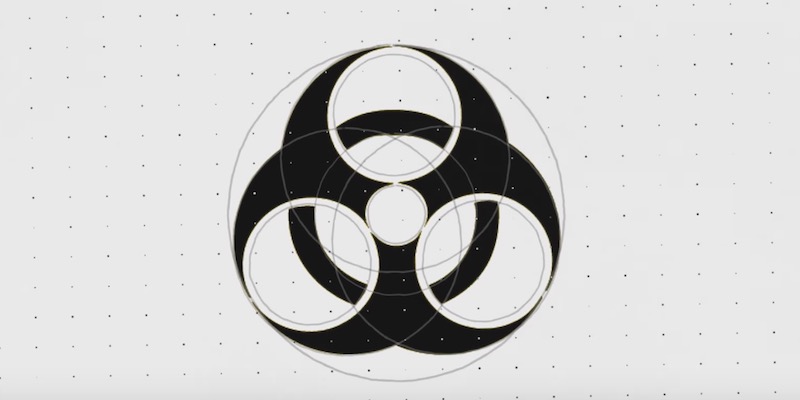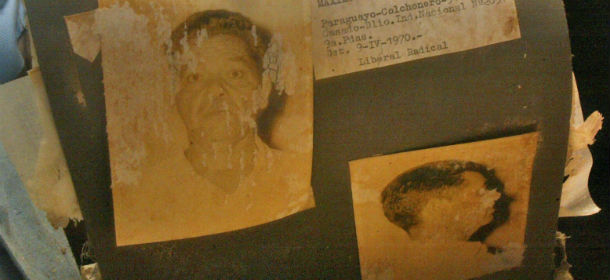Bravi a scuola
La sinistra, le élites e i banchi della terza fila nell'Italia del governo Monti
di Giuseppe Provenzano

Va bene, la manovra è discutibile. Ma non vedete come già il tono del discorso pubblico s’è alzato? Le Camere provano a emendarsi da mesi di risoluzioni sui sotterranei di Arcore, vi pare poco? È il primo effetto dei “bravi a scuola”. E bisogna sperare che non passi in fretta e le comprensibili delusioni non si volgano nel ripudio dell’onesta competenza – ché già tuona l’accusa: non serviva certo l’élite per tassare o tagliare all’ingrosso!
Ci si è vergognati di molte cose, nell’Italia berlusconiana. Ma assai più rivelatrici sono le cose di cui non ci si è vergognati più. In questi anni, non ci si è vergognati più dell’ignoranza. Ministri, non solo leghisti, rivendicavano di parlare come ci s’abbuffa all’osteria. “Sono solo parole…”, era la formula di assoluzione per ogni infamia proclamata. Le volgarità diffuse tra gli “eletti” erano esibite come prossimità alla “gente”, complemento di un potere forte, legittimato dalla volontà popolare. C’è un motto diffuso un po’ ovunque nel Mezzogiorno, a tardiva giustificazione di ogni intemperanza: “m’è scattata la ‘gnoranza”, si dice. E forse c’è del compiacimento nella frase ma è frutto della consapevolezza della colpa, dell’errore. La regressione compiaciuta alla brutale semplificazione dei problemi è stato il costume recente di una politica che ha giocato al ribasso con il popolo, coltivando il mimetismo nei disvalori messi in atto senza pudori, confermando e moltiplicando la base morale di un’arretratezza civile. I leghisti si sono solo spinti più degli altri all’estrema deriva, e c’è persino un’ostinata coerenza “antielitista” nella loro furba e isolata opposizione al governo dei professori.
“Il popolo è così”, hanno detto. E bisogna avere una considerazione del popolo assai scarsa o troppo alta di se stessi, spacciando per migliore intelligenza quella che è solo un’ulteriore camuffata ignoranza. Berlusconi nei suoi lati più oscuri, che non sono solo gli affari pruriginosi, era come dicesse: gli italiani sono come me, solo che io sono un po’ più italiano degli altri. Poteva perciò eccellere nel trucco della mimesi. Sono uno di voi! E loro: è “uno di noi”! Come Di Pietro e il suo italiano strapazzato: i congiuntivi sono un lusso da professori, l’antielitismo si accompagna sempre all’antintellettualismo – ricorda Luca Sofri trattando il tema, con occhio all’America di Sarah Palin, nel suo Un grande Paese (BUR, 2011). Ma il cortocircuito demagogico, depurato degli aspetti più volgari, ha attecchito anche a sinistra. In una comunità politica che forse viveva il complesso di un distacco reale dalla “gente” o il rimorso di una lunga mancata consuetudine col “popolo vero”: gli operai che votavano Lega, e così via. Il mito del “radicamento territoriale” è stata la coda ingenua e velenosa di questo senso di colpa: come se la Lega, più che rappresentare legittime ambizioni e aspettative delle comunità locali, non finisse per dar voce grossa soprattutto a paure, egoismi e miserie particolari.
Che gli eletti siano sempre meno gli “eletti”, è problema decisivo delle democrazie. Populismi vecchi e nuovi avanzano non solo nella nostra provincia. E sono questioni che hanno a che fare con la perdita di ruolo e potere reale della politica: se la maggioranza dei deputati spesso si limita a schiacciare un tasto, allora le carriere politiche si prestano a igieniste dentali, segretarie fedeli, figli di senz’altri meriti e nominati con più o meno spettacolare improvvisazione. L’uomo qualunque finalmente si è scoperto deputato o anche vice Ministro. Con l’elemento speciale di degenerazione proprio del costume nazionale, dell’antico vizio italico di “élites” che si formano per vincoli di sangue e affiliazione – familismo di figli nipoti e cognati, e amanti e servitù.
Eppure, nella prima Repubblica, intelligenza e cultura erano ancora un vanto, e nei grandi partiti per un bel po’ primeggiarono i “bravi a scuola” (scuola di partito, certo). Il meccanismo di selezione alla rovescia delle élites si è perfezionato solo con la seconda Repubblica, quando l’ignoranza non è stata più tabù politico.
Nel declino dei “bravi a scuola” è il declino dell’Italia. E ci sono aspetti strutturali: un’economia sempre meno competitiva, con scarso contenuto di innovazione e conoscenza, sottoutilizza o spreca il “capitale umano”, e non solo contribuisce all’impoverimento collettivo ma scoraggia l’investimento formativo. Il declino dei tassi di iscrizione all’università ne è la più preoccupante testimonianza, così come il rischio che a minori aspettative di benessere, per le nuovissime generazioni, si affianchi ora una minore quantità e peggiore qualità di sapere.
È difficile non cogliere un disegno perverso nella devastazione di una scuola pubblica che pure non riusciva a garantire pieno sviluppo delle capacità e promozione dei talenti, in cui il successo formativo è ancora largamente determinato dal retroterra socio-economico e familiare. Essere “bravi a scuola”, investire in sapere e conoscenza, non serviva più in un’Italia a debole economia e pessima burocrazia, dove i concorsi pubblici erano finiti e si affollavano come un tempo le anticamere dei favori e delle raccomandazioni. Altri erano i modelli di affermazione sociale, e i “bravi a scuola” nella vita potevano essere perdenti. Molti tendevano a diventare allora solo “secchioni”, un po’ sfigati e incattiviti, che dal primo banco guardavano gli altri con disprezzo e rancore: e non passavano il compito. Ma agli altri ormai non importava più: nella vita avrebbe vinto “uno di loro”. Non vedi la Ministra?
Questa faccenda del passare i compiti o del non far copiare è cruciale, ma un po’ complicata. A scuola i nuovi comandamenti importati dall’America sono: “non far copiare e denuncia chi copia”. Far copiare si presta all’accusa ingrata di falsare il merito, prediligendo certi beneficiari o subendone il ricatto. Però è l’intenzione e il gesto del “bravo a scuola”, se vuole far copiare, che qui conta: la volontà del migliore di occuparsi di chi è meno bravo. Come studiare insieme il pomeriggio, certo, ma di più. È così che il “bravo a scuola” pronto a passare il compito può acquisire meriti agli occhi del “popolo”. Compreso il merito di essere “eletto”. E forse in questo esempio da Libro Cuore è il succo dell’élitismo di sinistra, già difficile cimento filosofico di Norberto Bobbio. Eppure, una valenza ambigua della faccenda rimane: Berlusconi non dava l’idea di uno che lasciasse copiare? Il suo messaggio di successo, più che “arricchitevi!”, non è stato forse proprio “copiatemi!”? Non importa che la sua fama fosse costruita su molti favori, o che i suoi temi – peraltro venduti a caro prezzo – fossero fasulli. Ha funzionato. Copiatemi, somigliatemi! Ed è più facile somigliare a un peccatore che a un santo, ci ha spiegato Franco Cassano nella sua speciale rilettura della Leggenda del Grande Inquisitore, raccolta ne L’umiltà del male (Laterza, 2011). La sua critica al “narcisismo etico” – vale anche per il “narcisismo intellettuale” – s’è prestata all’entusiasmo strumentale di chi combatte il “puritanesimo” in nome di un potere che sguazza nel torbido. Ma il discorso di Cassano tende non certo alla legittimazione di un Cardinale di Siviglia o di un Cavaliere, ma a che le élites morali e intellettuali non si distacchino troppo dalla condizione umana della maggioranza, dai limiti, interessi minori e miserie della vasta “zona grigia”, finendo con l’esserne ripudiate in favore della rassicurante seduzione dei Grandi Inquisitori “democratici” del nostro tempo, che «ripetono al popolo che ha sempre ragione» e vi si mimetizzano.
Il risvolto politico dell’umiltà del male è un gran monito alla sinistra. Tuttavia, le sue classi dirigenti, forse elitarie, non sono state certo vere élites in questi anni. Così come i professionisti della politica troppo poco sono stati professionisti. E anzi, nell’organizzazione politica del consenso, nella vita partitica, hanno forse finito per somigliare troppo alla società così com’è, con le sue troppe imperfezioni, e non a quella da costruire nelle migliori intenzioni (giocate sempre al ribasso, peraltro). Troppo poco hanno contato merito e impegno, l’essere “bravi a scuola”, prevalendovi cortigianerie e conformismi. O la capacità di improvvisazione, la vuota riuscita comunicativa. Tanto, sono solo parole… Ma “se non sai di che parli, cosa vuoi riformare?”, avrebbe detto Napoleone Colajanni.
Tornasse davvero il tempo dei “bravi a scuola” sarebbe un gran bene per l’Italia post-berlusconiana. Non siano solo “secchioni”, però, solerti nello svolgere il solito compito: gravare su quelli per cui la vita è già grave, per dire. I “bravi a scuola” diventano i migliori, per intelligenza delle cose e forza morale, solo se si sforzano di trovare strade nuove, solo facendosi prossimi ai più deboli: i più fragili, i più imperfetti, persino i più vili e i più opportunisti. La buona politica è passione per la “zona grigia”, per quelli che non si salvano da soli, per i banchi della terza fila. È persino disponibilità generosa a passare i compiti, qualche volta, all’onesto copiare come esempio ed emancipazione. È la sinistra, quella che le lacrime di una professoressa ricordano appena vagamente.