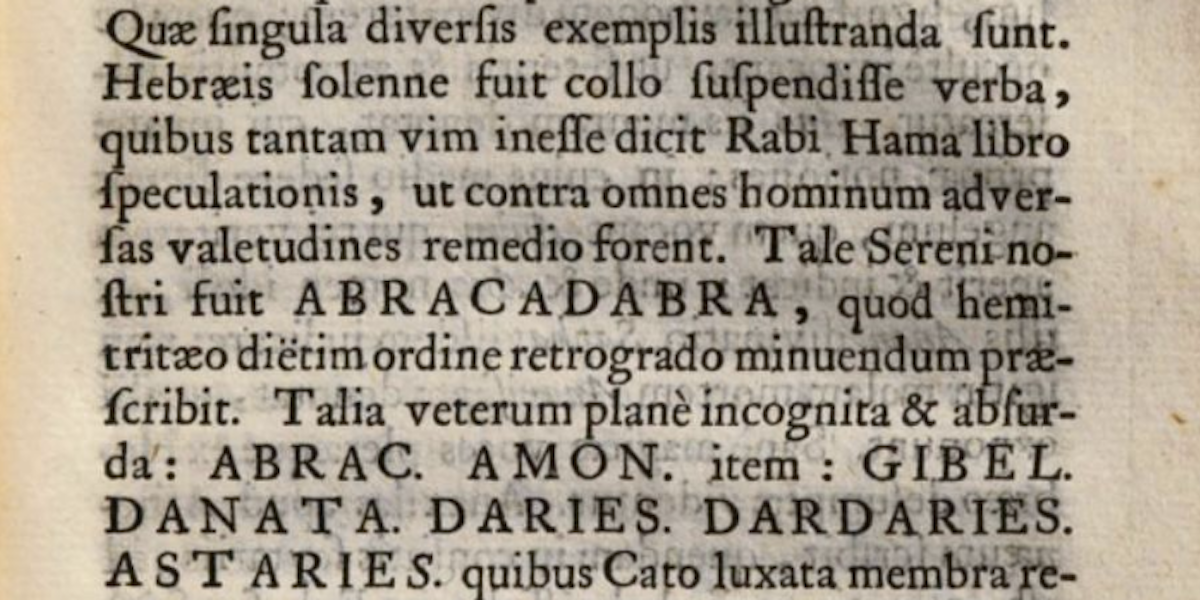Intorno a Bill Viola
Filippomaria Pontani è stato a vedere la mostra del "massimo videoartista vivente" al Grand Palais di Parigi
di Filippomaria Pontani

Il mare è dentro di lui. La scena clou della vita di Bill Viola (New York 1951) è l’annegamento mancato che visse all’età di 7 anni, quando la mano di uno zio tirò su la testa del bambino – recalcitrante – dal mondo dei pesci e dei coralli, come nella prima scena di Mare dentro di Amenábar. Non vi è dubbio che la simbiosi dell’arte di Viola con l’elemento acqua derivi da quell’episodio, e rappresenti il filo rosso di una carriera folgorante che si sdipana dai primi esperimenti degli anni Settanta (da Syracuse a Firenze a New York) fino ai Water Portraits del 2013 (altrimenti noti come i “Sognatori”, attori immersi in una piscina d’acqua in plexiglas). Diverse mostre, da Tokyo a New York, da Roma a Brema, lo hanno consacrato ormai a livello planetario come il massimo videoartista vivente: ma la mostra aperta di recente al Grand Palais è significativa per almeno tre motivi: è la prima mostra di videoarte in quell’augusta sede espositiva; è la più grande personale di Viola mai realizzata (20 video, allestiti peraltro con ammirevole ritmo e sapienza); offre un bilancio preciso, anche se un po’ tendenzioso, di 40 anni di carriera.
Il rilievo della mostra Bill Viola di Parigi, curata da Jérôme Neutres ma concepita e allestita con la diretta partecipazione dell’artista medesimo e dell’inseparabile compagna Kira Perov, risiede principalmente nella caratura e nella rappresentatività del protagonista, che è facile prevedere rimarrà nei libri di storia dell’arte, anche una volta passate le mode del mercato, come uno dei più significativi prodotti della nostra epoca. Va detto che tramite una lettura molto teleologica della propria produzione, Viola rimuove qui quasi del tutto le sue opere più “arcaiche”, quelle legate alla sperimentazione delle immagini e del suono alla scuola del grande Nam June Paik, o al confronto con gli Italiani riuniti a Firenze nel celebre studio Art/Tapes/22 (Vito Acconci, Giulio Paolini, Mario Merz e altri): rimangono di questo primo lotto solo l’affascinante The Reflecting Pool (1979), in cui l’osmosi fra un uomo, la vegetazione e l’acqua di una piscina è sottolineata da delicati giochi di luce e ingannevoli riflessi, e soprattutto Chott El-Djerid (1979), una lunga sequenza girata presso un lago salato del deserto tunisino, dove le sagome dei cammelli e degli uomini, delle rocce e delle dune, le fatemorgane e la caligine, producono immagini gravide di suggestioni cromatiche e di memorie, dai taccuini arabi di Sargent al periodo africano di Klee.
Ma questo mondo di monitor e di immagini sgranate appartiene ormai al passato: al Grand Palais il 70% delle opere risale agli anni Duemila, e attesta la conversione di Viola a una tecnica sempre più raffinata, che prevede immagini ad alta definizione, meccanismi elettronici d’avanguardia (installati per l’occasione da una nutrita compagine di operai tedeschi), e un nitore iconico che da un lato rivaleggia apertamente con la pittura ad olio, dall’altro rispecchia la decisione con cui l’artista vuole affrontare i temi centrali del vivere dell’uomo nel mondo. Emblematico in tal senso l’altissimo pannello del 2005 dal titolo Fire Woman, in cui una donna vista di spalle è il grimaldello per una lenta e sorprendente transizione materiale e cromatica da un magma di fuoco a un oceano d’acqua – un capolavoro sul piano strettamente tecnico oltre che su quello del potere evocativo.
L’obiettivo di Viola è dichiaratamente metafisico: riflettere su origine, percorso e destino dell’uomo, sui misteri della nascita e della morte (a suo parere, un’arte senza mistero non è arte), sui confini tra gli elementi e sulle loro (e nostre) trasformazioni. Il confine con la filosofia New Age è labile, e molte volte indubbiamente valicato; il melting pot di misticismo cristiano, sufismo, buddismo, sfocia in una sorta di religione naturale che può piacere o non piacere; i viaggi in Giappone, i paesaggi infiniti della California e le suggestioni platoniche del Rinascimento italiano convivono in un’idea di spiritualità vaga ma pervasiva, che rifiuta ogni deriva “culta” o pedante in nome della genuinità sovrana dell’autodidatta; le dichiarazioni di poetica risultano talora imbarazzanti nella loro naïveté, soprattutto quando fingono di aggredire il mondo come se fossero prive di passato.
In realtà, risiede altrove il vero fascino delle opere di Viola, e la prova tangibile della sua sincera fede nell’arte e nell’indispensabilità dell’immagine per ogni riflessione sul mondo, in un senso per certi versi riconducibile all’approccio ermeneutico dello storico dell’arte indiano Ananda Coomaraswamy – non a caso il nome più citato dall’artista nella conferenza stampa del 3 marzo al Grand Palais. Il vero fascino di Viola sta nel continuo dialogo con i capolavori del passato, a cominciare da quelli dell’arte cristiana europea. Che un genere così nuovo come la videoarte, e così debitore alle punte più avanzate della tecnologia del ‘900 (la fotografia, il cinema, la televisione) trovi la sua cifra più profonda nel confronto con la pittura di molti secoli addietro, non deve in fondo sorprendere: come rileva Salvatore Settis (Bill Viola: i conti con l’arte, in: Bill Viola: visioni interiori, Firenze 2008, 34-61), si tratta di un’altra tappa (tra le ultime in ordine di tempo, e tra le più alte a livello qualitativo nel panorama degli anni che viviamo) della irresistibile continuità di modelli e ideali dell’arte occidentale, da sempre capace di contaminare e modellare tramite i propri significanti anche i temi e le tecniche d’altre epoche e d’altri mondi, intensificando tanto lo spessore genetico delle creazioni più recenti quanto l’emozione dell’osservatore nell’interpretarle.
Così, Catherine’s Room (2001) – una serie orizzontale di 4 video in apparenza banali, in cui una medesima protagonista compie diverse azioni quotidiane nella medesima stanza – può essere letto come una riflessione new age sull’importanza dei piccoli gesti ripetuti della vita, ma anche come una rivitalizzazione e una drammatizzazione del genere antico della “predella” (non, come recita il catalogo, del “polittico”), cui appartiene sin dalla sua nascita: s’ispira infatti un prototipo di Andrea di Bartolo (Scene della vita di Santa Caterina da Siena) conservato nel Museo del Vetro di Murano.
Ancora, The Quintet of the Astonished (2000) reincarna un gruppo di personaggi dell’Incoronazione di spine di Hieronymus Bosch oggi alla National Gallery, e raffigura sullo schermo l’espressione del loro sgomento analizzando tramite un sapiente ralenti il farsi delle espressioni di ciascuno, dunque quasi scavando da un lato nel retrobottega degli studi del maestro fiammingo, dall’altro nei valori visibili e invisibili delle minime contrazioni dei muscoli dell’homo sapiens sapiens – è stato citato a tal proposito il tessuto delle Pathosformeln di Aby Warburg. In tal senso, forse ancor più commovente è la rilettura della Visitazione di Jacopo Pontormo (The Greeting, 1995), visibile in questi giorni a Firenze nella bella mostra di Palazzo Strozzi dedicata alle Divergenti vie della “maniera”, a pochi metri (ma purtroppo non in diretto confronto face to face) dall’originale del pittore toscano: anche in quel caso, nel reinterpretare al ralenti l’abbraccio tra la Vergine ed Elisabetta alla presenza di un’altra donna (nella tela originaria erano due), Viola destruttura e ricompone i minimi istanti del movimento, e offre memorabili squarci sull’evoluzione dell’animo umano tra la normale conversazione e la sorpresa di un avvento repentino, di una notizia inaspettata, di una gioia che si fatica d’acchito a comprendere e a condividere.
Ma se c’è una ragione per cui la mostra di Parigi (aperta fino al 21 luglio) vale il viaggio, è l’ambiziosissima “camera picta” dal titolo Going Forth by Day (2002), un complesso di 5 enormi video che occupano una sala di 20 metri x 8, e configurano un vero programma iconografico coerente come i cicli d’affreschi del nostro Medioevo, o come (il sincretismo è, di nuovo, un dato fondante) i papiri del Libro dei morti egiziano cui si richiama il titolo generale dell’opera. Il primo video, Fire Birth, propone il timido emergere di una figura umana dal veemente caos primordiale di un’acqua fiammeggiante di lingue di fuoco (si nota qui forse la lezione del nostro Fabrizio Plessi); The Path presenta una infinita teoria di persone (di ogni sesso, razza ed età, dai bebè agli anziani in carrozzella, senza alcun ritmo prestabilito né ordine apparente) che sfilano lungo un percorso obliquo e rettilineo tra gli alberi di un fitto bosco à la Paolo Uccello; The Deluge è il primo piano di una casa signorile e dell’antistante marciapiede, dove scorre per molti minuti la vita quotidiana di una città (gli affari, i traslochi, gli abbracci, la carità ai poveri…) fino al momento in cui si diffonde l’annuncio di una catastrofe, il panico accelera i movimenti e infine la casa (insieme a molti abitanti) viene travolta da un enorme valanga d’acqua (l’opera nasce pochi mesi dopo le Torri Gemelle e tre anni prima di Katrina); The Voyage è un quadro bipartito, sulla sinistra lo spaccato (di tipo giottesco o fiammingo) di una casetta in cui sta morendo un anziano assistito dai familiari (che però sono assenti nel momento decisivo), sulla destra la meticolosa preparazione di una vecchina alla partenza su un’imbarcazione che somiglia a quella di Caronte. Infine, First Light mostra una squadra di soccorritori sulla riva di un lago dopo un’inondazione, assieme a una madre intenta a scrutare l’acqua che ha evidentemente inghiottito suo figlio: una volta che, a notte, le ricerche vengono sospese e tutti si appoggiano alle rocce per dormire, la prima luce dell’alba è squarciata dall’emergere repentino e verticale del giovane scomparso dalle acque, senza che il sonno generale sia interrotto – a mio parere una delle più potenti ed enigmatiche riscritture della Resurrezione di Piero della Francesca a Sansepolcro.
Latore di un’arte che non mira mai alla vis narrativa propria del cinema, Viola ha più volte apertamente escluso di voler compiere il grande passo che ha portato il suo collega Steve McQueen dai video della Biennale d’Arte ai premi dell’Academy e di Cannes: così facendo, egli continuerà a schivare la saccenteria e la confusione di genere che alberga in un Terence Malick, per suggerire un senso nuovo e primordiale a un fare artistico altrimenti sempre più compiaciuto e sempre meno necessario; per rendere a ogni immagine, ai suoi movimenti lenti e polisemici, al suo carico antico di visione, tutto il potere evocativo del simbolo.
(foto: Bill Viola a Tokyo nel 2011, TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images)