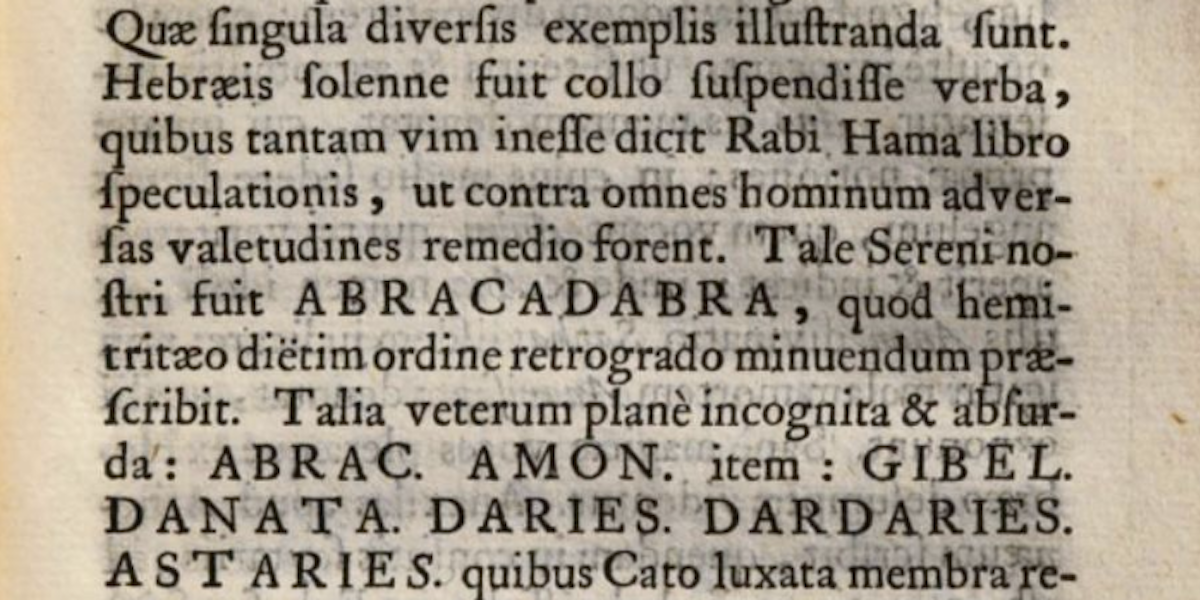Sprecarsi a Livorno
E altre meraviglie e trappole della città, nel nuovo libro di Simone Lenzi
di Simone Lenzi
Laterza ha pubblicato nella sua collana di racconti e guide sulle città italiane affidate a scrittori Sul Lungomai di Livorno, di Simone Lenzi: che cerca di spiegare nel libro illustrato con foto scattate da lui stesso, in cosa consista la “livornesità” attraverso i tre traslochi della sua vita in una città che può essere molto accogliente, ma anche una trappola da cui non si riesce a fuggire, dice. Simone Lenzi è nato a Livorno nel 1968, e nel 2012 ha pubblicato il romanzo La generazione, da cui è stato tratto il film Tutti i santi giorni di Paolo Virzì. In questo estratto dal libro Lenzi racconta i suoi incontri nel recinto per i cani di piazza Magenta.
***
Quando si dice che non fare niente è più faticoso che lavorare. Non è soltanto il gusto del paradosso. Perché vedi gli altri, che fanno, brigano, corrono, e ti pare che la loro vita, a differenza della tua, abbia un senso.
In treno mi è capitato mille volte: senti il vicino che parla al cellulare di lavoro con un collega, di certe beghe da risolvere. Parlano di mail, citano nomi di persone perfettamente note nel loro ambiente, dicono cose tipo ne ho parlato con Barazza o gliel’ho detto a Arconati di quella roba lì della trimestrale di cassa e lo sai che mi ha risposto?
Sono e si sentono parte di una rete di rapporti finalizzati alla realizzazione di qualcosa, hanno una mission e un target. Hanno colleghi con cui devono appianare disguidi, ma, soprattutto, con cui devono regolare rapporti di forza.
Da quando sono uscito dal recinto, mi capita spesso di andare a Milano in treno.
Mi ascolti bene, Manuela… lei deve assolutamente uscire dalla zona di comfort.
Silenzio.
Io la capisco Manuela, mi creda, ma lei non può continuare a cercarmi i clienti nel solito giro, dobbiamo guardare ad altri mercati… Le ripeto, trovi il coraggio ed esca fuori dalla zona di comfort.
Silenzio.
Bene, ne riparliamo in riunione, la saluto.
Ho ascoltato con curiosità e ammirazione centinaia di discorsi come questo, sul Freccia Rossa per Milano. Discorsi di uomini moderni, dinamici, modellati sui manuali di marketing e su un certo cinema hollywoodiano, tecnologicamente evoluti, tutto sommato a loro agio nel presente.
Come il manager sulla cinquantina che parlava con quella che un tempo avremmo chiamato rappresentante o commesso viaggiatore (lo dico al maschile, perché a una donna non c’era neanche da pensarci), ma che adesso aveva sicuramente un biglietto da visita con scritto sales manager. Quella che andava motivata, incentivata, spinta fuori dalla zona di comfort.
E io, sul treno, mi chiedevo se fossi uscito davvero dalla zona di comfort del recinto dei cani, se fosse mai possibile uscirne una volta per tutte. Intanto, però, ero felice di quelle passeggiate là fuori. E come dentro il recinto toglievo il guinzaglio al mio cane per farlo sgambare un po’, forse per me era venuto il momento di togliermi il guinzaglio che mi ero messo da solo e uscire a vedere come era il mondo là fuori. L’unica alternativa possibile sarebbe stata quella di chiudermici per sempre, con catena e lucchetto, buttando la chiave in mare. Finire così per far parte della categoria umana per la quale ho provato da sempre il più doloroso fastidio: gli sprecati.
Ne ho conosciuti a decine di sprecati in questa città. Non che ne manchino nelle altre, certo, ma voglio dire che c’è qualcosa in questa città, una retorica diffusa, diciamo così, che invita allo spreco di sé. Allo scialo d’esistenza. Sprecarsi a Livorno è la cosa più facile del mondo. Tutto ti aiuta a farlo.
Ne ho conosciuti a decine di uomini e donne che avrebbero potuto fare qualcosa di più, e invece a un certo punto si sono fermati, e si sono rinchiusi da soli nel recinto dei cani o nel barrino sotto casa. Qualcosa li ha fermati. Qualcosa che si respira in questa città piena di vento, qualcosa che ti riporta sempre indietro. Perché puoi anche diventare capocannoniere in serie A, ma poi devi tornare qui e farci i conti, e vai tranquillo che resterai fregato. Anzi, ti fregherai da solo, con le tue stesse mani.
È difficile da spiegare.
Uno dovrebbe venire al bar, in piazza, per capire davvero. Sentire come si saluta la gente:
Com’è, bello? Tutto a posto?
Già il modo in cui si pronuncia la doppia elle livornese, che Pier Vittorio Tondelli definì uno scivolo lascivo. Ma che invece è carnalmente indolente, come chi si sdraia al sole. E quel tutto a posto, che non è il tutto bene che si pronuncia ovunque. No, vuol dire piuttosto che se qualcosa fosse fuori posto toccherebbe rimettercela, mentre vogliamo accertarci proprio che non ci sia bisogno di far nulla. Niente cui mettere mano. Niente che valga davvero la pena.
E questo significa anche che se invece hai messo mano a qualcosa, forse non era così indispensabile, e chiunque avrebbe potuto farlo al posto tuo, e meglio di te, se solo avesse voluto. Ma l’hai fatto tu, e quasi ti tocca di giustificarti.
È difficile da spiegare. Anche quel bello, bella, detto a tutti, belli e brutti, che ti mette subito a tuo agio, e che fa piacere, certo, ma non è forse anche un modo di dirti che vai già bene così, che tu non ti dia pena di nulla?
Anche il modo di parlare, che è andato cambiando, impercettibilmente, ma mi si creda sulla parola: vent’anni a occuparmi di canzoni, senza successi eclatanti, lo ammetto, mi saranno pur valsi un po’ di orecchio.
Le ragazze, ad esempio, quel modo di allargare le e in modo che suonino a.
Ciao ballo! Oh, viani ballo!
Quel modo di mangiarsi l’inizio delle parole, come se ogni parola fosse strappata controvoglia al sonno. È difficile da spiegare.
Incontro una conoscente, alla Stazione, qualche giorno fa:
“Ciao bella, come stai?”.
“Bane”.
“E dove te ne vai?”.
“A Franze”.
“Eh?”.
“Fraanze”.
“Dove, scusa?”.
“A Firaaanze”.
“Ah, Firenze, ok, bene, buon viaggio allora!”.
Forse è sempre stato un po’ così, ma sicuramente adesso è così un po’ più di prima. Anno dopo anno, sempre un po’ di più.
Le e sempre più aperte, fino a diventare le a di cui Rimbaud ha scritto che sono
noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles
(nero corsetto villoso delle mosche lucenti
Che ronzano intorno a fetori crudeli)
Versi che mi piace ricordare perché almeno si intuisca come quell’apertura estrema di ogni parola pronunciata in questa città di ampie piazze e cieli chiari nasconda invece, nel riverbero accecante della luce, il suo esatto contrario. Il buio, dove ci si può muovere solo brancolando a piccoli passi di incertezza estrema.
In attesa di trasferirmi sul lungomare, continuo a portare fuori il cane, in giro per la piazza.
Ora, da fuori, posso descrivere il recinto come un quadrilatero di circa cinquanta metri per cinquanta, delimitato da una cancellata verde, con al centro una palma. Sotto la palma, una panchina.
Ci sono stati anche periodi felici là dentro. Ad esempio l’estate del 2009.
La padrona di Luna e il suo fidanzato avevano portato un tavolino di plastica trovato ai cassonetti. Qualcuno aveva aggiunto qualche sedia. La sera ci ritrovavamo a veglia nel recinto. Chi portava un dolce, chi una bottiglia di vino.
Una piccola comunità che si era creata dal nulla.
Stavamo lì fin verso le una di notte, a far giocare i cani e a chiacchierare di questo e quello. Veniva anche il Maggiore, che ci raccontava di quanto sia affascinante tuffarsi con la maschera nel reef corallino, e già che c’era, raccoglieva anche qualche cartaccia. Veniva la padrona di Luna con il fidanzato che ci metteva sempre al corrente di come era andato in bagno la mattina, la padrona di Snoopy con il marito che era un esperto di malattie delle piante e ci aggiornava sullo stato di salute della nostra palma, dopo che ne avevano abbattuta una secolare, altissima, proprio davanti a casa mia, e si temeva l’invasione di un parassita.
The palm at the end of the mind
(La palma alla fine della mente)
È il primo verso di una enigmatica poesia di Wallace Stevens che si intitola Of Mere Being, difficilmente traducibile: mere vale come puro, ma anche come semplice, e mind non è solo mente, perché rappresenta anche lo stato pensante della mente stessa. Per farla breve, comunque, per Stevens alla fine della mente c’è una palma, e questa palma è il puro e semplice essere, dove un uccello dalle piume d’oro canta, senza significato umano, senza umano sentire, una canzone straniera.
Nel tempo che è seguito ho forse udito questo canto levarsi fra le fronde della palma, nel recinto dei cani. Specialmente l’anno dopo, alla fine del sussidio di disoccupazione, alla fine della mente disoccupata.
Più spesso ho visto però i tarponi, cioè le pantegane, che salivano e scendevano su per il tronco, in mezzo a quell’oasi di pace che quando piove si riempie di pozze, e i cani, dispettosamente, ci si rotolano dentro.
Passavamo lì le serate, dicevo. A volte si portavano anche le carte. Fuori, sotto il lampione, A. smerciava con discrezione.
Una volta che due marocchini ubriachi facevano troppo chiasso, A. si era fatto sotto a muso duro, con il cane ringhiante a seguito.
Oh ma dove credete di esse’ eh! No voglio casini! Fuori da’ coglioni.
E aveva fatto il gesto di alzare il guinzaglio di cuoio in aria, come fosse una frusta.
Quelli si erano messi subito in riga, avevano chiesto scusa, e se ne erano andati.
A. mi aveva poi detto di quanto lo facessero arrabbiare quelli che attaccano briga e fanno baccano dove lui lavora.
Guarda… mi so’ dovuto fermare perché sennò poi faccio cazzate e dopo viene sogno proibito!
Con sogno proibito, espressione che gli avevo sentito usare altre volte, credo intendesse un’azione irreparabile e delittuosa per la quale si è destinati a provare rimorso in forma di incubo ricorrente.
Così le ore trascorrevano tranquille, sotto l’occhio di questi uomini d’ordine.
Ma i cani a volte si mettevano ad abbaiare, per i motivi assurdi per cui abbaiano di solito i cani: uno che passa in bicicletta, una tizia con l’ombrello, un altro cane che li sfida da fuori, cose così. Alcuni abitanti allora telefonarono ai vigili e il recinto venne sgombrato dagli arredi posticci che vi avevamo collocato.
La piazza fu restituita al suo decoro, e noi alle nostre case, a morir di caldo nelle sere afose di luglio.
A. invece rimase. Da quel momento il recinto divenne il suo vero e proprio ufficio. Con l’arrivo dell’inverno prese anche a riscaldarlo con bracieri di fortuna, e arruolò altri due cani. Certi suoi amici poi dipinsero di blu i vetri dei lampioni circostanti, in modo da oscurare l’area. Il Maggiore cominciò a mutare opinione su di lui.
Rimase anche la palma, naturalmente. Anche quella, come tutti gli alberi della piazza, reca appesa sul tronco una placchetta metallica con il numero di identificazione.
Alla fine della mente c’era e c’è ancora la palma numero 3097, così come è stata identificata nell’inventario del patrimonio arboreo comunale.
Di notte, quando intorno è silenzio, chi cammina per i vialetti può sentire distintamente il tintinnare delle placchette che sbattono sulle cortecce. Come se il libeccio, passando, elencasse gli alberi chiamandoli all’appello, e questi rispondessero bisbigliando la loro paziente presenza.
È difficile dire esattamente cosa ci trattenga nel recinto. O cosa, una volta che ne siamo usciti, ci faccia provare nostalgia per quel luogo.
Sia che i nostri desideri siano chimere o progetti ragionevoli, che siano sogni condivisibili o sogni proibiti che torneranno a toglierci il sonno, è difficile dire cosa sia mai questa indolenza che ci invita a non realizzare mai niente, a lasciar perdere.
Cosa ci spinge allo scialo, allo spreco di tutto anche se abbiamo poco. Qualcosa che forse accomuna tutte le città di mare, ma che pure ciascuna declina a modo suo.
Come quando Virzì ci racconta di quell’ovosodo che rimane in gola e non va né su né giù. Un groppo. Una voglia di piangere di nascosto e senza lacrime. Ecco, una voglia di piangersi dentro che non ha sfogo. Una rabbia disarmata per cui alla fine ti viene da ridere. E così ridiamo sempre di tutto.
Te ne accorgi quando ci sei, e perdi continuamente il filo di quello che vorresti fosse il tuo futuro, ma lo senti ancora più forte quando ti allontani e gli occhi degli altri ti riportano a considerare il punto da cui sei partito, che per me è questa palma alla fine della mente.
Come quando vai a Milano e trovi l’ennesimo qualcuno (più spesso una donna) che ti dice Ah ma sei toscano! Che simpatico… dimmi un po’ qualcosa…, e si aspetta la hoha hola hon la hannuccia etc. E tu vorresti rispondere che si sbaglia, che non sei toscano in quel senso lì, ammesso che poi sia giusto quel senso lì che pensano loro. Vorresti dirgli che intanto i toscani non sono tutti simpatici, che pensassero al mostro di Firenze, ad esempio, o alle peggiori squadracce fasciste che venivano da queste terre, o anche alle efferatezze dei briganti maremmani o ai torbidi romanzi di Tozzi, tanto per dire le prime cose che mi vengono in mente, e che, comunque, tu non sei mica Pieraccioni, e non c’entri nulla con i filari di cipressi, l’olio bono, i saggi e simpatici vecchietti che giocano a carte in paese. No. Tu sei di Livorno, che è un’altra cosa, magari peggiore, ma diversa. E siccome sei livornese non dici la hoha hola hon la hannuccia, perché da noi non aspiriamo la c. Non ce l’abbiamo la cosiddetta gorgia fiorentina, mi dispiace. Da noi la c la tagliamo proprio, di netto. Senza aspirazioni. Ecco, siamo gente senza aspirazioni, mettiamola così.
È difficile dire esattamente cosa sia questa cosa che ci trattiene dall’averne e ci rinchiude nel recinto dei cani, per il quale vale in fondo lo stesso principio di indeterminazione che vale per tante altre cose. Che se ci stai dentro non puoi parlarne, perché ne fai parte e il tuo esserci lo modifica. Ma se ne esci, come fai a descriverlo?