Le colpe dei padri
Il primo capitolo del romanzo di Alessandro Perissinotto, che racconta la storia di un ingegnere di successo di Torino che un giorno viene scambiato per qualcun altro
di Alessandro Sabbatini - Caffeina
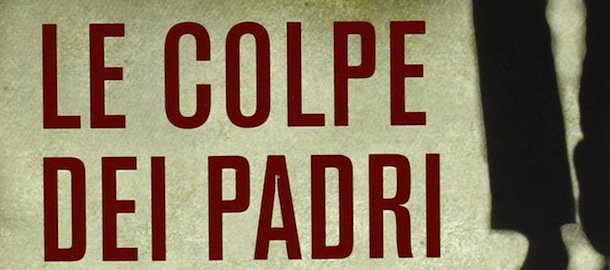
Tutto nella vita del quarantaseienne torinese Guido Marchisio sembra procedere per il meglio. È un cinico ingegnere che ha fatto carriera, vive in una casa prestigiosa in piazza Castello, a Torino, con una compagna bellissima e molto più giovane di lui. È il classico uomo arrivato, con la strada davanti tutta in discesa. Poi si sa come è la vita. Talvolta dietro l’angolo l’ombra di un dubbio crea una frattura incolmabile tra prima e dopo, togliendo prepotentemente alla vita ogni certezza. Così accade all’ingegnere Guido, che è travolto dall’ossessione di un suo doppio. Cade nello smarrimento e sembra andare inesorabile alla deriva, assieme alla sua industria. Tra risvolti privati ed eventi pubblici, la sua vicenda si snoda verso un finale a sorpresa.
Le colpe dei padri è il nuovo romanzo di Alessandro Perissinotto, pubblicato ad aprile dalla casa editrice Piemme. La storia che racconta è un riflesso storico-sociale di un contesto di crisi e del senso di perdita e spaesamento, e fa riflettere su ciò che siamo e non siamo, e su ciò che avremmo potuto essere. Il libro è tra i dodici finalisti del Premio Strega e, in occasione della rinnovata collaborazione tra il Premio e il Festival Caffeina Cultura, ne pubblichiamo il primo capitolo.
***
Ci vorrebbero le Brigate Rosse
Questa storia inizia con un pugno in faccia e finisce con un colpo di pistola, o viceversa, a seconda dell’ordine che vogliamo dare alle cose, perché l’ordine è solo una convenzione e il tempo, che sembra allineare gli eventi lungo sequenze immutabili, talvolta si ritorce su se stesso come legno di vite. In ogni caso c’è un pugno, ben assestato, ma alla persona sbagliata. E c’è un colpo di pistola, sparato verso la persona giusta, ammesso che esista qualcuno che davvero si merita un proiettile.
Siamo seduti in un bar, Franco e io. È un bar alla moda, di quelli che non ci piacciono. Però è comodo incontrarsi in piazza Vittorio e lì i caffè sono tutti alla moda. Per fortuna non è ora di aperitivi e di fighetti: i clienti sono eccezioni. Una coppia di amanti clandestini si è chiusa in una bolla in fondo alla sala e, al banco, un uomo, di cui vedo solo la schiena, di tanto in tanto porge in avanti il bicchiere per farselo riempire di vino bianco.
Ogni volta, io e Franco ci diciamo che dovremmo capire se la vecchia “Fogna” esiste ancora, ma poi non lo facciamo, per pigrizia o per malafede. La “Fogna” è la bettola dove ci trovavamo da ragazzi, il sabato sera; un locale lungo e stretto che, oltre il bancone, ospitava tre tavolini, rotondi, pubblicitari: Caffè Paulista. Niente birra alla spina, solo bottiglie grandi di Peroni. Uno dei tre tavolini era il nostro, mio, di Franco e di Roberto. Uno era riservato ai calabresi, quattro vecchi di quarantacinque anni, in servizio permanente continuo nel bar: carte, sigarette e frequenti raffiche di Dio fa’, la bestemmia che gli immigrati dal sud imparavano a infilare ogni quattro parole per mostrare ai torinesi la loro ferma intenzione di integrarsi. Dio fa’, variante troncata di Dio fauss, dio falso e bugiardo. Bestemmia da officina, da pezzo che cade dal tornio, bestemmia che marca l’arrivo dell’addetto ai “tempi e metodi”, col suo cronometro. Bestemmia da fonderia, da colata di ghisa che acceca all’improvviso; bestemmia da lavoro, abusivamente esportata al bar, per accompagnare una primiera mancata o un rigore negato alla giuventus.
Il terzo tavolo era vuoto, sempre.
Ogni volta diciamo che torniamo là, dove si erano consumate le nostre utopie adolescenti, sotto lo sguardo dei calabresi. Ma poi, ogni volta, preferiamo piazza Vittorio e il decoro spudoratamente vintage della Drogheria. Ogni volta significa poi una volta l’anno: è quella la frequenza con cui io e Franco ci vediamo. E la sera, rientrando a casa, diciamo alle nostre mogli che l’incontro è stato bellissimo, che abbiamo ripreso il discorso da dove l’avevamo lasciato l’anno prima, come se i trecentosessantacinque giorni in mezzo fossero stati congelati in una breve parentesi; ma non è vero, semplicemente ci piace crederlo. Roberto invece è desaparecido; ultimo domicilio conosciuto: Bonn. Persino Facebook si sottrae al compito di ritrovarlo. E poco ci importa.
Siamo seduti al bar dunque, io e Franco. E parliamo, e davvero lo facciamo come se il tempo non fosse passato, come se credessimo ancora nella parola che cambia il mondo.
«La gente è esasperata: prima o poi qualcuno riprende a sparare.»
«Non credo,» faccio io «la lezione degli anni ’70 l’abbiamo imparata.»
Lui insiste.
«Io sento dire da tutte le parti: “Ci vorrebbero le Brigate Rosse”.»
Il barista ci guarda, con l’aria di chi non ama che si facciano certi discorsi. L’uomo al banco ne approfitta per afferrare la bottiglia di prosecco e servirsi da solo.
«Non ho nessuna nostalgia per quel periodo.»
«Non ti piacerebbe che qualcuno infilasse una pallottola in mezzo agli occhi a qualche ministro? O magari a qualche giornalista, a quelli più spudorati, a quelli più venduti, quelli che hanno abbastanza faccia da culo per dire che è la sinistra che controlla i mezzi di informazione.»
Prima di rispondere mi prendo un attimo per pensare a tutte le volte che, di fronte alla televisione, mi è venuto il voltastomaco. Un attimo, per pensare alla sofferenza vera che abbiamo sentito tutti noi, schiavi ma non servi. E in quell’attimo mi rendo conto di aver provato il desiderio di ucciderli, loro e i potenti a cui baciano la mano. Ma non riesco a dirlo. Non ho il coraggio per ammettere di aver contemplato l’omicidio politico come igiene del nostro paese. Quindi mi rifugio nella banalità assoluta: «La violenza non è mai una soluzione».
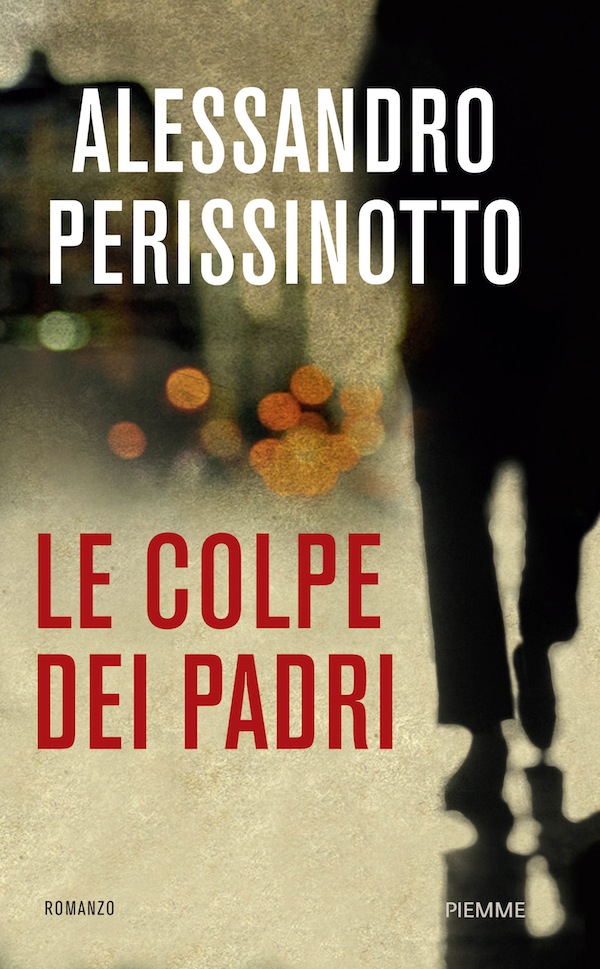 Franco capisce che sto mentendo in malo modo e mi incalza: «Te lo ricordi il rapimento Dozier vero? Non dire che non stavi dalla parte delle Brigate Rosse perché non ti credo».
Franco capisce che sto mentendo in malo modo e mi incalza: «Te lo ricordi il rapimento Dozier vero? Non dire che non stavi dalla parte delle Brigate Rosse perché non ti credo».
Ha ragione. Se almeno una volta nella tua vita avevi manifestato per la libertà in Cile o contro l’apertura di nuove basi NATO, in quell’occasione non potevi che essere dalla parte delle Brigate Rosse. No, non lo dicevi apertamente, ma a scuola, negli intervalli o durante le ore di officina, dove parlare col compagno era l’unica strategia di salvezza, il sequestro Dozier assumeva contorni epici. Era Robin Hood contro lo sceriffo di Nottingham, era Davide contro Golia. Un generale americano! Era la scelta della vittima che faceva amare il carnefice.
«Sì, un comandante NATO in mano ai brigatisti era un godimento.»
«Era come il Toro che batte il Real Madrid, nel ’92.»
Gli sorrido: mi piace il paragone. Lui torna alla carica: «Allora facciamo un po’ di tifo per la P38?».
E con la mano abbozza un gesto che la mia generazione conosce, quello con il pollice, l’indice e il medio a imitare una pistola.
È a quel punto che l’uomo al banco si alza dallo sgabello, è di poco più vecchio di noi. Osservo il suo incedere traballante e immagino che debba andare in bagno. Invece fa due passi e si ferma, davanti al nostro tavolo, lo sguardo appannato. E, tutto a un tratto, il suo muoversi lento, da pachiderma stanco e disorientato, si trasforma in un guizzo. È col sinistro che colpisce il mento di Franco. Non so se sia mancino, ma il colpo è fiacco, spento; Franco non avrebbe difficoltà a restituirglielo, con più forza, ma rimane lì, inebetito, a prendersi, dopo il pugno, l’invettiva dell’altro: «Non bestemmiare» gli urla sfidandolo con gli occhi. «Con la P38, le Brigate Rosse hanno ucciso un mio compagno di scuola. E anche un altro, uno che abitava vicino a casa mia, alla Falchera, un amico di mio padre…»
La voce, impastata fin dalle prime parole, si spegne e l’uomo esce dal bar. Il barista ci guarda di nuovo, un po’ come a dire che ce la siamo cercata e un po’ per verificare che la cosa sia finita lì, che a Franco non venga in mente di inseguirlo o di aspettarlo per spaccargli la faccia: non voglio rogne nel mio locale.
Ma Franco è più avvilito che arrabbiato. Il cazzotto lo ha appena solleticato, ma le parole sono andate più in profondità e hanno riportato alla luce un’immagine che noi, che ci avviciniamo alla cinquantina, abbiamo sepolto nell’animo nel 1979, quando vivere in questa città faceva paura, quando niente ti metteva al riparo dall’eventualità di essere la prossima vittima. È l’immagine di un ragazzo di diciotto anni che, per caso, si trova in mezzo a una sparatoria: si butta a terra, dietro un’auto, ma questo gesto non basta a salvargli la vita. Non è una scena che abbiamo visto, ce l’hanno raccontata, e proprio per questo ci è parsa ancora più drammatica. Ci hanno detto che, vedendo il ragazzo scomparire dietro la macchina parcheggiata, il brigatista si è chinato e ha fatto partire una raffica all’altezza del suolo, per uccidere. Ancora oggi non so se davvero sia andata così o se Emanuele sia stato colpito da un proiettile vagante quando era ancora in piedi, ma poco importa. Di certo so che non è stato un brigatista a sparare, ma uno di Prima Linea.
«Secondo te,» mi chiede Franco «quello lì era compagno di Emanuele Iurilli?»
Annuisco, in silenzio, e lui abbassa lo sguardo: si vergogna di aver inneggiato al terrorismo.
Franco era accanto a me il 9 marzo del 1979, nell’officina di aggiustaggio dell’istituto tecnico che entrambi frequentavamo per alimentare il sogno familiare di avere un figlio alla Fiat. La notizia della morte di un ragazzo che stava rincasando da un altro istituto tecnico ci aveva ammutoliti e il chiacchiericcio, che di solito accompagnava lo stridere della lima su un pezzo serrato nella morsa, era cessato di colpo rendendo ancora più lugubre l’officina.
«E l’altro? Quello della Falchera?»
«Credo si riferisse a Carmine Civitate. È stato ucciso da Marco Donat-Cattin e da un altro, ma si è trattato di uno scambio di persona: volevano ammazzare un certo Villari che secondo loro era responsabile della morte di due compagni. Ma anche Villari non c’entrava niente.»
«Com’è che sai tutte queste cose?»
«È perché hanno a che vedere con la storia di Guido Marchisio, uno che ho intervistato qualche mese fa. Mi sembrava una vicenda interessante la sua, ma il giornale non me l’ha pubblicata.»
«Marchisio quello della Moosbrugger?» «Lo conosci?»
«Sì, perché era amico di…»
In fondo ci conosciamo tutti, perché siamo nati a Torino e a Torino i gradi di separazione sono sempre meno di sei, perché siamo cresciuti tutti sotto l’occhio vigile della stessa matrigna, quella che una volta dettava il ritmo del nostro lavoro, del nostro riposo, che definiva l’orizzonte dei nostri sogni e che oggi, invecchiata e indebolita, è come quelle donne, un tempo bellissime, che del loro passato di creature magnifiche e crudeli, non hanno saputo conservare che la spietatezza.
Pubblicato in accordo con Grandi & Associati, Milano



